Incipit nuovi libri (2000 - 2009)
In questa pagina vengono proposti gli incipit di libri editi tra il 2000 e il 2009, best sellers e romanzi scelti tra quelli di maggior successo.
ISABEL ALLENDE - Ritratto in seppia (2000)
JOHN GRISHAM - Fuga dal Natale (2001)
Nicolò Ammaniti - Io non ho paura (2001)
ANDREA CAMILLERI - L'odore della notte (2001)
CARLOS LUIS ZAFON - L'ombra del vento (2001)
JAMES PATTERSON - Il diario di Suzanne (2001)
BANANA YOSHIMOTO - Arcobaleno (2002)
Nicholas Sparks - Come un uragano (2002)
MURAKAMI HARUKI - Kafka sulla spiaggia (2002)
SERGIO BAMBAREN - Il vento dell'oceano (2002)
JAMES PATTERSON & ANDREW GROSS - Il giullare (The Jester, 2003)
DAN BROWN - Il codice da Vinci (2003)
KHALED HOSSEINI - Il cacciatore di aquiloni (2004)
BANANA YOSHIMOTO - Il corpo sa tutto (2004)
STIEG LARSSON - Uomini che odiano le donne (2005)
PHILIPPA GREGORY - L'altra donna del re (2005)
PHILIPPA GREGORY - Caterina, la prima moglie (2005)
MICHAEL BENOIT - Il tredicesimo apostolo
MURIEL BARBERY - L'eleganza del riccio (2006)
Isabel Allende - Inés dell'anima mia (2006)
THOMAS HARRIS - Hannibal Lecter . L'origine del male (2006)
KHALED HOSSEINI - Mille splendidi soli (2007)
Ildefonso Falcones - La cattedrale del mare (2006)
GIULIA CARCASI - Io sono di legno (2007)
DIANE SETTERFIELD - La tredicesima storia (2007)
DANIEL PENNAC - Diario di scuola (2007)
NICHOLAS SPARKS - Ho cercato il tuo nome (2009)
GIORGIO FALETTI - Io sono Dio (2009)
ISABEL ALLENDE - Ritratto in seppia (2000)

PRIMA PARTE
18621880
Sono venuta al mondo un martedì d'autunno dei 1880, nella dimora dei miei nonni materni, a San Francisco. Mentre all'interno di quella labirintica casa di legno mia madre, grondante di sudore,
ansimava per aprirmi un varco, il cuore intrepido e le ossa disperate, nella strada ribolliva la vita selvaggia del quartiere cinese con il suo aroma indelebile di cucina esotica, il suo
chiassoso torrente di dialetti sbraitati, la sua inestinguibile folla di api umane in un frettoloso andirivieni. Nacqui di buon mattino, ma a Chinatown gli orologi non si attengono ad alcuna
regola e a quell'ora prende vita il mercato, il traffico di carretti e i latrati tristi dei cani nelle loro gabbie, in attesa del coltello del cuoco. Solo parecchio tempo dopo sono venuta a
conoscenza dei particolari della mia nascita, ma sarebbe stato ancora peggio non averli mai appresi; si sarebbero potuti smarrire per sempre negli impervi sentieri dell'oblio. Nella mia famiglia
i segreti sono talmente tanti che probabilmente non avrò tempo sufficiente per svelarli tutti: la verità è fugace e viene lavata via da torrenti di pioggia. I miei nonni materni mi accolsero con
commozione - benché, stando a diversi testimoni, fossi una neonata orribile - e mi adagiarono sul petto di mia madre, dove rimasi raggomitolata per alcuni minuti, gli unici che ebbi la
possibilità di trascorrere con lei. Poi mio zio Lucky mi alitò sul viso per trasmettermi la sua buona sorte. L'intenzione era generosa e il metodo si è rivelato infallibile, dato che almeno in
questi primi trent'anni di vita mi è andata bene. Ma, attenzione, non devo anticipare troppe cose. Questa storia è lunga e ha inizio ben prima della mia nascita; per raccontarla ci vuole pazienza
e ce ne vuole ancora di più per ascoltarla. Se durante la strada perdessi il filo, non c'è bisogno che ti disperi, perché con tutta certezza lo ritroverai qualche pagina dopo. E siccome bisogna
pur cominciare con una qualche data, fissiamola nel 1862 e diciamo allora, tanto per dare l'avvio, che la storia ha inizio con un mobile dalle proporzioni inverosimili.
Il letto di Paulina del Valle fu commissionato a Firenze, un anno dopo l'incoronazione di Vittorio Emanuele II, quando nel novello Regno d'Italia vibrava ancora l'eco delle pallottole di
Garibaldi; smontato, fece la traversata per mare a bordo di una nave genovese, sbarcò a New York nel bel mezzo di uno sciopero sanguinoso e proseguì poi trasportato su uno dei vapori della
compagnia di navigazione dei miei nonni paterni, i Rodrìguez de Santa Cruz, cileni residenti negli Stati Uniti. Toccò al capitano John Sommers ricevere le casse contrassegnate in italiano con una
sola parola: naiadi.
David Grossman - Qualcuno con cui correre (2000)

JOHN GRISHAM - Fuga dal Natale (2001)
L'uscita era affollata di viaggiatori stanchi, per lo più in piedi e accalcati lungo le pareti perché da tempo, ormai, gli scarsi sedili di plastica erano stati occupati. Almeno un'ottantina di passeggeri arrivavano e partivano su ogni aereo, eppure c'era da sedere solo per poche decine.
Sembravano mille le persone in attesa del volo delle diciannove per Miami. Erano infagottati e carichi, e dopo essersi districati nel traffico, al check-in e nell'assembramento dell'atrio apparivano tutti un po' spenti. Era il martedì prima del Ringraziamento, il giorno più caotico dell'anno per i viaggi in aereo e, mentre sgomitavano e venivano compressi in un nodo ancora più stretto a ridosso dell'uscita, molti si chiedevano, non per la prima volta, perché mai avessero scelto quella data per volare.
Le ragioni erano svariate e in quel momento irrilevanti. Qualcuno cercava di sorridere. Qualcuno cercava di leggere, ma in quella ressa e in quel baccano non era facile. Altri guardavano il pavimento e aspettavano. Poco distante, uno smilzo Babbo Natale dalla pelle nera suonava un'irritante campanella dispensando auguri per le feste.
La famigliola che arrivò in quel momento, vista la moltitudine di gente davanti all'uscita a cui era stata indirizzata, si fermò ad attendere qualche passo più indietro. La ragazza era giovane e molto graziosa. Si chiamava Blair ed era chiaramente in partenza. I suoi genitori no. Tutti e tre osservarono la folla e anche loro, in quel momento, si domandarono in silenzio perché avessero scelto quel giorno per viaggiare.
I pianti erano finiti, anche se non proprio per tutti. Blair aveva ventitré anni, fresca di laurea, con un buon curriculum ma non ancora pronta per iniziare una carriera. Una sua compagna di università era in Africa con i Peace Corps e questo aveva ispirato a Blair l'idea di dedicare i prossimi due anni ad aiutare i bisognosi. Era stata assegnata a una sperduta zona orientale del Perù, dove avrebbe insegnato a leggere ai bambini piccoli. Avrebbe alloggiato in una capanna senza acqua corrente, senza elettricità, senza telefono, ed era ansiosa di cominciare il suo viaggio.
L'aereo l'avrebbe portata a Miami e da lì a Lima, dove, dopo tre giorni di corriera su per le montagne, sarebbe entrata in un altro secolo.
Nicolò Ammaniti - Io non ho paura (2001)

Stavo per superare Salvatore quando ho sentito mia sorella che urlava. Mi sono girato e l'ho vista sparire inghiottita dal grano che copriva la collina.
Non dovevo portarmela dietro, mamma me l'avrebbe fatta pagare cara.
Mi sono fermato. Ero sudato. Ho preso fiato e l'ho chiamata. — Maria? Maria?
Mi ha risposto una vocina sofferente. — Michele!
— Ti sei fatta male?
— Sì, vieni.
— Dove ti sei fatta male?
— Alla gamba.
Faceva finta, era stanca. Vado avanti, mi sono detto.
E se si era fatta male davvero? Dov'erano gli altri?
Vedevo le loro scie nel grano. Salivano piano, in file parallele, come le dita di una mano, verso la cima della collina, lasciandosi dietro una coda di steli abbattuti.
Quell'anno il grano era alto. A fine primavera aveva piovuto tanto, e a metà giugno le piante erano più rigogliose che mai. Crescevano fitte, cariche di spighe, pronte per essere raccolte.
Ogni cosa era coperta di grano. Le colline, basse, si susseguivano come onde di un oceano dorato. Fino in fondo all'orizzonte grano, cielo, grilli, sole e caldo.
Non avevo idea di quanto faceva caldo, uno a nove anni, di gradi centigradi se ne intende poco, ma sapevo
che non era normale.
Quella maledetta estate del 1978 è rimasta famosa come una delle più calde del secolo. Il calore entrava nelle pietre, sbriciolava la terra, bruciava le piante e uccideva le bestie, infuocava le
case. Quando prendevi i pomodori nell'orto, erano senza succo e le zucchine piccole e dure. Il sole ti levava il respiro, la forza, la voglia di giocare, tutto. E la notte si schiattava
uguale.
Ad Acqua Traverse gli adulti non uscivano di casa prima delle sei di sera. Si tappavano dentro, con le persiane chiuse. Solo noi ci avventuravamo nella campagna rovente e abbandonata.
Mia sorella Maria aveva cinque anni e mi seguiva con l'ostinazione di un bastardino tirato fuori da un canile.
«Voglio fare quello che fai tu», diceva sempre.
Mamma le dava ragione.
«Sei o non sei il fratello maggiore?» E non c'erano santi, mi toccava portarmela dietro. Nessuno si era fermato ad aiutarla. Normale, era una gara.
— Dritti, su per la collina, niente curve. È vietato stare uno dietro l'altro. E vietato fermarsi. Chi arriva ultimo paga penitenza —. Aveva deciso il Teschio e mi aveva concesso: — Va bene, tua
sorella non gareggia. E' troppo piccola.
— Non sono troppo piccola! — aveva protestato Maria. — Voglio fare anch'io la gara! — E poi era caduta.
Peccato, ero terzo.
ANDREA CAMILLERI - L'odore della notte (2001)
Uno.
La persiana della finestra spalancata sbattì tanto forte contro il muro che parse una pistolettata e Montalbano, che in quel priciso momento si stava sognando d'essiri impegnato in un conflitto a
fuoco, s'arrisbigliò di colpo sudatizzo e, 'nzemmula, agghiazzato dal friddo.
Si susì santiando e corse a chiudere. Tirava una tramontana accussì gelida e determinata che, invece di ravvivare i colori della matinata, come sempre aveva fatto, stavolta se li portava via
cancellandoli a metà e lasciandone le sinopie, o meglio, tracce splàpite come quelle di un acquerello dipinto da un dilettante in libera uscita domenicale. Evidentemente l'estate, che già da
qualche giorno era trasuta in agonia, aveva addeciso durante la nottata di rendersi definitivamente defunta per lasciare posto alla stagione che veniva appresso e che avrebbe dovuto essere
l'autunno. Avrebbe dovuto, perché in realtà, da come s'annunziava, questo autunno pareva già essere inverno e inverno profunno.
Rimettendosi corcato, Montalbano si concesse un'elegia alle scomparse mezze stagioni. Dove erano andate a finire? Travolte anch'esse dal ritmo sempre più veloce dell'esistenza dell'omo, si erano
macari loro adeguate:
avevano capito di rappresentare una pausa ed erano scomparse, perché oggi come oggi nisciuna pausa può essere concessa in questa sempre più delirante corsa che si nutre di verbi all'infinito:
nascere, mangiare, studiare, scopare, produrre, zappingare, accattare, vendere, cacare e morire. Verbi all'infinito però dalla durata di un nanosecondo, un vìdiri e svìdiri. Ma non c'era stato un
tempo nel quale esistevano altri verbi? Pensare, meditare, ascoltare e, perché no?, bighellonare, sonnecchiare, divagare? Quasi con le lagrime agli occhi, Montalbano s'arricordò degli abiti di
mezza stagione e dello spolverino di suo padre. E questo gli fece macari venire in testa che, per andare in ufficio, avrebbe dovuto mettersi un vistito d'inverno. Si fece forza, si susì e raprì
l'anta dell'arrnuar dove c'era la roba pesante.
Il feto di un quintale o quasi di naftalina l'assugliò alla sprovista. Prima gli mancò il sciato, poi gli occhi gli lagrimiarono e quindi principiò a stranutare. Di stranuti ne fece dodici a
fila, col moccaro che gli colava dal naso, la testa intronata e sintendosi sempre più indolenzire la cassa toracica. Si era scordato che la cammarera Adelina da sempre conduceva una sua personale
guerra senza esclusione di colpi contro le tarme, uscendone sempre implacabilmente sconfitta. Il commissario ci arrinunciò. Richiuse l'anta e andò a pigliare un pullover pesante dal settimanile.
Macari qui Adelina aveva usato i gas asfissianti, ma Montalbano stavolta sapeva come stavano le cose e si parò tenendo il sciato. Andò sulla verandina ed espose sul tavolino il pullover per
fargli svaporare all'aria aperta tanticchia di feto. Quando, dopo essersi lavato, sbarbato e vestito, tornò nella verandina per metterselo, il pullover non c'era più.
CARLOS LUIS ZAFON - L'ombra del vento (2001)

Il Cimitero dei Libri Dimenticati
Ricordo ancora il mattino in cui mio padre mi fece conoscere il Cimitero dei Libri Dimenticati. Erano le prime giornate dell'estate del 1945 e noi passeggiavamo per le strade di una Barcellona
prigioniera di un cielo grigiastro e di un sole color rame che inondava di un calore umido la rambla de Santa Mónica.
«Daniel, quello che vedrai oggi non devi raccontarlo a nessuno» disse mio padre. «Neppure al tuo amico Tomás. A nessuno.»
«Neanche alla mamma?» domandai sottovoce.
Mio padre sospirò, offrendomi il sorriso dolente che lo seguiva sempre come un'ombra.
«Ma certo» rispose mesto. «Per lei non abbiamo segreti.»
Subito dopo la guerra civile, il colera si era portato via mia madre. L'avevamo sepolta a Montjuïc, sotto una pioggia battente, il giorno in cui compivo quattro anni. Ricordo che quando chiesi a
mio padre se il cielo piangeva gli mancò la voce. Sei anni dopo, l'assenza di mia madre era ancora un grido muto, un vuoto che nessuna parola poteva colmare. Mio padre e io abitavamo in un
piccolo appartamento di calle Santa Ana, vicino alla piazza della chiesa, sopra la libreria specializzata in edizioni per collezionisti e libri usati che era stata del nonno, un magico bazar che
un giorno sarebbe diventato mio, diceva mio padre. Sono cresciuto tra i libri, in compagnia di amici immaginari che popolavano pagine consunte, con un profumo tutto particolare. Da bambino, prima
di addormentarmi raccontavo a mia madre come era andata la giornata e quello che avevo imparato a scuola. Non potevo udire la sua voce né essere sfiorato dalle sue carezze, ma la luce e il calore
del suo ricordo riscaldavano ogni angolo della casa e io, con l'ingenuità di chi conta ancora gli anni sulle dita delle mani, credevo che se avessi chiuso gli occhi e le avessi parlato, lei mi
avrebbe ascoltato, ovunque si trovasse. A volte mio padre mi sentiva dal soggiorno e piangeva di nascosto.
JAMES PATTERSON - Il diario di Suzanne (2001)
Katie Wilkinson era immersa nell'acqua tiepida nell'insolita ma bellissima vasca da bagno di porcellana antica del suo appartamento newyorkese. La casa aveva un suo modo di evocare un senso di 'antico' e 'logoro' che i devoti allo shabby chic non avrebbero neanche potuto immaginare.
Guinevere, il gatto persiano che assomigliava più a un maglione di lana grigio, era raggomitolato sul bordo del lavandino.
Merlin, il labrador nero, sedeva invéce nel vano della porta che separava il bagno dalla camera da letto.
Tutti e due guardavano Katie come se fossero in pena per lei.
Dopo aver finito di leggere il diario, Katie abbassò il capo e posò il quaderno rilegato in pelle sullo sgabello di legno accanto alla vasca. Rabbrividì.
Poi iniziò a singhiozzare e si accorse che le tremavano le mani. Stava perdendo il controllo, una cosa che non le accadeva spesso. Era una donna forte, lo era sempre stata. Sussurrò una frase che aveva udito una volta nella chiesa di suo padre ad Asheboro, nel North Carolina: «Oh, Signore, oh, Signore, dove sei, Signore mio?»
Non avrebbe mai pensato che quelle pagine potessero turbarla tanto. Naturalmente non era stato soltanto il diario a farla sprofondare in quello stato di abbandono e confusione.
No, non era solo il diario che Suzanne aveva scritto per Nicholas.
Provò a immaginarsi Suzanne. La vide nel suo bel cottage di Beach Road a Martha's Vineyard. Poi fu la volta del piccolo Nicholas. Dodici mesi, e due vivaci occhi azzurri.
E infine, Matt.
Il papà di Nicholas.
Il marito di Suzanne.
E l'ex amante di Katie.
Che cosa provava per Matt, adesso? Sarebbe mai riuscita a perdonarlo? Non ne era certa, ma almeno iniziava a capire cos'era successo. Il diario le aveva rivelato verità che doveva assolutamente conoscere, oltre ad alcuni segreti intimi e dolorosi che forse non avrebbe dovuto sapere.
Sprofondò ancora di più nell'acqua del bagno e si sorprese a ripensare al giorno in cui aveva ricevuto il diario, il 19 luglio. Il ricordo di quella giornata la fece piangere di nuovo.
BANANA YOSHIMOTO - Arcobaleno (2002)
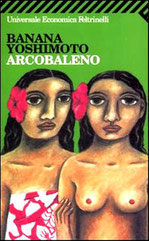
"Al Tour della laguna si può nuotare insieme a tartarughe marine, razze e squali in cattività all'interno di una riserva naturale marina."
Vi avevano preso parte molti turisti provenienti da tutti gli alberghi di Bora Bora; io, però, ero l'unica a parteciparvi da sola.
Per quanto mi guardassi intorno, gli altri erano tutti francesi o italiani riuniti in piccole comitive formate nei rispettivi hotel.
Di giapponesi non ce n'era nemmeno uno.
Non che la cosa mi preoccupasse più di tanto, tuttavia – piccola di statura come sono - stare in coda in mezzo a quella confusione mi faceva sentire un po' fuori luogo.
Dopo essere stati divisi nei vari gruppi, finalmente venne il mio turno.
Insieme a me c'era una famiglia di francesi.
La moglie era incinta, per cui decisero di entrare in acqua soltanto il marito e il figlio di circa dieci anni.
Le dissero in coro qualcosa come "torniamo subito!" oppure "aspettaci, eh!" e scesero verso la spiaggia.
Ah, beati loro! Come li invidio, pensai.
Dopodiché la signora aprì un ombrellino da sole e, sotto i raggi trasparenti, piano piano si sedette a terra facendo attenzione al pancione.
A quella vista riaffiorò il nitido ricordo di quando da piccola correvo lontano dalla mamma, sapendo che qualsiasi cosa mi fosse successa lei sarebbe stata pronta a soccorrermi.
Rivissi con intensità quella sensazione del tutto particolare, immaginando che sotto il suo parasole si nascondesse un viso sorridente.
Quella sensazione divertente, intensa come miele scuro, conosciuta spesso da bambina quando giocavo tranquilla con una concentrazione quasi eccessiva, me la ritrovai in tutto il corpo fino a
provare un leggero senso di oppressione.
Sono davvero molto lontana...
Non che volessi tornare indietro o che la mia vita fosse stata soltanto un avvicendarsi continuo di difficoltà.
Tuttavia, ogni volta che mi giravo e vedevo i piedi candidi spuntare da sotto la gonna lunga di quella mamma sconosciuta con l'ombrellino, insieme a quella scena di ombre che si
proiettavano sulla sabbia bianchissima, mi si stringeva il cuore.
Una volta in mare, nella riserva, a dire la verità sembravamo noi umani a essere in mostra.
I pesci si muovevano tranquilli, del tutto incuranti di noi alieni che invece nuotavamo affannosamente.
Con gli occhi spalancati per la meraviglia, ebbi uno strano pensiero.
Chissà se un gruppo di extraterrestri che si fosse messo a osservare la Terra dallo spazio avrebbe pensato che anche noi, esattamente come quei pesci, siamo esseri meravigliosi che fluttuano
nell'atmosfera.
In quel momento vidi un piccolo squalo color giallo limone spuntare impavido; nuotava in un modo differente dagli altri pesci.
Ah, incredibile! È giallo! E sgranai ulteriormente gli occhi.
Ogni volta che cambiava direzione con la pinna posteriore, controllavo con un certo disagio che non si soffermasse a osservare i miei piedi.
Ricordavo nel dettaglio quelle storie secondo le quali l'olfatto degli squali è superiore a quello degli esseri umani decine di migliaia di volte, e che nel momento in cui attaccano gli
uomini strabuzzano gli occhi.
Anche se è così piccolo, ha un'aura diversa dagli altri pesci.
Fa davvero paura! E per di più è di un giallo da non crederci!
Morivo dalla voglia di dirlo a qualcuno e mi ritrovai a indicarlo con la mia manina decisamente più piccola della norma. Che oltretutto sott'acqua sembrava ancora più piccola.
La coppia di anziani che nuotava al mio fianco mi fece un cenno di assenso. Intuii che anche loro fossero eccitati da quell'incontro.
Erano due francesi simpatici che soggiornavano nel mio stesso albergo e avevamo parlato un po' sulla barca che ci aveva portati lì.
In quel momento, continuando a osservare lo squalo, ci prendemmo istintivamente tutti e tre per mano.
Che le mani di estranei potessero trasmettere tanta felicità, superando la barriera delle nazionalità, dipendeva dal fatto che erano quelle di due persone anziane.
Due grandi mani piene di rughe che avevano abbracciato un'infinità di volte i loro figli e nipoti.
Dopo esserci assicurati che lo squalo fosse tranquillo e per niente intenzionato ad attaccarci, tirammo fuori la testa dall'acqua e ne parlammo un po'.
Poi ci sorridemmo e ognuno andò per la sua strada a inseguire i pesci che preferiva.
Io avrei voluto continuare a osservare quel rarissimo squalo in eterno.
Ma guarda che giallo trasparente! Era davvero di un giallo limone molto acceso.
Esattamente come l'avevo sentito descrivere. Eppure era incredibile che ci fossero esseri viventi di quel colore, che
ci fossero pesci colorati come frutti. Immaginai i miei occhi intenti a fissare i suoi movimenti luccicare come quelli di una ragazza innamorata.
L'acqua del mare, all'inizio pulita e limpida, piano piano divenne torbida per via della sabbia sollevata dai movimenti della gente.
Ed esattamente come in una tempesta di sabbia nel deserto, come nei giorni di forte vento con le nuvole che all'improvviso affollano il cielo, il mondo dei pesci si offuscò come in
un'illusione.
In quel mare che a tratti si intorbidiva per poi tornare limpido, davanti ai miei occhi vedevo pesci dai colori variopinti, agili razze che scivolavano sul fondo marino, mentre in bocca sentivo
un sapore di sale carico di nostalgia.
Il corallo cambiava colore ogni volta che veniva illuminato dai raggi del sole, e sott'acqua tutto brillava leggermente.
Pensai che fosse un sogno, come vedere un arcobaleno.
I sette colori erano tutti presenti in quel mondo.
E sfocandosi, poco alla volta si disperdevano in tremolanti raggi sottili che davano vita a splendidi fiocchi colorati.
Era un mondo silenzioso in cui il tempo pareva essersi fermato.
Nicholas Sparks - Come un uragano (2002)
1.
Adrienne Willis era tornata alla locanda tre anni prima, in una calda mattinata del novembre 1999, e a prima vista l'aveva trovata immutata, come se il piccolo edificio a due piani fosse rimasto
immune dagli effetti del sole e dell'aria salmastra. Il portico era stato tinteggiato di fresco e le lucide persiane nere, ai lati delle finestre rettangolari con le tendine bianche, sembravano
tasti di un pianoforte.
Il rivestimento esterno di tavolette di cedro aveva un colore grigio-argento. Le querce marine sui fianchi della casa ondeggiavano come per darle il benvenuto e la sabbia aveva creato una duna
che cambiava forma impercettibilmente ogni momento sotto la spinta del vento.
Quando il sole, facendo capolino tra le nubi, aveva donato all'aria intorno a lei una particolare luminescenza, Adrienne aveva avuto l'impressione di compiere un viaggio a ritroso nel tempo. Ma,
a uno sguardo più attento, aveva colto cambiamenti che la recente riverniciata non era stata in grado di nascondere: gli angoli delle finestre cominciavano a scrostarsi e c'erano macchie di
umidità intorno alle tubature. Piccoli ma inequivocabili segni di decadenza davanti ai quali aveva chiuso istintivamente gli occhi, quasi per riportare magicamente la locanda all'antico splendore
con un battito di ciglia.
Ora era in piedi nella cucina di casa sua e aveva appena riagganciato il telefono dopo aver parlato con la figlia. Si mise seduta al tavolo per riflettere sulla sua ultima visita alla locanda,
per ricordare quei pochi giorni d'intensa felicità che una volta vi aveva trascorso.
Nonostante tutti gli avvenimenti accaduti da allora, a sessant'anni Adrienne conservava ancora intatta la fiducia nell'amore, che per lei era la vera essenza di una vita piena e
gratificante.
Fuori pioveva. Il rumore delle gocce che battevano sui vetri la confortava. La memoria di quei giorni lontani le suscitava sempre una ridda di emozioni contrastanti, qualcosa di simile alla
nostalgia, ma più complesso. La nostalgia spesso sconfinava nel sentimentalismo; i suoi ricordi, però, erano già abbastanza romantici così com'erano, senza bisogno che l'immaginazione vi
aggiungesse nulla. Li custodiva gelosamente: erano soltanto suoi e nel corso degli anni si erano trasformati in una specie di museo privato, di cui lei era la sola custode e visitatrice. Per
qualche strana ragione, Adrienne era giunta allaconclusione di aver imparato molto di più in quei cinque giorni che in tutti gli anni precedenti e successivi.
Viveva da sola. I figli erano cresciuti, suo padre era morto nel 1996 e il divorzio da suo marito Jack risaliva ormai a diciassette anni prima. Sebbene i ragazzi la esortassero a trovarsi un
nuovo compagno, Adrienne non ne sentiva affatto il desiderio.
Non che avesse smesso di provare attrazione per l'altro sesso; anzi, quando andava al supermercato si sorprendeva spesso a guardare uomini più giovani di lei. Alcuni avevano solo pochi anni più
dei suoi figli... e chissà che cosa avrebbero pensato quei giovanotti, si domandò, se avessero notato le sue occhiate. Avrebbero fatto finta di niente? Oppure le avrebbero rivolto un sorriso,
lusingati dall'interesse che mostrava per loro? A ogni modo dubitava che fossero in grado di vedere, al di là dei capelli grigi e delle rughe, la donna attraente che un tempo era stata.
Comunque, il fatto di invecchiare non la spaventava, rifletté. Non desiderava tornare giovane.
Magari le sarebbe piaciuto avere qualche anno di meno, questo sì, per poter salire di nuovo le scale di corsa, per riuscire a portare più di una borsa della spesa alla volta, oppure avere tutta
l'energia necessaria per stare dietro ai nipoti, ma di certo non avrebbe dato il tesoro di esperienze accumulate con l'età in cambio della giovinezza. Era la consapevolezza di potersi guardare
indietro e sapere di essere rimasta sempre la stessa che le permetteva di addormentarsi serena la sera.
E poi, si disse, la gioventù aveva i suoi problemi.
Se li ricordava per esperienza diretta e aveva visto anche i suoi figli dibattersi nei dilemmi adolescenziali e nell'indecisione dei vent'anni. Sebbene tutti e tre fossero ormai sulla trentina, a
volte si chiedeva quando la maternità avrebbe smesso di essere per lei un impegno.
Matt aveva trentadue anni, Amanda trentuno e Dan ne aveva appena compiuti ventinove, considerò.
Era orgogliosa del fatto che tutti e tre i suoi figli fossero riusciti a portare a termine gli studi.
Erano persone oneste, disponibili e autonome, con quelle qualità che aveva sempre cercato di sviluppare in loro. Matt si occupava di amministrazione in una ditta, Dan faceva il cronista sportivo
per un canale televisivo ed entrambi erano sposati con prole. Quando andavano a trovarla per il Giorno del Ringraziamento, le dava grande soddisfazione sedersi in un angolo a osservarli mentre
badavano affettuosamente ai loro bambini.
Come spesso accade, la situazione era invece un po' più complicata per quanto riguardava sua figlia Amanda.
Jack se n'era andato di casa quando i ragazzi erano ancora adolescenti, pensò, e ognuno di loro aveva affrontato la separazione dei genitori in maniera diversa. Matt e Dan avevano sfogato
l'aggressività sui campi sportivi e con qualche bravata occasionale a scuola, mentre Amanda era diventata chiusa e scostante. Essendo l'unica femmina, in mezzo a due fratelli, era sempre stata la
più sensibile e soffriva molto per l'assenza del padre. Aveva cominciato a mettersi addosso vestiti che sembravano stracci, stava fuori fino a tardi la sera e, nei due anni successivi al
divorzio, era passata da un amore all'altro. Dopo la scuola, trascorreva il pomeriggio in camera sua ad ascoltare musica a volume altissimo, senza rispondere quando la madre la chiamava all'ora
di cena. C'erano stati dei periodi in cui a casa non rivolgeva quasi la parola a nessuno per giorni interi.
C'era voluto qualche anno, rifletté Adrienne, ma alla fine anche Amanda aveva trovato la sua strada, scegliendo un tranquillo modo di vivere che stranamente era molto simile al suo.
All'università aveva conosciuto Brent e, dopo la laurea, si erano sposati e avevano avuto subito due figli. Come per molte giovani coppie, i soldi non bastavano mai, ma Brent era estremamente
accorto, al contrario di Jack. Subito dopo la nascita del primogenito aveva stipulato un'assicurazione sulla vita, solo per precauzione, diceva. Lui e Amanda erano convinti di avere un lungo
futuro insieme.
Si sbagliavano.
Poco dopo essersi ammalato di una forma particolarmente aggressiva di cancro, Brent era morto.
Da allora erano passati otto mesi, e intanto Amanda era caduta in una profonda depressione da cui non si era ancora ripresa. Il giorno prima, quando aveva riaccompagnato a casa i nipotini,
Adrienne aveva trovato le tende delle finestre chiuse, la luce della veranda accesa e sua figlia seduta nella penombra del salotto con indosso la vestaglia e un'espressione vacua sul viso.
Era stato allora, mentre era lì in piedi davanti ad Amanda, che aveva capito che era giunto il momento di raccontarle quello che era successo. Quattordici anni. Tanto era passato.
In tutto quel tempo Adrienne aveva confidato il suo segreto a una persona soltanto, suo padre. Ma lui non c'era più.
Sua madre era morta quando lei aveva trentacinque anni e, nonostante l'affetto che le univa, Adrienne si era sempre sentita più legata al padre.
Era stato uno dei due uomini che l'avevano capita fino in fondo e ancora adesso sentiva molto la sua mancanza. Aveva condotto la vita tipica di molti della sua classe sociale e della sua
generazione: era andato presto a lavorare, invece di proseguire gli studi, e per quarant'anni era rimasto nella stessa fabbrica di mobili dove guadagnava un modesto stipendio. Indossava il
cappello di feltro anche d'estate, si portava dietro il pranzo in una scatoletta di metallo, e tutte le mattine si alzava alle sette meno un quarto per raggiungere a piedi la fabbrica che distava
due chilometri da casa.
La sera, dopo cena, si metteva una comoda camicia di flanella e un cardigan. I calzoni sempre stropicciati gli davano un'aria trasandata, che si era fatta più marcata con il passare degli anni,
soprattutto dopo la morte della moglie. Gli piaceva stare seduto in poltrona, con la lampada dal paralume giallo accesa accanto a lui, a leggere vecchi romanzi e libri sulla seconda guerra
mondiale.
Negli ultimi tempi, prima che fosse colpito dall'ictus, gli occhiali dalla montatura antiquata, le sopracciglia cespugliose e la faccia rugosa lo facevano somigliare più a un professore
universitario in pensione che all'operaio che era stato.
Adrienne aveva sempre ammirato la sua tranquillità d'animo. Era convinta che sarebbe stato un ottimo prete: alle persone che lo incontravano per la prima volta in genere suo padre dava
l'impressione di un uomo in pace con se stesso e con il mondo. Era anche un buon ascoltatore: con il mento posato sulla mano, non distoglieva mai lo sguardo dall'interlocutore, il viso atteggiato
a un'espressione di comprensione e pazienza, pieno di sensibilità. Sarebbe stato la persona ideale per consolare Amanda.
Un mese prima, quando lei aveva tentato con delicatezza di indurla a parlare del suo dolore, sua figlia si era alzata da tavola con una scrollata rabbiosa del capo.
«Guarda che non è come tra te e papà», aveva risposto brusca. «Voi due non riuscivate a risolvere i vostri problemi, perciò avete divorziato. Io invece amavo Brent. Lo amerò sempre. E l'ho
perso.
Tu non puoi capire che cosa si prova in queste situazioni, non ti è mai successo nulla di simile.»
MURAKAMI HARUKI - Kafka sulla spiaggia (2002)

Il ragazzo chiamato Corvo
«E così il denaro sei riuscito a trovarlo?» chiede il ragazzo chiamato Corvo. Il modo di parlare è il solito, un po’ strascicato. Come di uno che si è appena svegliato dopo una lunga dormita e ha
i muscoli della bocca ancora intorpiditi. Ma il suo è solo un atteggiamento: in realtà è perfettamente sveglio. Come sempre.
Io annuisco.
«Quanto?»
Rifaccio un’altra volta il calcolo a mente, quindi rispondo: «Circa quattrocentomila yen in contanti. Poi c’è ancora qualcosa che posso prelevare con la carta. Naturalmente non credo che basti,
ma almeno per ora dovrei farcela.»
«Non è male,» dice il ragazzo chiamato Corvo. «Almeno per ora.»
Io annuisco.
«Però questi soldi non li hai certo ricevuti da Babbo Natale, o sbaglio?» dice.
«No,» rispondo.
Il ragazzo chiamato Corvo si guarda intorno, storcendo leggermente le labbra in una smorfia ironica.
«Non sarà che provengono dal cassetto di qualcuno, qualcuno molto vicino?»
Non rispondo. Lui sa benissimo di chi è quel denaro, è ovvio. Non sta cercando di strapparmi una confessione. Mi sta semplicemente prendendo in giro.
«Beh, pazienza,» dice il ragazzo chiamato Corvo. «Quei soldi ti servono. Ti servono davvero. Devi averli. Qualsiasi mezzo è lecito: chiederli, prenderli in prestito di nascosto, rubarli... In
ogni caso sono soldi di tuo padre. Con quelli, almeno per ora, ce la farai. Ma quando avrai finito quei quattrocentomila yen, come hai intenzione di muoverti? I soldi non crescono spontaneamente
nel portafogli come funghi di montagna. Avrai bisogno di mangiare, e di un posto per dormire. A un certo punto i soldi finiranno.»
«Ci penserò quando sarà il momento,» dico.
«Ci penserò quando sarà il momento,» ripete il ragazzo, come soppesando le mie parole sul palmo della mano.
Io annuisco.
«Vuoi dire che cercherai un lavoro o qualcosa del genere?»
«Forse,» dico.
Il ragazzo chiamato Corvo scuote la testa. «Ma quando imparerai qualcosa sulla vita? Come pensi che un ragazzo di quindici anni, in un posto lontano e sconosciuto, possa trovare un lavoro? Se non
hai neanche finito la scuola! Chi ti darebbe un impiego?»
Arrossisco leggermente. Sono uno che arrossisce subito.
«Mah, lasciamo perdere,» dice il ragazzo chiamato Corvo. «Non è il caso di fare un elenco dei problemi, prima ancora di cominciare. Ormai hai fatto la tua scelta. Adesso si tratta solo di
metterla in pratica. E comunque sia, è la tua vita. Alla fine, sei solo tu a dover decidere.»
Sì, comunque sia, questa è la mia vita.
«Ma d’ora in avanti, se non diventi più tosto non ce la farai.»
«Faccio del mio meglio,» dico.
«Certo,» dice il ragazzo chiamato Corvo. «In questi ultimi anni ti sei rafforzato molto, non si può negare.»
Annuisco.
Il ragazzo chiamato Corvo continua: «Resta però il fatto che hai solo quindici anni. La tua vita è appena cominciata. Il mondo è pieno di cose di cui non sai niente. Cose che tu nemmeno ti
immagini.»

SERGIO BAMBAREN - Il vento dell'oceano (2002)
Capitolo Uno
Sono nato il primo di giugno di un anno che non ricordo più. Almeno questo è quanto scritto nero su bianco nel certificato di nascita messo in mano ai miei genitori il giorno in cui sono venuto al mondo.
Non sapevo che cosa fosse un certificato di nascita fino a quando non compii quattro anni, un'età in cui le faccende che non contano iniziano a sembrare importanti, e si incomincia invece a
dimenticare le cose significative nella vita. Ragion per cui io credo che il mio nome sia del tutto irrilevante in questa storia.
Non ricordo molto dei primi anni della mia esistenza. Mi rammento appena di quando compii un anno e mi vestirono di tutto punto, e una marea di gente che non potevo conoscere si riversò nella
nostra casa. A quanto pareva, nel mondo in cui ero nato certe ricorrenze venivano festeggiate, come in quel caso. Ma come ho già detto, non ricordo granché. Personalmente sentivo che non stavo
celebrando un bel niente. Ero troppo piccolo per capire le leggi che governano i giorni di festa. Attaccato al petto di mia madre e al suo calore, non avevo bisogno di altro. Il linguaggio della
Verità, quella voce interiore di cui siamo dotati noi esseri venti, era solito dirmi che ogni giorno della mia vita doveva essere una magica avventura da non lasciarsi scappare. Tutto qui. Molto
semplice.
Con il passare degli anni, il rituale del compleanno si ripeté di nuovo, esattamente in quell'identico giorno. Sebbene non fossi d'accordo con quello che stava accadendo, non potei far sentire la
mia protesta. Ero troppo giovane. Io ero convinto che ogni giorno fosse da festeggiare e che avremmo dovuto vivere ogni giornata come un evento speciale, perché questo era ciò che il linguaggio
della Verità sussurrava al mio cuore. Ogni nuovo giorno presentava come una nuova avventura, indipendentemente dal fatto che fosse il mio compleanno, Capodanno, Natale oppure un'altra anonima
data. Ognuno era unico e prezioso.
Tuttavia, con mia somma amarezza, ben presto scoprii che il linguaggio della Verità inciampava in molti ostacoli, e che con il crescere si allontana progressivamente dall'esistenza. Apprendiamo
leggi e regole che non c'insegnano niente di essenziale, niente di vitale. A poco a poco il linguaggio della Verità si fa sempre più flebile e presto diventa incapace di comunicare con il
cuore.
Questo tipo di lingua è un dono che abbiamo ricevuto prima di nascere e che ci permette di comunicare con ogni forma di vita: uccelli, balene, foreste, la Luna. Non è un linguaggio parlato. È
spirituale. E si trova dentro a ogni frammento di materia che faccia parte della Creazione. Ci lega a tutto ciò che esiste, e ci colloca in perfetta sintonia con l'Universo.
Per favore, non fraintendetemi. Non sono contro gli anniversari da festeggiare. Grazie a loro uno può vivere in armonia con gli altri e con le persone che ama. Mi riferisco a
quell'incontrollabile desiderio di integrarsi nel gruppo sociale che ci fa perdere molto della nostra unicità, e che quando diventiamo grandi s'impossessa della nostra vita, rendendoci incapaci
di trovare dei momenti preziosi che dovremmo sfruttare per crescere spiritualmente e per assaporare il fremito magico che dà sapore a ogni giorno, quello che mantiene vivo il linguaggio della
Verità.
JAMES PATTERSON & ANDREW GROSS - Il giullare (The Jester, 2003)
PROLOGO
IL RITROVAMENTO
Con un completo di tweed marrone e gli inseparabili occhiali da sole con la montatura di tartaruga, il dottor Alberto Mazzini si fece strada tra la folla di cronisti vocianti e agitati che
affollavano i gradini all'ingresso del Musée d'Histoire di Borée.
«Può dirci qualcosa? È autentico? Lei è qui per questo?» insistette una donna, avvicinandogli al viso un microfono della CNN. «Hanno fatto i test del DNA?»
Il dottor Mazzini era già infastidito. Chi aveva avvisato gli sciacalli della stampa? Non c'erano state conferme a proposito del ritrovamento. Con un gesto secco della mano allontanò giornalisti
e operatori. «Da questa parte, dottore», indicò un usciere del museo. «Prego, entri.»
All'interno lo aspettava una donna minuta dai capelli scuri, con un completo pantaloni nero. Sembrava avere più o meno quarantacinque anni e appariva quasi deferente nei confronti dell'ospite
prestigioso.
«Grazie per essere venuto. Sono Renée Lacaze, la direttrice del museo. Ho cercato di tenere a bada la stampa, ma...» si strinse nelle spalle. «Hanno fiutato il colpo grosso. È come se avessimo
trovato una bomba atomica.»
«Se l'artefatto che avete ritrovato dovesse risultare autentico», replicò deciso Mazzini, «si tratterebbe di qualcosa di molto più importante di una bomba.»
Nella sua veste di direttore dei Musei Vaticani, negli ultimi trent'anni Alberto Mazzini aveva assicurato il peso della sua autorità a ogni importante ritrovamento di carattere religioso. Le
tavolette incise, forse appartenute al discepolo Giovanni, dissotterrate nella Siria occidentale. La prima Bibbia Vericotte. Reperti che ormai riposavano tra i tesori del Vaticano. Mazzini era
stato anche coinvolto in tutte le indagini sui falsi, ed erano centinaia.
Renée Lacaze lo guidò attraverso la sala del quindicesimo secolo decorata con insegne araldiche.
«Mi diceva che la reliquia è stata scoperta in una tomba», disse Mazzini.
«Un centro commerciale...» sorrise Renée Lacaze. «Anche nel centro di Borée le costruzioni procedono senza sosta. Le ruspe hanno ritrovato quella che un tempo era stata una cripta. Se un paio di
sarcofagi non si fossero aperti, non ne avremmo saputo niente.»
La signorina Lacaze guidò l'importante ospite in un minuscolo ascensore che li portò al terzo piano. «La tomba apparteneva a un oscuro duca morto nel 1098. Abbiamo svolto subito le prove
dell'acido e della fotoluminescenza. L'età sembra esatta. Ci siamo subito chiesti perché una reliquia tanto preziosa risalente a mille anni fa, e proveniente dall'altra parte del mondo, dovesse
essere sepolta in una tomba dell'undicesimo secolo.»
«E cosa avete scoperto?» chiese Mazzini.
«Sembra che il nostro duca fosse andato a combattere alla prima Crociata e sappiamo che era alla ricerca di reliquie contemporanee a Cristo.» Arrivarono infine nell'ufficio della donna. «Le
consiglio di prendere fiato. Sta per vedere qualcosa di veramente eccezionale.»
Il reperto era posato su un tavolo da lavoro coperto da un semplice telo bianco, umile come solo un oggetto prezioso può esserlo.
Finalmente Mazzini si tolse gli occhiali da sole. Non gli fu necessario prendere fiato. Era paralizzato. Mio Dio, questa è una bomba!
«Guardi da vicino. C'è un'iscrizione.»
Il direttore dei Musei Vaticani si chinò per osservarla. Sì, poteva essere. Le caratteristiche erano quelle giuste. C'era un'iscrizione. In latino. Socchiuse gli occhi per leggere da vicino.
«Acre, Galilee...» Esaminò il manufatto da cima a fondo. L'età tornava. I segni. Corrispondeva anche alle descrizioni della Bibbia.
DAN BROWN - Il codice da Vinci (2003)
PROLOGO
Museo del Louvre, Parigi
ore 22.46
Il famoso curatore del Louvre, Jacques Saunière, raggiunse a fatica l'ingresso della Grande Galleria e corse verso il quadro più vicino a lui, un Caravaggio. Afferrata la cornice dorata, l'uomo
di settantasei anni tirò il capolavoro verso di sé fino a staccarlo dalla parete, poi cadde all'indietro sotto il peso del dipinto.
Come da lui previsto, una pesante saracinesca di ferro calò nel punto da cui era passato poco prima, bloccando l'ingresso al corridoio. Il pavimento di parquet tremò. Lontano, un allarme cominciò
a suonare.
Per un momento, ansimando profondamente, il curatore rimase immobile per fare l'inventario dei danni. "Sono ancora vivo." Uscì da sotto la tela, strisciando, e si guardò attorno, nella galleria
simile a una caverna, per cercare un nascondiglio.
Si udì una voce, spaventosamente vicina. «Non si muova.»
Il curatore, che era riuscito a mettersi carponi, si immobilizzò e voltò lentamente la testa. A soli cinque metri da lui, dietro la saracinesca, si scorgeva attraverso le sbarre l'enorme
silhouette del suo assalitore. Era un uomo alto, dalle spalle larghe, la pelle pallida come quella di uno spettro, i capelli bianchi radi. Aveva le iridi rosa e le pupille rosso scuro.
L'albino prese una pistola dalla tasca e infilò la canna in mezzo alle sbarre, puntandola contro Saunière. «Non doveva fuggire.» Parlava con un accento difficile da individuare. «Adesso mi dica
dov'è.»
«Gliel'ho già detto» balbettò il curatore, indifeso e inginocchiato sul pavimento della galleria. «Non ho idea di che cosa stia parlando.»
«Lei mente.» L'uomo lo fissò, perfettamente immobile, a parte il luccichio dei suoi occhi spettrali. «Lei e i suoi compagni possedete qualcosa che non è vostro.»
Il curatore si sentì percorrere da una scarica di adrenalina. "Da chi può averlo saputo?"
«Questa notte ritornerà ai suoi legittimi guardiani. Mi dica dov'è nascosta e le risparmierò la vita.» L'uomo puntò la pistola contro la testa del curatore. «È un segreto per cui vale la pena di
morire?»
Saunière si sentì mancare il fiato.
L'albino inclinò leggermente la testa, prendendo la mira lungo la canna dell'arma.
Saunière alzò le mani come per difendersi. «Aspetti. Le dirò quello che vuole sapere.» Poi proseguì lentamente, scandendo con attenzione le parole. La bugia che raccontò l'aveva già ripetuta
molte volte, tra sé e sé... augurandosi ogni volta di non doverla mai pronunciare.
Quando il curatore ebbe terminato di parlare, il suo assalitore sorrise con aria astuta. «Sì. È esattamente quello che mi hanno detto gli altri.»
Saunière trasalì. "Gli altri?"
«Ho trovato anche loro» disse il gigantesco albino. «Tutt'e tre. Hanno confermato quello che lei mi ha raccontato adesso.»
"Non può essere!" L'identità nascosta del curatore, come quella dei suoi tre sénéchaux, era sacra come l'antico segreto da loro protetto. Saunière ora comprendeva l'accaduto: i suoi siniscalchi
avevano seguito la procedura e detto la stessa bugia prima di morire. Faceva parte del protocollo stabilito.
L'aggressore puntò di nuovo la pistola. «Scomparso lei, sarò il solo a conoscere la verità.»
"La verità." In un istante, il curatore comprese il vero orrore della situazione. "Se morrò, la verità andrà persa per sempre." Istintivamente, cercò di mettersi al riparo.
La pistola ruggì; il curatore sentì un lancinante bruciore quando il proiettile gli entrò nello stomaco. Cadde in avanti... lottando contro il dolore. Poi, lentamente, Saunière si girò su se
stesso e guardò il suo assalitore, dietro le sbarre.
KHALED HOSSEINI - Il cacciatore di aquiloni (2004)

Sono diventato la persona che sono oggi all'età di dodici anni, in una gelida giornata invernale del 1975.
Ricordo il momento preciso: ero accovacciato dietro un muro di argilla mezzo diroccato e sbirciavo di nascosto nel vicolo lungo il torrente ghiacciato. E' stato tanto tempo fa. Ma non è vero,
come dicono molti, che si può seppellire il passato. Il passato si aggrappa con i suoi artigli al presente. Sono ventisei anni che sbircio di nascosto in quel vicolo deserto.
Oggi me ne rendo conto.
Nell'estate del 2001 mi telefonò dal Pakistan il mio amico Rahim Khan.
Mi chiese di andarlo a trovare.
In piedi in cucina, il ricevitore incollato all'orecchio, sapevo che in linea non c'era solo Rahim Khan. C'era anche il mio passato di peccati non espiati. Dopo la telefonata andai a fare una
passeggiata intorno al lago Spreckels. Il sole scintillava sull'acqua dove dozzine di barche in miniatura navigavano sospinte da una brezza frizzante. In cielo due aquiloni rossi con lunghe code
azzurre volavano sopra i mulini a vento, fianco a fianco, come occhi che osservassero dall'alto San Francisco, la mia città d'adozione. Improvvisamente sentii la voce di Hassan che mi sussurrava:
Per te qualsiasi cosa. Hassan, il cacciatore di aquiloni.
Seduto su una panchina all'ombra di un salice mi tornò in mente una frase che Rahim Khan aveva detto poco prima di riattaccare, quasi un ripensamento.
Esiste un modo per tornare a essere buoni. Alzai gli occhi verso i due aquiloni. Pensai ad Hassan. A Baba e ad Ali. A Kabul. Pensai alla mia vita fino a quell'inverno del 1975. Quando tutto era
cambiato. E io ero diventato la persona che sono oggi.
Due.
Da bambini Hassan e io ci arrampicavamo su uno dei pioppi lungo il vialetto che portava a casa mia e da lassù infastidivamo i vicini riflettendo la luce del sole in un frammento di
specchio. Ci sedevamo uno di fronte all'altro su un ramo, le gambe nude a penzoloni, e mangiavamo more di gelso e castagne di cui avevamo sempre le tasche piene. Usavamo il frammento di specchio
a turno, ci tiravamo le more e ridevamo come matti. Vedo ancora i raggi di sole che filtrano attraverso il fogliame illuminando il viso di Hassan: perfettamente tondo, come quello di una bambola
cinese di legno, con il naso largo e piatto, gli occhi a mandorla, stretti come una foglia di bambù, giallo oro, verdi, o azzurri come zaffiri a seconda della luce. Ricordo le piccole orecchie
dall'attaccatura bassa e il mento appuntito, che sembrava un'appendice carnosa, aggiunta al viso in un secondo momento.
E quel labbro spezzato, un errore del fabbricante di bambole, cui forse era sfuggito lo scalpello, per stanchezza o disattenzione.
Talvolta, mentre ce ne stavamo nascosti sugli alberi, proponevo ad Hassan di estrarre la sua fionda e mitragliare di castagne il pastore tedesco del nostro vicino. Lui non voleva mai, ma se io
glielo chiedevo, glielo chiedevo veramente, cedeva. Non mi avrebbe mai rifiutato nulla. E la sua fionda era infallibile.
Quando suo padre Ali ci scopriva, si arrabbiava - per quanto si potesse arrabbiare una persona gentile come lui - e minacciandoci con il dito ci faceva scendere dall'albero. Poi ci
requisiva lo specchio e ci ripeteva quello che sua madre diceva a lui quando era piccolo: che anche il diavolo usa gli specchi per distrarre i musulmani dalla preghiera. «E ride mentre lo fa»
aggiungeva sempre, guardando severamente il figlio.
«Sì, padre» balbettava Hassan con gli occhi a terra.
Ma non mi ha mai tradito. Non ha mai confessato che tanto lo specchio quanto le castagne erano idee mie.
BANANA YOSHIMOTO - Il corpo sa tutto (2004)

IL POLLICE VERDE.
In treno avevo dormicchiato, e così avevo per metà la sensazione di sognare. Quando sentii il nome della mia stazione, scesi precipitosamente. Nell'aria pungente dell'inverno, il marciapiede
sembrava ghiacciato. Mi strinsi bene la sciarpa e uscii dal controllo biglietti.
Salita in taxi, chiesi all'autista di portarmi all'albergo, ma lui disse di non conoscerlo. Ricordai che si trattava di un albergo nuovo, piccolo, probabilmente poco pubblicizzato, e così mi feci
lasciare in una zona da cui avrei potuto facilmente raggiungerlo.
Tutt'intorno non c'erano altro che campi, e in lontananza si vedeva il profilo dolce delle montagne. Quando trovai una piccola insegna che indicava l'albergo, la seguii inerpicandomi per una
stretta salita.
Ora che mi ero abituata al freddo, assaporavo con gioia l'aria pulita. Ero sempre più sveglia, e stavo cominciando a sudare un po' quando davanti a me percepii la presenza di qualcuno che
conoscevo.
Era stato durante l'inverno precedente che era venuto fuori il discorso dell'aloe nella stradina davanti casa, cresciuto troppo e diventato di intralcio.
Mio padre, mia madre e io avevamo completamente dimenticato l'aloe che mia sorella più piccola aveva comprato per trecento yen e che, per mancanza di spazio in giardino, avevamo piantato accanto
alla porta d'ingresso. Anche lei che, sotto l'influenza di una rivista o non so cosa, ci aveva continuamente ripetuto che "l'aloe cura tutto! Bisogna berlo, applicarlo sui brufoli", alla fine era
guarita da questa fissazione e aveva smesso persino di occuparsene. Ma anche se non veniva innaffiato regolarmente e l'esposizione al sole non era molto buona, l'aloe era cresciuto. Anzi, era
cresciuto anche troppo, fino a diventare in breve tempo una specie di albero che sporgeva invadendo parte della strada, e in più ricoperto di fiori rossi dalla forma sgradevole.
Ricordo bene quella volta. Mio padre, mia sorella e io eravamo intorno al piccolo tavolo di cucina nella casa dove eravamo nate e cresciute. Stava per cominciare una sera come tutte le
altre.
Quando eravamo piccole, era quello il luogo della casa dove tutto si svolgeva. Lì cenavamo, litigavamo, guardavamo la tivù, mangiavamo i dolci che io e mia sorella avevamo comprato con i soldi di
entrambe. Capitava che sul tavolo ci fossero la busta dei grandi magazzini con la biancheria intima della mamma e il pesce secco che avremmo mangiato quella sera per cena. Era lì che una volta il
babbo era crollato addormentato per i postumi di una sbornia, lì che mia sorella, ai tempi delle medie, per la sua prima delusione d'amore aveva bevuto del vino tutto d'un fiato, si era ubriacata
ed era scivolata dalla sedia battendo la testa. Quel piccolo rettangolo era il simbolo della nostra famiglia. Era un luogo che odorava di vita, tiepido, morbido, caldo. Da poco tempo mia sorella
si è sposata ed è andata via, e il tavolo è sempre lì ma è raro che la famiglia vi si riunisca al completo. Adesso la mamma ci si siede spesso per lavorare a maglia guardando la televisione. E
così, piano piano, il paesaggio si trasforma.
Quella sera mio padre disse: "L'aloe è cresciuto troppo, ho paura che dia fastidio al vicino quando va a prendere la macchina dal garage". Io e mia sorella facemmo finta di non sentire, che
seccatura sarebbe stata doverlo trapiantare da qualche altra parte! "Se non ve ne occupate voi lo strappo e lo butto via" minacciò mio padre, ma noi rispondemmo: "Fai pure" e seppellimmo il naso
nelle riviste.
Mentre si svolgeva questa scena, rientrò la mamma carica di sacchetti con la spesa fatta al supermercato vicino casa. Io e mia sorella la salutammo come al solito, senza neanche guardarla bene in
faccia. Poiché non ci rispose, alzammo gli occhi e ci accorgemmo che era molto pallida. "Che hai?" chiese mia sorella.
"La nonna si era fatta ricoverare per una lombalgia, ma in ospedale le hanno trovato un cancro all'utero in uno stadio molto avanzato. Pare che da tempo soffrisse parecchio, ma non aveva detto
nulla. Dicono che non si può nemmeno operare.
La nonna viveva da sola in un appartamento nelle vicinanze. Due giorni prima aveva detto di avere una lombalgia, e così mia sorella aveva tirato fuori l'automobile e l'aveva portata in
ospedale.
I miei genitori sono entrambi figli unici, quindi abbiamo pochi parenti, e questo ci rende molto uniti. Così tutti, incluso mio padre, andavamo ogni giorno a turno in ospedale.
Non era certo più il caso di stare a pensare all'aloe. La nonna fu dimessa dall'ospedale una volta, poi di nuovo ricoverata.
STIEG LARSSON - Uomini che odiano le donne (2005)
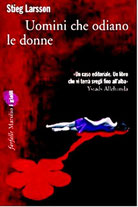
Prologo
Venerdì 1 novembre
Era diventato un rito che si ripeteva ogni anno. Il destinatario del fiore ne compiva stavolta ottantadue. Quando il fiore arrivò, aprì il pacchetto e lo liberò della carta da regalo in cui era
avvolto. Quindi sollevò il ricevitore e compose il numero di un ex commissario di pubblica sicurezza che dopo il pensionamento era andato a stabilirsi sulle rive del lago Siljan. I due uomini non
erano solo coetanei, ma erano anche nati nello stesso giorno - fatto che in quel contesto poteva essere considerato come una sorta d'ironia. Il commissario, che sapeva che la telefonata sarebbe
arrivata dopo la distribuzione della posta delle undici, nell'attesa stava bevendo un caffè. Quest'anno il telefono squillò già alle dieci e trenta. Lui alzò la cornetta e disse ciao senza
nemmeno presentarsi.
«È arrivato.»
«Cos'è, questa volta?»
«Non so che genere di fiore sia. Lo farò identificare. È bianco.»
«Nessuna lettera, suppongo?»
«No. Nient'altro che il fiore. La cornice è la stessa dell'anno scorso. Una di quelle cornici da poco che uno si monta da solo.»
«Timbro postale?»
«Stoccolma.»
«Calligrafia?»
«Come al solito, stampatello, tutte maiuscole. Lettere dritte e ordinate.»
Con ciò l'argomento era stato esaurito e i due rimasero seduti qualche minuto in silenzio, ognuno dalla sua parte della linea telefonica. Il commissario in pensione si lasciò andare contro lo
schienale della sedia davanti al tavolo della cucina, succhiando la pipa. Sapeva comunque che non ci si aspettava più che ponesse qualche domanda risolutiva oppure iperintelligente, in grado di
gettare nuova luce sulla faccenda. Quel tempo era passato da un pezzo, e la conversazione fra i due anziani conoscenti aveva piuttosto il carattere di un rituale intorno a un mistero che nessun
altro essere umano al mondo aveva il benché minimo interesse a risolvere.
Il suo nome latino era Leptospermum (Myrtaceae) Rubinette. Si trattava di un arbusto piuttosto anonimo dotato di piccole foglie simili a quelle dell'erica, che produceva un fiore di due
centimetri con una corolla di cinque petali. Era alto grossomodo dodici centimetri.
La pianta era originaria delle regioni montuose e del bush australiani, dove cresceva in robusti agglomerati. In Australia la chiamavano Desert Snow. Più avanti, un'esperta del giardino botanico
di Uppsala avrebbe constatato che si trattava di una pianta insolita, raramente coltivata in Svezia.
PHILIPPA GREGORY - L'altra donna del re (2005)
Primavera 1521.
Udivo un rullo attutito di tamburi, ma non vedevo nulla tranne il pizzo sul corpetto della dama che mi stava davanti e mi ostruiva la vista del patibolo. Era più di un anno che vivevo a corte e
avevo assistito a centinaia di eventi mondani, però mai a uno come questo.
Spostandomi un po' di lato e piegando il collo riuscii a scorgere il condannato, accompagnato dal prete, che procedeva lentamente dalla Torre verso la zona erbosa dove lo aspettavano la
piattaforma di legno, il ceppo piazzato al centro e il boia in maniche di camicia, con un cappuccio nero che gli copriva la testa. Sembrava più un masque, una rappresentazione allegorica, che un
evento reale. Il re, seduto sul trono, appariva distratto, come se stesse ripassando tra sé e sé il discorso con cui avrebbe concesso il perdono.
In piedi dietro di lui stavano mio marito William Carey, che avevo sposato un anno prima, mio fratello George e mio padre, Sir Thomas, tutti con l'espressione grave. Mi sgranchii le dita dei
piedi nelle babbucce di seta, sperando che il re si sbrigasse a concedere la grazia, in modo che potessimo andare tutti a colazione. Io, Maria Bolena, avevo solo tredici anni e avevo sempre
fame.
Sul patibolo, il duca di Buckinghamshire si tolse la pesante giubba. Eravamo parenti abbastanza prossimi perché lo chiamassi zio. Aveva assistito al mio matrimonio e mi aveva regalato un
braccialetto dorato. Aveva offeso il re in una decina di modi, questa la spiegazione datami da mio padre: aveva sangue reale nelle vene, e il suo seguito di uomini armati era troppo numeroso per
i gusti di un sovrano non ancora ben saldo sul trono; ancor peggio, sembrava avesse affermato che il re al momento non aveva un figlio maschio, non avrebbe potuto averlo e probabilmente sarebbe
morto senza un erede al trono.
Una cosa simile non andava detta a voce alta. Il re, la corte, il paese intero sapevano che la regina avrebbe dovuto dare alla luce un maschio, il prima possibile. Suggerire altrimenti equivaleva
a compiere il primo passo verso gli scalini di legno del patibolo, sui quali stava salendo ora mio zio, con fermezza e senza paura. Un bravo cortigiano non deve mai accennare a verità sgradevoli.
La vita di una corte dovrebbe sempre essere allegra.
Zio Stafford si portò sul bordo anteriore della piattaforma per dire le sue ultime parole. Ero troppo lontana per udirlo, e comunque la mia attenzione era tutta puntata sul re, che era in attesa
del momento giusto per fare un passo avanti ed elargire il perdono reale. Quell'uomo in piedi sul patibolo era stato suo compagno a tennis, suo rivale nei tornei, suo amico in centinaia di
bisbocce, tra bevute e giochi d'azzardo; fin da quando il sovrano era un bambino aveva condiviso tante cose con lui. Ora lui gli stava dando una lezione, una grandiosa lezione in pubblico, poi lo
avrebbe perdonato e saremmo andati tutti a colazione.
La figura lontana si voltò verso il confessore. Chinò la testa per la benedizione e baciò il rosario. Si inginocchiò davanti al ceppo e lo afferrò con entrambe le mani. Mi chiesi che sensazione
dava appoggiare una guancia su quel legno levigato e incerato, annusare il vento tiepido proveniente dal fiume, udire le strida dei gabbiani. Pur sapendo, come sapeva, che quello era un masque,
doveva essere strano per lo zio mettere giù la testa, avendo il boia dietro le spalle.
L'uomo incappucciato sollevò l'ascia. Guardai il re.
Aspettava proprio l'ultimo momento per intervenire!
PHILIPPA GREGORY - Caterina, la prima moglie (2005)
Granada 1491 .
Vi fu un urlo e poi si udì il fragore del fuoco che avviluppava i tendaggi in seta.
Un crescendo di grida si diffondeva da una tenda all'altra, da uno stendardo all'altro, mentre le fiamme risalivano i tiranti e irrompevano da porte in mussola.
I cavalli iniziarono a nitrire e gli uomini sbraitarono per calmarli, ma il terrore nelle loro stesse voci alimentava la paura, fino a quando l'intera piana fu illuminata dal terribile incendio e
la notte fu avvolta dal fumo.
La bambina gridò spaventata e chiamò la madre in spagnolo: «I mori? Ci stanno assalendo i mori?» «Mio Dio, salvaci, stanno incendiando l'accampamento!» esclamò la balia. «Madre di Dio, mi
violenteranno e infilzeranno voi sulle loro lame ricurve.» «Madre!» urlò la bimba, scendendo dal letto. «Dov'è mia madre?» Si precipitò fuori, la camicia da notte che svolazzava, i teli in fiamme
alle sue spalle in un inferno di panico. Tutte le migliaia e migliaia di tende dell'accampamento bruciavano e si levavano scintille nel buio notturno.
«Madre!» gridò in cerca d'aiuto.
Dalle fiamme si materializzarono due enormi cavalli scuri, come animali mitologici che si muovevano all'unisono, neri come l'ebano stagliati nel bagliore del fuoco. Dall'alto, da più in alto di
quanto si possa sognare, la madre della bimba si chinò per parlare alla figlia, la testa che arrivava appena alla spalla del cavallo. «Resta con la balia e fa' la brava», le ordinò, la voce priva
di paura. «Tuo padre e io dobbiamo farci vedere da tutti.» «Portatemi con voi! Madre! Brucerò. Lasciatemi venire! I mori mi prenderanno!» La bambina allungò le braccia verso di lei.
La luce del fuoco si rifletté dalla corazza e dalle gambiere goffrate della madre, come se fosse fatta d'oro e d'argento, mentre si chinava a spiegare in tono grave: «Se gli uomini non mi vedono,
diserteranno».
«Non m'importa!» piagnucolò la bimba terrorizzata. «Non m'importa di niente, solo di voi! Tiratemi su!» «L'esercito è più importante», dichiarò dall'imponente destriero nero. «Devo farmi vedere.»
Allontanò la testa dell'animale dalla figlia in preda al panico. «Tornerò a prenderti», le promise da sopra la spalla. «Aspettami qui. Ora devo andare.» Impotente, la piccola osservò i genitori
allontanarsi a cavallo. «Madre!» strillò. «Madre! Per piacere!» Ma la donna non si voltò.
«Bruceremo vive!» gridò l'ancella Madilla alle sue spalle. «Correte! Correte e nascondetevi!» «Zitta», inveì la bambina con improvvisa e rabbiosa cattiveria.
«Se io, la principessa del Galles in persona, posso essere abbandonata in un accampamento in fiamme, di certo potrete sopportarlo voi, che non siete altro che una raorisca.» Osservò i due cavalli
trottare fra le tende in fiamme.
Ovunque andavano le urla cessavano e, nel campo atterrito, ritornò una certa disciplina. Gli uomini formarono delle 4 file, passandosi secchi d'acqua dal canale d'irrigazione e ritrovando
lentamente l'ordine. Il generale corse disperato tra i suoi uomini, sferzandoli con la spada e riorganizzando così un battaglione con quelli che solo un attimo prima stavano fuggendo: li schierò
in una formazione di difesa nella piana, nel caso i mori avessero visto le colonne di fuoco dai loro scuri spalti merlati e avessero fatto una sortita per attaccarli nell'accampamento. Quella
notte i saraceni non si fecero vedere: rimasero dietro le alte mura del loro castello, chiedendosi quale nuova diavoleria i pazzi cristiani stessero architettando nell'oscurità, troppo spaventati
per uscire nell'inferno creato dal nemico, sospettando qualche trappola infedele.
La bimba di soli cinque anni osservò la determinazione della madre vincere il fuoco, la sua consapevolezza regale dissipare il panico, la sua certezza nel successo superare la realtà del disastro
e della sconfitta. Si appollaiò su una delle casse del tesoro, rimboccò la camicia da notte attorno ai piedi nudi e attese che l'accampamento si calmasse.
MICHAEL BENOIT - Il tredicesimo apostolo
Tracciato sul fianco della montagna, l'angusto sentiero dominava una vallata. Lontano, più in basso, si intuiva un torrente che convogliava le acque: avevo lasciato il mio camper alla fine della strada forestale; non sarei riuscito a procedere oltre. Nell'Italia turistica e industriosa, il massiccio del Gran Sasso appariva selvaggio e deserto come agli albori dell'umanità.
All'uscita di un boschetto di abeti, il fondo della valle mi apparve: un pendio impressionante che si elevava fino a una frangia che nascondeva il versante adriatico.
Uccelli da preda planavano pigramente. Una solitudine assoluta a una decina di chilometri dalla strada affollata di villeggianti, nessuno dei quali si sarebbe avventurato sin qui.
Fu allora che lo incontrai: indossava una sorta di blusa, il falcetto in mano, chino su un ciuffo di genziane. I capelli bianchi che gli sfioravano le spalle mettevano in risalto la fragilità della sua figura.
Quando si alzò vidi una barba incolta e due occhi chiari, acquatici; uno sguardo infantile, ingenuo e tenero, eppure penetrante e vivo, mi mise a nudo l'anima.
«Eccola... l'ho sentita arrivare. Qui i suoni giungono da molto lontano. Non viene mai nessuno in questa vallata.»
«Parla francese!»
Si alzò, infilò il falcetto nella cintura della blusa, e senza darmi la mano disse: «Padre Nil. Sono - o piuttosto, ero - monaco in un'abbazia francese. Prima».
STIEG LARSSON - La ragazza che giocava con il fuoco (2006)

Prologo
Era legata con cinghie di cuoio a una stretta branda con il telaio in acciaio. Le cinghie tese sopra il torace premevano. Era stesa sulla schiena. Le mani bloccate all'altezza dei fianchi.
Ormai aveva rinunciato da tempo a qualsiasi tentativo di liberarsi. Era sveglia ma teneva gli occhi chiusi. Se li avesse aperti si sarebbe ritrovata al buio, l'unica fonte di luce era una debole
striscia che filtrava da sopra la porta. Si sentiva in bocca un sapore cattivo e non vedeva l'ora di potersi lavare i denti.
Una parte della sua coscienza tendeva l'orecchio per cogliere il rumore di passi che avrebbe indicato che lui stava arrivando. Non aveva la minima idea di che ora della sera fosse, al di là del
fatto che aveva l'impressione che cominciasse a essere troppo tardi perché venisse a trovarla. Un'improvvisa vibrazione della branda la indusse ad aprire gli occhi. Era come se un macchinario di
qualche genere si fosse avviato da qualche parte all'interno dell'edificio. Ma dopo un paio di secondi non sapeva se fosse stata solo un'illusione oppure se il rumore fosse stato reale.
Mentalmente spuntò un altro giorno sul calendario.
Era il suo quarantatreesimo giorno di prigionia.
Avvertì un prurito nel naso e girò la testa in modo da poterlo sfregare contro il cuscino. Sudava. Nella stanza l'aria era calda e soffocante. Indossava una semplice camicia da notte che le si
era arrotolata sotto il corpo. Spostando l'anca riusciva ad afferrare l'indumento fra l'indice e il medio e a tirarlo giù da una parte un poco alla volta. Ripeté il procedimento con l'altra mano.
Ma la camicia faceva ancora una piega sotto l'osso sacro. Il materasso era sformato e scomodo. Il totale isolamento faceva sì che ogni piccola impressione, che altrimenti sarebbe passata del
tutto inosservata, si ingigantisse pesantemente. Le cinghie erano abbastanza lasche da permetterle di cambiare posizione e mettersi sul fianco, ma anche così era scomoda perché doveva stare con
una mano dietro la schiena e questo le faceva intorpidire il braccio.
Non era spaventata. Al contrario sentiva accumularsi dentro di sé una rabbia violenta.
Ma era anche tormentata dai suoi stessi pensieri che si trasformavano costantemente in sgradevoli fantasie su ciò che le sarebbe successo. Odiava la sua impotenza coatta. Per quanto cercasse di
concentrarsi su qualcos'altro per far passare il tempo e reprimere il pensiero della sua situazione, l'angoscia riusciva comunque a filtrare. Ristagnava intorno a lei come una nube di gas
minacciando di infiltrarsi nei suoi pori e avvelenarle l'esistenza. Aveva scoperto che il modo migliore per tenere lontana l'angoscia era fantasticare di qualcosa che le desse una sensazione di
forza. Chiuse gli occhi e richiamò l'odore della benzina.
Lui era in macchina con il finestrino aperto. Lei gli si avventava contro, versava la benzina e accendeva un fiammifero. Questione di un attimo. Le fiamme si alzavano subito. Lui si contorceva
dal dolore e lei sentiva le sue urla di terrore e sofferenza. Poteva percepire l'odore della carne bruciata e quello più aspro del rivestimento e dell'imbottitura dei sedili che si incenerivano.
MURIEL BARBERY - L'eleganza del riccio (2006)

Capitolo primo
Chi semina desiderio
«Marx cambia completamente la mia visione del mondo» mi ha dichiarato questa mattina il giovane Pallières che di solito non mi rivolge nemmeno la parola.
Antoine Pallières, prospero erede di un’antica dinastia industriale, è il figlio di uno dei miei otto datori di lavoro. Ultimo ruttino dell’alta borghesia degli affari - la quale si riproduce
unicamente per singulti decorosi e senza vizi -, era tuttavia raggiante per la sua scoperta e me la narrava di riflesso, senza sognarsi neppure che io potessi capirci qualcosa. Che cosa possono
mai comprendere le masse lavoratrici dell’opera di Marx? La lettura è ardua, la lingua forbita, la prosa raffinata, la tesi complessa.
A questo punto, per poco non mi tradisco stupidamente.
«Dovrebbe leggere L’ideologia tedesca» gli dico a quel cretino in montgomery verde bottiglia.
Per capire Marx, e per capire perché ha torto, bisogna leggere L’ideologia tedesca. È lo zoccolo antropologico sul quale si erigeranno tutte le esortazioni per un mondo migliore e sul quale è
imperniata una certezza capitale: gli uomini, che si dannano dietro ai desideri, dovrebbero attenersi invece ai propri bisogni. In un mondo in cui la hybris del desiderio verrà imbavagliata potrà
nascere un’organizzazione sociale nuova, purificata dalle lotte, dalle oppressioni e dalle gerarchie deleterie.
“Chi semina desiderio raccoglie oppressione” sono sul punto di mormorare, come se mi ascoltasse solo il mio gatto.
Ma Antoine Pallières, a cui un ripugnante aborto di baffi non conferisce invece niente di felino, mi guarda, confuso dalle mie strane parole. Come sempre, mi salva l’incapacità del genere umano
di credere a ciò che manda in frantumi gli schemi di abitudini mentali meschine. Una portinaia non legge L’ideologia tedesca e di conseguenza non sarebbe affatto in grado di citare l’undicesima
tesi su Feuerbach. Per giunta, una portinaia che legge Marx ha necessariamente mire sovversive ed è venduta a un diavolo chiamato sindacato. Che possa leggerlo per elevare il proprio spirito,
poi, è un’assurdità che nessun borghese può concepire.
«Mi saluti tanto la sua mamma» borbotto chiudendogli la porta in faccia e sperando che la disfonia delle due frasi venga coperta dalla forza di pregiudizi millenari.
Isabel Allende - Inés dell'anima mia (2006)

Sono Inés Suárez, suddita nella leale città di Santiago della Nuova Estremadura, Regno del Cile, anno 1580 di Nostro Signore. Della data esatta della mia nascita non sono certa ma, stando a mia madre, venni alla luce dopo la carestia e la terribile pestilenza che devastarono la Spagna alla morte di Filippo il Bello. Non credo fosse stata la scomparsa del re a provocare la peste, come diceva la gente vedendo passare il corteo funebre che lasciava dietro di sé per giorni, sospeso nell'aria, un odore di mandorle amare, ma non si può mai dire... La regina Giovanna, ancora giovane e bella, percorse in lungo e in largo la Castiglia per oltre due anni portandosi appresso quel feretro che apriva di tanto in tanto per baciare le labbra del marito, nella speranza che risuscitasse. A dispetto degli unguenti dell'imbalsamatore, il Bello puzzava. Quando io venni al mondo, la sventurata regina, pazza da legare, era già stata reclusa nel palazzo di Tordesillas insieme al cadavere del consorte, e ciò significa che ho sul groppone almeno una settantina di inverni e che prima di Natale mi toccherà morire. Potrei dire che è stata una gitana, sulle rive del fiume Jerte, a pronosticare la data della mia morte, ma sarebbe una di quelle falsità cui si dà forma nei libri e che per il fatto di essere stampate sembrano vere. La gitana mi predisse semplicemente una lunga vita, genere di augurio che si fa a chiunque in cambio di una moneta. È il mio cuore frastornato ad annunciarmi la prossimità della fine. Ho sempre saputo che sarei morta anziana, in pace e nel mio letto, come tutte le donne della mia famiglia; per questo non ho esitato ad affrontare molteplici pericoli, dal momento che nessuno se ne va all'altro mondo prima che sia giunto il suo momento. "Tu andrai morendo vecchietta, non prima, señoray" mi tranquillizzava Catalina nel suo affabile castigliano del Perú quando il galoppo insistente che sentivo nel petto mi scagliava a terra. Ho dimenticato il nome in quechua di Catalina e ormai è tardi per domandarglielo, visto che l'ho seppellita nel patio di casa mia molti anni fa, ma sono assolutamente certa della precisione e della veridicità delle sue profezie. Catalina entrò al mio servizio nell'antica città di Cuzco, gioiello degli inca, all'epoca di Francisco Pizarro, quell'audace bastardo che, secondo le male lingue, in Spagna accudiva i maiali e finì per diventare marchese governatore del Perú, sfiancato dalla sua stessa ambizione e dai numerosi tradimenti. Ironia della sorte, in questo Nuovo Mondo, non sono in vigore le leggi della tradizione e tutto è aggrovigliato: santi e peccatori, bianchi, neri, mulatti, indios, meticci, nobili e braccianti... A chiunque di loro può succedere di trovarsi in catene, marchiato col ferro incandescente, e che la fortuna poi lo innalzi di nuovo. Ho vissuto più di quarant'anni nel Nuovo Mondo e ancora non mi sono abituata al disordine, benché io stessa ne abbia beneficiato, dato che, se fossi rimasta nel mio paesino d'origine, oggi sarei un'anziana qualsiasi, povera e cieca per il tanto cucire pizzi alla luce di una lanterna. Là sarei Inés, la sarta della strada dell'acquedotto. Qui sono doña Inés Suárez, signora tra le più influenti, vedova dell'eccellentissimo governatore don Rodrigo de Quiroga, conquistatrice e fondatrice del Regno del Cile.
THOMAS HARRIS - Hannibal Lecter . L'origine del male (2006)

PROLOGO
La porta del palazzo della memoria del dottor Hannibal Lecter è immersa nel buio al centro della sua mente e ha una serratura che può essere trovata solo al tatto. Questo strano portale si apre
su spazi immensi e ben illuminati, un po' barocchi, con corridoi e stanze che rivaleggiano per numero e varietà con quelle del museo Topkapi.
Ci sono esposizioni ovunque, ben allestite e con le luci appropriate, ognuna collegata a ricordi che portano ad altri ricordi in una progressione geometrica.
Gli spazi dedicati ai primi anni di Hannibal Lecter sono diversi dalle altre sale per la loro incompletezza. Vi sono scene statiche, frammentarie, come ceramiche attiche tenute insieme dallo
stucco. Altre stanze racchiudono suoni e gesti, enormi serpenti che lottano e ondeggiano nell'oscurità, e si illuminano in lampi improvvisi. Suppliche e urla echeggiano in anfratti al
pianterreno, dove lo stesso Hannibal non può andare. Ma nei corridoi non si odono grida, anzi, può esserci della musica.
Il palazzo è una costruzione che ha avuto inizio presto, quando Hannibal era uno studente. Nei suoi anni d'isolamento lo ha reso più grande e più bello, e quei tesori lo hanno sostenuto per
lunghi periodi, quando i guardiani gli negavano persino i suoi libri.
Qui, nella calda oscurità della sua mente, cerchiamo insieme il chiavistello. Una volta che lo avremo trovato, seguiamo la musica nei corridoi e, senza guardare né a sinistra né a destra, andiamo
alla Saia dell'Inizio, dove le esposizioni sono più frammentarie.
Vi aggiungeremo quello che abbiamo appreso altrove, negli archivi di guerra e della polizia, dagli interrogatori e dalle indagini, dalle mute posture dei morti. Le lettere di Robert Lecter,
scoperte di recente, ci possono aiutare a stabilire i dati significativi della vita di Hannibal, che alterò a piacimento le date per confondere le autorità e i suoi cronisti. Grazie ai nostri
sforzi potremo vedere come la bestia che è dentro abbandoni il seno materno e, lavorando per emergere, appaia nel mondo.
Ildefonso Falcones - La cattedrale del mare (2006)

Anno 1320
Masseria di Bernat Estanyol Navarcles, principato di Catalogna.
Approfittando di un attimo di disattenzione dei presenti, Bernat alzò gli occhi verso il cielo azzurro e terso. Il tenue sole di fine settembre accarezzava i volti dei suoi invitati. Aveva dedicato così tante ore e sforzi ai preparativi della festa che solo un tempo inclemente avrebbe potuto rovinarla. Bernat sorrise al cielo autunnale e, quando abbassò lo sguardo, l'espressione dipinta sul suo volto si accentuò di fronte all'allegria che regnava sullo spiazzo di pietra davanti alla porta delle stalle, al pianterreno della masseria.
Gli invitati, una trentina, erano entusiasti: la vendemmia, quell'anno, era stata ottima. Tutti, uomini, donne e bambini, avevano lavorato dall'alba al tramonto, prima per raccogliere l'uva e poi per pigiarla, senza concedersi un momento di riposo.
Solo quando il mosto era ormai a fermentare nelle botti e le vinacce riposte per essere poi distillate nelle tediose giornate invernali, i contadini celebravano le feste di settembre. E Bernat Estanyol aveva deciso di sposarsi proprio in quell'occasione.
Ossservò i suoi invitati: si erano dovuti svegliare all'alba per coprire a piedi la distanza, in alcuni casi assai rilevante, che separava la loro masseria da quella degli Estanyol. Chiacchieravano animatamente delle nozze, del raccolto o di entrambe le cose; alcuni, come il gruppo in cui si trovavano i cugini Estanyol e i Puig, la famiglia di suo cognato, scoppiarono a ridere e gli rivolsero un'occhiata maliziosa. Bernat si accorse che stava arrossendo e preferì ignorarli: non voleva neppure immaginare il motivo della loro ilarità. Sparpagliati sullo spiazzo della masseria scorse i Fontanes, i Vila e gli Joaniquet oltre, naturalmente, ai parenti della sposa: gli Esteve.
Bernat guardò di sottecchi il suocero, Pere Esteve, che portava instancabilmente in giro la sua immensa pancia, sorridendo agli uni e rivolgendo la parola agli altri. Pere girò la faccia allegra verso di lui e Bernat si sentì obbligato a salutarlo ancora una volta, poi cercò con lo sguardo i suoi cognati e li trovò mescolati agli altri. Fin dal primo momento l'avevano trattato con una certa diffidenza, malgrado gli sforzi con cui aveva cercato di ingraziarseli.
Alzò di nuovo gli occhi al cielo. Il raccolto e il tempo avevano deciso di partecipare alla sua festa.
Guardò la masseria e poi ancora la gente, e strinse appena le labbra. D'un tratto, malgrado tutta quella confusione, si sentì solo. Suo padre era morto appena un anno prima; quanto alla sorella Guiamona, che si era stabilita a Barcellona subito dopo essersi sposata, non aveva mai risposto ai messaggi che le aveva inviato. L'avrebbe rivista volentieri, gli restava soltanto lei dopo la morte del padre.
Una morte che aveva attirato sulla masseria degli Estanyol l'interesse dell'intera regione: mezzane di matrimoni e padri di figlie nubili avevano sfilato senza sosta fino a casa sua. E dire che prima nessuno andava mai a fargli visita, ma alla morte del padre, che per il suo carattere ribelle e impetuoso si era meritato il soprannome di Estanyol il Pazzo, Bernat aveva rinverdito le speranze di quanti desideravano accasare la propria figlia con il contadino più ricco della regione.
“Ormai sei grande abbastanza per sposarti”, gli dicevano.
“Quanti anni hai?”
“Ventisette, credo”, rispondeva lui.
“Alla tua età, dovresti quasi avere dei nipoti”, lo rimproveravano.
KHALED HOSSEINI - Mille splendidi soli (2007)

Mariam aveva cinque anni la prima volta che sentì la parola barami.
Accadde di giovedì, Doveva essere per forza un giovedì, perché ricordava di essersi sentita inquieta e pensierosa tutto il giorno, come le capitava di sentirsi soltanto di giovedì, il giorno in cui Jalil veniva a trovarla alla kolba. Per far passare il tempo sino al momento del suo arrivo, quando finalmente l'avrebbe visto salutare con la mano mentre attraversava la radura con l'erba alta sino al ginocchio, Mariam era salita su una sedia e aveva tirato giù il servizio da té cinese della madre, Nana. Il servizio da té era la sola reliquia che Nana conservasse della propria madre, morta quando lei aveva due anni. Custodiva con venerazione ciascuno dei pezzi di porcellana bianca e azzurra: la teiera dal becco elegantemente ricurvo, i fringuelli e i crisantemi dipinti a mano, sulla Zuccheriera il drago che doveva allontanare il malocchio.
Fu quest'ultimo pezzo che scivolò dalle dita di Manam andando in frantumi sulle assi di legno del pavimento della kolba.
Quando Nana vide la zuccheriera, si fece rossa in viso, il labbro superiore ebbe un tremito e gli occhi, sia quello buono che quello guasto, fissarono Mariam con uno sguardo inespressivo, immobile. Era così fuori di sé da far temere a Mariam che il jinn sarebbe entrato nuovamente nel corpo della madre. Ma il jinn non si presentò, non quella volta almeno. Nana, invece, afferrò Mariam per i polsi, se la tirò vicina e a denti stretti le disse: «Sei una piccola, goffa barami. Questa è la ricompensa per tutti i sacrifici che ho fatto per te. Rompere l'unica mia eredità, piccola goffa barami».
A quel tempo, Mariam non aveva afferrato. Non conosceva il significato della parola barami, bastardo. E non era abbastanza grande per rendersi conto dell'ingiustizia, per capire che la colpa era di chi aveva messo al mondo l'harami, non era il barami stesso, il cui solo peccato era di essere nato. Mariam aveva avuto il sospetto, dal modo in cui Nana aveva pronunciato la parola, che Vharami fosse una cosa brutta, schifosa, come un insetto, come gli scarafaggi che correvano veloci mentre Nana li copriva di maledizioni scopandoli fuori dalla kolba.
Crescendo, Mariam aveva capito. Era il modo in cui Nana proferiva la parola - sputandogliela in faccia – che l'offendeva nel profondo. Allora aveva compreso cosa voleva dire Nana, che un barami era qualcosa di indesiderato; che lei, Mariam, era una figlia illegittima che mai avrebbe potuto rivendicare di diritto le cose che gli altri possedevano, come l'amore, la famiglia, la casa, l'essere accettata.
GIULIA CARCASI - Io sono di legno (2007)
Questa storia comincia di domenica e non poteva cominciare in un altro giorno.
La domenica per te è un avanzo di settimana, per me è una zingara che fruga tra scatoloni e panni usati, che cerca roba ancora buona in mezzo a quello che è stato buttato via.
Credo che i migliori propositi si facciano di domenica. Credo che le guerre finiscano di domenica.
Credo che Ulisse sia tornato di domenica, dopo il ballo delle onde, è tornato a casa come torni tu, dopo il ballo delle onde, ogni domenica.
Per Penelope il suono del ritorno era il legno tosto di una zattera che si scontrava con la roccia del porto. E l'odore del ritorno era salsedine.
Per una madre il suono del ritorno sono tre giri di chiave, uno scatto, la porta che apri e chiudi. E l'odore del ritorno non è salsedine, no, è un profumo maschile che ti si è impigliato nei capelli, un profumo che ogni settimana cambi.
Vorrei incontrare quei colli schizzati di odori costosi, sapere che faccia hanno, come si chiamano, li conosco?, sapere come li baci, se hai del trasporto o se lo fai così, vorrei vedere come vai incontro a loro, se hai il passo deciso degli irresponsabili o se i tuoi piedi per un attimo si trattengono.
T'immagino tutto il sabato sera, Mia.
Immagino come diventi rossa quando un ragazzo ti chiede "come ti chiami?" e gli rispondi "fai tu. Giorgia, Sara, Chiara. Sono tutte le donne che vuoi" e sorridi, maliziosa come la mela che offre un morso.
Immagino finché ti vedo arrivare: le scarpe col tacco in mano, la borsa che pende dal polso, il mascara scivolato sotto l'occhio, brillantini ovunque. Sei una donna di ieri, non di oggi: ti porti addosso la notte prima.
È l'alba di una domenica dopo un sabato come tanti. Ti ha accompagnato a casa un ragazzo più grande di te, mi fa paura dire uomo, tu sei una bambina.
"Prendi il caffè?"
Fai cenno di sì con la testa.
Mi stringo la vestaglia addosso e mando indietro uno sbadiglio. Devo farti capire che sei al sicuro, fidati, parlami, verso il caffè in due tazzine, anche se il caffè proprio non mi va, siedo con te, bevo, sorrido, così si fa, dicono gli esperti.
"Dove sei stata?" ti chiedo, il tono costretto e calmo. "Che fai, indaghi?"
"No, dicevo per dire." "E allora non dire."
DIANE SETTERFIELD - La tredicesima storia (2007)

LA LETTERA
Era novembre. In cielo già abbuiava quando svoltai in Laundress Passage, anche se non era tardi.
Papà aveva concluso la sua giornata lavorativa, spento le luci del negozio e abbassato le saracinesche; per non farmi rientrare al buio, però, aveva lasciato accesa la luce delle scale che
conducevano all’appartamento.
Filtrava dal vetro del portoncino, proiettando sul marciapiede bagnato un pallido rettangolo grande quanto un foglio di carta, ed ero proprio su quel rettangolo, pronta a girare la chiave nella
toppa, quando vidi la lettera. Un altro rettangolo bianco, sul quinto gradino dal basso, dove non poteva sfuggirmi.
Chiusi il portoncino e misi la chiave del negozio al solito posto, dietro i Principi avanzati di geometria di Bailey. Povero Bailey. Erano trent’anni che nessuno voleva quel suo librone grigio. A
volte mi domando che effetto gli faccia essere il custode della chiave della libreria. Non doveva prospettarsi quel destino per il capolavoro che aveva impiegato due decenni a scrivere.
Una lettera. Per me. Quello sì che era un avvenimento. La busta, gonfiata dalle pieghe del voluminoso contenuto che increspavano gli angoli, recava l’indirizzo in una calligrafia che doveva aver
creato non pochi problemi al postino. Pur essendo una scrittura vecchio stile, tutta maiuscole e piena di svolazzi e ghirigori, sulle prime mi parve opera di un bambino. Sembrava la mano di un
inesperto. I tratti irregolari o sfumavano nel nulla o incidevano a fondo la carta. Non c’era fluidità nelle lettere che componevano il mio nome. Ciascuna era stata affrontata singolarmente – M A
R G A R E T L E A – come un’impresa nuova e scoraggiante. Io, però, non conoscevo bambini. Fu allora che pensai a un invalido.
Mi diede una strana sensazione. Il giorno prima o quello prima ancora, mentre io badavo ai fatti miei in silenzio e in privato, uno sconosciuto, un estraneo, si era preso la briga di scrivere il
mio nome su quella busta. Chi, a mia insaputa, aveva concentrato su di me l’attenzione?
Il soprabito e il cappello ancora indosso, mi sedetti sulle scale a leggere la lettera. (Non leggo mai se non ho la certezza di trovarmi in una posizione stabile. Questo da quando, all’età di
sette anni, leggendo The Water Babies seduta su un muretto piuttosto alto rimasi così sedotta dalla descrizione della vita subacquea da rilassare senza volerlo i muscoli. Ma, invece di
restare a galla sorretta dall’acqua che mi circondava così vivida nella mente, piombai in terra conciandomi proprio male. Se mi tocco sotto la frangetta sento ancora la cicatrice. Leggere può
essere pericoloso.)
Aprii la lettera e ne estrassi un fascio di cinque o sei pagine, tutte nella stessa calligrafia laboriosa.
Grazie al mio mestiere sono diventata un’esperta nella lettura dei manoscritti ostici. Dietro non ci sono grandi segreti. Pazienza e pratica: non ci vuole altro. Quelle, e la volontà di coltivare
un occhio interiore. Quando leggi un manoscritto deturpato dall’acqua, dal fuoco, dalla luce o semplicemente dagli anni, l’occhio deve studiare non solo la forma delle lettere ma anche altri
segni rivelatori. La velocità della penna. La pressione della mano sulla pagina. Interruzioni e riprese nel flusso della scrittura.
Devi rilassarti. Non pensare a niente. Finché non ti svegli in un sogno in cui sei una penna che svolazza sulla pergamena e la pergamena stessa, e ti senti solleticare in superficie
dall’inchiostro. A quel punto sei in grado di leggere. Gli intenti dello scrittore, i suoi pensieri, le esitazioni, i desideri e i significati reconditi. Sei in grado di leggere con estrema
chiarezza, quasi fossi la candela che illumina la pagina corsa dalla penna.
Non che quella lettera fosse particolarmente impegnativa. Esordiva con un laconico “Miss Lea”; da lì in poi i geroglifici assunsero presto forma di lettere, poi di parole, poi di frasi.
Ecco ciò che lessi:
Una volta ho rilasciato un’intervista al “Banbury Herald”. Farò bene a rispolverarla un giorno di questi, per la biografia. Mi mandarono uno strano tipo.
Un ragazzo. Alto come un uomo ma paffuto come un giovincello. Era impacciato nel vestito nuovo, un orribile completo marrone concepito per uno molto più avanti negli anni. Il collo, il taglio, la
stoffa: era tutto sbagliato. Il genere di vestito che una madre comprerebbe per il figlio fresco di diploma in vista del primo impiego, convinta che crescendo lo calzerà meglio. Ma ai ragazzi non
basta smettere l’uniforme scolastica per lasciarsi la giovinezza alle spalle.
DANIEL PENNAC - Diario di scuola (2007)
PRIMO: LA DISCARICA DI GIBUTI.
Statisticamente tutto si spiega, personalmente tutto si complica.
UNO.
Cominciamo dall'epilogo: la mamma, quasi centenaria, guarda un film su un autore che conosce bene. Si vede l'autore a casa sua, a Parigi, circondato dai suoi libri, nella sua biblioteca che è
anche il suo studio. La finestra dà sul cortile di una scuola. Baccano della ricreazione. Si viene a sapere che per un quarto di secolo l'autore ha esercitato la professione di insegnante e che
ha scelto questo appartamento affacciato sui cortili di due scuole un po' come un ferroviere che andasse in
pensione sopra una stazione di smistamento. Poi si vede l'autore in Spagna, in Italia, intento a chiacchierare con i suoi traduttori, a scherzare con gli amici veneziani, e sull'altopiano del
Vercors a camminare solitario nella foschia delle vette, parlando di lavoro, di lingua, stile, struttura romanzesca, personaggi...
Un altro studio, questa volta affacciato sull'incanto delle Alpi. Le scene sono inframmezzate da interviste ad artisti che l'autore ammira, e che parlano anch'essi del loro lavoro: il cineasta e
romanziere Dai Sijie, il disegnatore Sempé, il cantante
Thomas Fersen, il pittore Jùrg Kreienbùhl.
Ritorno a Parigi: l'autore davanti al suo computer, tra i suoi dizionari, questa volta. Ne ha la passione, dice. Veniamo peraltro a sapere, ed è la conclusione del film, che ci è entrato, nel
dizionario, il Robert, alla lettera P, alla voce Pennac, per esteso Pennacchioni, di nome Daniel.
La mamma, dunque, guarda questo film in compagnia di mio fratello Bernard, che l'ha registrato per lei. Lo guarda dall'inizio alla fine, immobile nella sua poltrona, con l'occhio fisso, senza
spiccicare parola, nella sera che scende.
Fine del film.
Titoli di coda.
Silenzio.
Poi, voltandosi lentamente verso Bernard, chiede: "Credi che se la caverà, prima o poi?".
NICHOLAS SPARKS - Ho cercato il tuo nome (2009)
Clayton e Thibault
Adesso che li vedeva da vicino, gli piacevano ancora meno. Sia lui sia il cane. Il vicesceriffo Keith Clayton non amava i pastori tedeschi e questo, sebbene se ne stesse tranquillo, gli ricordava
Panther, il cane poliziotto dell’agente Kenny Moore, quello addestrato ad attaccare all’inguine non appena riceveva l’ordine. Clayton considerava il collega un idiota, ma era l’essere più vicino
a un amico che avesse al dipartimento e doveva riconoscere che aveva un modo di raccontare gli assalti del cane alle parti intime dei sospettati che lo faceva piegare in due dalle risate. E di
sicuro Moore avrebbe apprezzato il gruppetto di bagnanti nudiste che lui aveva appena fatto sloggiare. C’erano un paio di studentesse che prendevano la tintarella integrale giù al torrente. Era
appostato da pochi minuti e aveva scattato solo qualche foto, quando una terza ragazza era saltata fuori da dietro le ortensie. Si era sbarazzato velocemente della macchina fotografica gettandola
nei cespugli alle sue spalle, era sbucato fuori dalla macchia e un istante dopo si era trovato faccia a faccia con la tipa.
«Ma bene, che cosa combiniamo qui?» aveva detto con voce strascicata, tanto per metterla sulla difensiva.
Non gli andava di essere stato beccato a spiare, né era contento della propria battuta d’esordio. Di solito era più brillante. Molto più brillante.
Per fortuna la ragazza era troppo imbarazzata e rischiò addirittura di inciampare indietreggiando. Balbettò qualche parola mentre cercava disperatamente di coprirsi con le mani.
Clayton non si preoccupò di distogliere lo sguardo. Sorrise, invece, fingendo di non notare il suo corpo, come se per lui fosse normale imbattersi in donne nude nel bosco. Aveva già capito che
non si era accorta della macchina fotografica.
«Calmati, ora. Che cosa stavate facendo?» chiese.
Lo sapeva perfettamente. Succedeva tutte le estati, specialmente in agosto: le studentesse universitarie, dirette al mare per un ultimo weekend di sole prima dell’inizio del semestre autunnale, a
volte facevano una deviazione su una vecchia strada dissestata utilizzata dai boscaioli che si inoltrava per un paio di chilometri nella foresta e approdava a una spiaggetta sassosa
diventata famosa come luogo di nudisti. Clayton ci faceva spesso un salto nella vaga speranza di lustrarsi la vista. Due settimane fa aveva visto sei bellezze; oggi ce n’erano tre, e quelle che
prima erano sdraiate a prendere il sole adesso stavano cercando di recuperare le magliette. Una di loro era un po’ pienotta, ma le altre due – compresa la brunetta che gli stava di fronte –
avevano un corpo da far girare la testa ai ragazzi delle confraternite. E anche ai poliziotti.
«Credevamo che non ci fosse nessuno! Pensavamo fosse un posto tranquillo!» Il suo viso aveva un’aria così innocente che gli venne voglia di dire: Chissà come sarebbe fiero il tuo paparino se
sapesse che cosa stava facendo la sua bambina. Lo divertiva immaginare la risposta di lei, ma siccome era in uniforme doveva esprimersi in modo ufficiale. E poi sapeva che stava sfidando la
sorte; se si fosse sparsa la voce che l’ufficio dello sceriffo pattugliava la zona, addio studentesse, e a questo non ci voleva pensare.
«Andiamo a parlare con le tue amiche.»
La seguì verso la spiaggetta, scrutandola con gusto mentre lei tentava invano di coprirsi. Una volta arrivati nella radura in riva al fiume, le sue amiche si erano già infilate le magliette. La
brunetta si mise a correre verso le altre e afferrò un asciugamano, rovesciando un paio di lattine di birra.
GIORGIO FALETTI - Io sono Dio (2009)
OTTO MINUTI
Inizio a camminare.
Cammino lento perché non ho bisogno di correre. Cammino lento
perché non voglio correre. Tutto è previsto, anche il tempo legato al mio passo. Ho calcolato che mi bastano otto minuti. Al polso ho un orologio da pochi dollari e un peso nella tasca della giacca. È una giacca in tela verde e sul davanti, sopra il taschino, sopra il cuore, una volta c'era una striscia cucita con un grado e un nome. Apparteneva a una persona il cui ricordo è sbiadito come se la sua custodia fosse stata affidata alla memoria autunnale di un vecchio. È rimasta solo una leggera traccia più chiara, un piccolo livido sul tessuto, sopravvissuto all'affronto di mille lavaggi quando qualcuno
chi?
perché?
ha strappato via quella striscia sottile e ha trasferito il nome prima su una tomba e poi nel nulla.
Adesso è una giacca e basta.
La mia giacca.
Ho deciso che la metterò ogni volta che uscirò per fare la mia breve
camminata di otto minuti. Passi che si perderanno come fruscii nel fragore di milioni di altri passi camminati ogni giorno in questa città. Minuti che si confonderanno come scherzi del tempo, stelle filanti senza colore, un fiocco di neve sul crinale che è l'unico a sapere di essere diverso da tutti gli altri.
Devo camminare otto minuti a un passo regolare per essere sicuro che il segnale radio abbia voce sufficiente per compiere il suo lavoro.
Ho letto da qualche parte che se il sole si spegnesse di colpo, la sua luce raggiungerebbe la terra ancora per otto minuti prima di precipitare tutto nel buio e nel freddo dell'addio.
D'un tratto mi ricordo di questa cosa e mi metto a ridere. Solo, in mezzo alla gente e al traffico, la testa levata al cielo, una bocca spalancata su un marciapiede di New York per la sorpresa di un satellite nello spazio, mi metto a ridere. Intorno a me persone si muovono e guardano quel tipo in piedi all'angolo di una strada che sta ridendo come un pazzo.
Qualcuno forse pensa che pazzo lo sia davvero.
Uno addirittura si ferma e per qualche istante si unisce alla mia risata, poi si rende conto che ride senza saperne il motivo. Rido fino alle lacrime per la incredibile e derisoria viltà del destino. Uomini hanno vissuto per pensare e altri non hanno potuto farlo per essere stati costretti alla sola incombenza di sopravvivere.
E altri a morire.
Un affanno senza remissione, un rantolo senza aria da salvare, un punto interrogativo da portare sulle spalle come il peso di una croce, perché la salita è una malattia che non finisce mai. Nessuno ha trovato il rimedio per il semplice motivo che il rimedio non c'è.
La mia è solo una proposta: otto minuti.
 CULTURA & SVAGO
CULTURA & SVAGO