INCIPIT DI LIBRI MENO RECENTI
In questa pagina leggeremo incipit di libri non recenti, su cui grava ancora il copyright perché gli autori sono deceduti dopo il 1942.
Non potendo offrirne la lettura completa, propongo l'incipit, perché spesso è sufficiente leggere le prime due pagine di un libro per valutarne le principali caratteristiche.
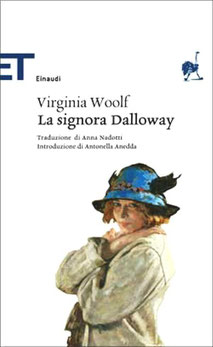
VIRGINIA WOOLF - Mrs Dalloway (1925)
La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comperati lei. Lucy ne aveva fin che ne voleva, del lavoro. C'era da levare le porte dai cardini; e per questo dovevano venire gli uomini di Rumpelmayer. "E che mattinata!" pensava Clarissa Dalloway " fresca, pare fatta apposta per dei bimbi su una spiaggia."
Che voglia matta di saltare! Così ella s'era sentita a Bourton: quando, col lieve cigolar di cardini che ancora le pareva di sentire, aveva spalancato le porte-finestre e s'era tuffata nell'aria aperta. Ma quanto più fresca e calma, e anche più silenziosa di questa era quell'altra aria, di buon mattino; come il palpito di un'onda; il bacio di un'onda; gelida e pungente eppure (per la fanciulla di diciott'anni ch'ella era allora) solenne: là alla finestra aperta, ella provava infatti un presagio di qualcosa di terribile ch'era lì lì per accadere; e guardava ai fiori, agli alberi ove s'annidavano spire di fumo, alle cornacchie che si libravano alte, e ricadevano; e rimaneva trasognata, fino a che udiva la voce di Peter Walsh: "Fate la poetica in mezzo ai cavoli?" - così aveva detto? - oppure: "Preferisco gli uomini ai cavolfiori" - aveva detto così? Doveva averlo detto una certa mattina a colazione, quando lei era uscita sul terrazzo... Peter Walsh! Sarebbe tornato dall'India quanto prima, a giugno o a luglio, ella non rammentava più, ché le sue lettere erano disastrosamente monotone.
Erano i suoi motti che vi si imprimevano in mente; i suoi occhi, il suo temperino, il suo sorriso, la
sua orsaggine e, quando milioni d'altre cose erano interamente svanite - strano davvero! - poche parole, come quelle
a proposito dei cavolfiori. In attesa che passasse il furgone di Durtnall, ella s'irrigidì un poco, sull'orlo del
marciapiede. Una donna graziosa, la giudicò Scrope Purvis (egli la conosceva come ci si conosce tra vicini di casa a Westminster); aveva in sé qualcosa di un uccellino, della gazza, un che di verdazzurro,
lieve, vivace, quantunque avesse varcato la cinquantina

ARCHIBALD CRONIN - E le stelle stanno a guardare (1935)
Il vento s'ingolfava gelido nelle crepe dei muri della casupola di due soli vani. Si udiva, lontano, il rantolo delle onde. Il resto era silenzio.
Immobile, Marta si teneva il piú possibile discosta da Roberto che aveva dato segni di irrequietezza, e tossito spasmodicamente, a tratti, durante la notte.
Stette ancora un minuto a giacere, arcigna, armandosi per affrontare quest'altra odiosa giornata, sforzandosi a soffocare il malanimo che sentiva contro di lui. Poi, a stento, si levò.
La pietra del pavimento sembrava ghiaccio sotto i suoi piedi nudi.
Si vestí alla svelta, con le mosse decise d'una donna robusta non ancor quarantenne. Tuttavia, come fu vestita, lo sforzo la lasciò ansante.
Non sentiva fame; strano che da qualche giorno in qua non sentisse piú fame! ma si sentiva debole, mortalmente
debole. Si trascinò verso l'acquaio, girò il rubinetto. Niente acqua: era gelata nella tubazione.
Si perse d'animo un istante; stette in piedi, premendo le palme callose sul ventre pregno, e lasciò lo sguardo vagare fuor dalla finestra verso l'alba esitante.
Sotto i suoi occhi, indistinte, le fila parallele delle case dei minatori.
Sulla destra, Sleescale, il paese, nero; e al di là il porto, con un unico lume, freddo; e poi il mare, piú freddo ancora.
Sulla sinistra la sagoma aspra della impalcatura sovrastante il pozzo n. 17 della Nettuno torreggiava come un patibolo, delineandosi entro il livido cielo di levante, dominando sul paese sul porto sul mare.
Sulla fronte di Marta il solco si fece piú profondo. Da tre mesi ormai durava lo sciopero.
Al tetro pensiero, ella voltò bruscamente le spalle alla finestra e cominciò ad accendere il fuoco. Non era facile accenderlo. Aveva solo qualche pezzo di legno umido, che ieri Sam aveva racimolato in terra qua e là, e un po' di carbonigia, della qualità pessima, che Ugo aveva raccolto sulle prode del pozzo. Si ribellava all'idea di doversi arrabattare con quei rifiuti lei Marta Fenwick, abituata, da sempre, ad usare la migliore qualità di carbone, abituata a un vero fuoco da minatori.
Riuscí tuttavia ad accenderlo, finalmente. Uscí nel cortile, ruppe, con un colpo vendicativo, il ghiaccio nella tinoza dell'acqua piovana, riempí la pentola, tornò e la mise a bollire. Non bolliva mai. Quando l'acqua fu calda, se ne riempí una tazza e si accosciò davanti al fuoco; tenendo la taza tra le due mani, prese a sorseggiare, lentamente.

WILLIAM FAULKNER - Luce d'agosto (1939)
Seduta sul ciglio della strada Lena guarda il carretto salire verso di lei, e pensa: "Vengo dall'Alabama.
Quanta strada! Tutto a piedi dall'Alabama, un bel pezzo di strada!".
Pensando al tempo stesso: "e sono già nel Mississippi dopo neanche un mese che cammino, più lontano da casa di quanto non sia mai stata, più lontano dalla segheria di Doane di quanto, dopo che ho fatto i dodici anni, non sia mai stata." Essa non sapeva nulla della segheria di Doane finché suo padre e sua madre non morirono, sebbene qualche volta il sabato, sei o sette volte in un anno, andasse col carretto in città vestita d'un vestitino da
"Magazzini Generali", coi piedi nudi spiaccicati contro il fondo del carretto e le scarpe, avvolte in un pezzo di carta, posate sul sedile accanto a lei. Metteva le scarpe al momento preciso che il carretto entrava in città.
E quando cominciò ad essere una ragazza grande chiedeva al padre di fermare il carretto, scendeva e continuava a piedi.
A suo padre non diceva per quale ragione volesse andare a piedi una volta entrata in città.
Egli pensava fosse per via delle strade lisce e dei marciapiedi.
Ma era per l'idea che, vedendola passare a piedi, la gente l'avrebbe creduta una della città anche lei.
Come ebbe dodici anni, suo padre e sua madre morirono, la stessa estate, in una casa di tronchi con tre vani e un ingresso senza imposte alle finestre né usci, in una stanza rischiarata da un lume a petrolio intorno al quale turbinavano gli insetti, il nudo impiantito reso liscio come vecchio argento dall'andare e venire dei piedi nudi.
Essa era la più giovane dei figli rimasti vivi.
Sua madre morì per la prima.
Prendi cura del vecchio disse.
Lena lo fece.
Quindi un giorno il padre le disse: Tu andrai alla segheria di Doane, con McKinley.
Tieniti pronta per quando viene.
Poi morì.
McKinley, il fratello, arrivò.
Il padre fu seppellito di pomeriggio, dietro una chiesa campestre in un bosco, ed ebbe un'asse di pino per lapide.

ARTHUR KOESTLER - Buio a mezzogiorno (1940)
La porta della cella si chiuse con un colpo secco alle spalle di Rubasciov.
Egli restò appoggiato con le spalle alla porta per qualche secondo, e accese una sigaretta. Sul lettuccio alla sua destra c'erano due coperte pulite e il pagliericcio era stato rinnovato di fresco. La catinella alla sua sinistra non aveva tappo, ma il foro di scarico funzionava. Il bugliolo accanto era stato appena disinfettato e non puzzava. Le pareti su ambo i lati erano di solidi mattoni, il che avrebbe attutito il suono di qualsiasi colpo contro il muro, ma là dove il tubo del riscaldamento e quello di scarico lo attraversavano, era stata data una mano di calce e in quel punto risuonava sonoro; inoltre lo stesso tubo del riscaldamento sembrava un buon conduttore del suono. La finestra aveva inizio all'altezza dell'occhio, così che si poteva guardare nel cortile senza doversi sollevare sospendendosi alle sbarre dell'inferriata. In questo campo tutto era a posto.
Rubasciov sbadigliò, si tolse la giacchetta e, arrotolatala, la pose sul pagliericcio a mo' di guanciale. Poi guardò nel cortile. La neve aveva uno scintillìo giallastro alla doppia luce della luna e delle lampade elettriche. Intorno al cortile lungo i muri, era stato aperto nella neve un angusto passaggio per la passeggiata quotidiana. L'alba non era ancora sorta; le stelle brillavano ancora lucenti e gelide, nonostante le lampade. Sul bastione del muro esterno, che si levava proprio davanti alla cella di Rubasciov, un soldato col moschetto abbassato andava avanti e indietro; batteva gli scarponi ad ogni passo come se si fosse trovato a sfilare in parata. Ogni tanto la luce giallastra delle lampade lampeggiava sulla sua baionetta.
Rubasciov si tolse le scarpe, sempre davanti alla finestra. Finì la sigaretta, ne buttò il mozzicone per terra ai piedi del suo lettuccio, e rimase seduto sul pagliericcio per alcuni minuti. Quindi tornò ancora alla finestra. Il cortile era immerso nella pace più profonda; la sentinella proprio in quell'istante si voltava per ritornare sui suoi passi; sopra la torretta della mitragliatrice il prigioniero vide una striscia della Via Lattea.
Rubasciov si coricò sul giaciglio, avvolgendosi nella prima coperta.
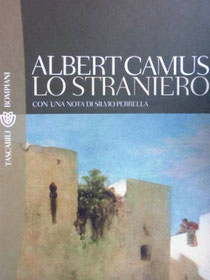
ALBERT CAMUS - Lo straniero (1942)
Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio: "Madre deceduta. Funerali domani. Distinti saluti". Questo non dice nulla: è stato forse ieri.
L'ospizio dei vecchi è a Marengo, a ottanta chilometri da Algeri. Prenderò l'autobus delle due e arriverò ancora nel pomeriggio. Così potrò vegliarla e essere di ritorno domani sera. Ho chiesto due giorni di libertà al principale e con una scusa simile non poteva dirmi di no. Ma non aveva l'aria contenta. Gli ho persino detto: "Non è colpa mia". Lui non mi ha risposto. Allora ho pensato che non avrei dovuto dirglielo. Insomma, non avevo da scusarmi di nulla. Stava a lui, piuttosto, di farmi le condoglianze. Ma certo lo farà dopodomani, quando mi vedrà in lutto. Per adesso è un po' come se la mamma non fosse morta; dopo il funerale, invece, sarà una faccenda esaurita e tutto avrà preso un andamento più ufficiale.
Ho preso l'autobus delle due: faceva molto caldo. Prima ho mangiato in trattoria, da Celeste, come al solito. Avevano tutti molta compassione per me e Celeste mi ha detto: "Di mamme ce n'è una sola". Quando ho fatto per andarmene, mi hanno accompagnato alla porta. Ero un po' intontito perché ero anche andato su da Emanuele a farmi prestare una cravatta nera e una benda per il braccio. Lui ha perso suo zio qualche mese fa.
Ho dovuto correre per non perdere l'autobus. La gran fretta, la corsa, certo è per questo, oltre alle scosse, all'odor di benzina, al riverbero della strada e del cielo, che presto mi sono assopito. Ho dormito quasi tutto il percorso. E quando mi sono svegliato ero addossato a un militare che mi ha sorriso e mi ha chiesto se venivo di lontano. Ho detto "Sì" per non dover più parlare.
L'ospizio è a due chilometri dal villaggio: ho fatto la strada a piedi. Volevo vedere subito la mamma, ma il portinaio mi ha detto che dovevo prima andare dal direttore. Siccome era occupato, ho atteso per un po' e intanto il portinaio non smetteva di parlare. Poi ho visto il direttore: mi ha ricevuto nel suo ufficio.

GEORGE ORWELL - La fattoria degli animali (Animal Farm, 1945)
Capitolo I
Il signor Jones, della Fattoria Padronale, serrò a chiave il pollaio per la notte, ma, ubriaco com'era, scordò di chiudere le finestrelle. Nel cerchio di luce della sua lanterna che danzava da una parte all'altra attraversò barcollando il cortile, diede un calcio alla porta retrostante la casa, da un bariletto nel retrocucina spillò un ultimo bicchiere di birra, poi si avviò su, verso il letto, dove la signora Jones già stava russando.
Non appena la luce nella stanza da letto si spense, tutta la fattoria fu un brusio, un'agitazione, uno sbatter d'ali. Durante il giorno era corsa voce che il Vecchio Maggiore, il verro Biancocostato premiato a tutte le esposizioni, aveva fatto la notte precedente un sogno strano che desiderava riferire agli altri animali. Era stato convenuto che si sarebbero tutti riuniti nel grande granaio, non appena il signor Jones se ne fosse andato sicuramente a dormire. Il Vecchio Maggiore (così era chiamato, benché fosse stato esposto con il nome di Orgoglio di Willingdon) godeva di così alta considerazione nella fattoria che ognuno era pronto a perdere un'ora di sonno per sentire quello che egli aveva da dire.
A un'estremità dell'ampio granaio, su una specie di piattaforma rialzata, il Vecchio Maggiore già stava affondando sul suo letto di paglia, sotto
una lanterna appesa a una trave. Aveva dodici anni e cominciava a divenire corpulento, ma era pur sempre un
maiale dall'aspetto maestoso, spirante saggezza e benevolenza, benché mai fosse stato castrato. In breve cominciarono a giungere gli altri animali e ognuno si accomodava a seconda della propria natura. Vennero primi i tre cani, Lilla,
Jessie e Morsetto, poi i porci che si adagiarono sulla paglia immediatamente davanti alla piattaforma, le
galline si appollaiarono sul davanzale delle finestre, i piccioni svolazzarono sulle travi, le pecore e le mucche si accovacciarono dietro ai maiali e cominciarono a ruminare. I due cavalli da tiro, Gondrano e Berta, arrivarono assieme, camminando
lenti e appoggiando cauti i loro ampi zoccoli pelosi per tema che qualche piccolo animale potesse trovarsi
nascosto nella paglia. Berta era una grossa, materna cavalla di mezza età che, dopo il quarto parto, non aveva più riacquistato la sua linea.

JACK KEROUAC - Sulla strada (1951)
Incontrai Dean per la prima volta dopo la separazione da mia moglie. Mi ero appena rimesso da una seria malattia della quale non vale la pena di parlare, se non perché aveva a che fare con quella separazione avvilente e penosa e con la sensazione di morte che si era impadronita di me. Con l’arrivo di Dean Moriarty cominciò quella parte della mia vita che si può chiamare la mia vita sulla strada. Prima di allora avevo spesso fantasticato di attraversare il Paese, ma erano sempre progetti vaghi, e non ero mai partito. Dean è il compagno perfetto per mettersi sulla strada, perché c’è addirittura nato, sulla strada, nel 1926, mentre i suoi genitori si trovavano a passare per Salt Lake City a bordo di una vecchia automobile sfiancata, diretti a Los Angeles. Le prime notizie su di lui le avevo avute da Chad King, che mi aveva mostrato certe sue lettere scritte da un riformatorio del New Mexico. Quelle lettere mi avevano fatto una forte impressione perché chiedevano a Chad King, con ingenuità e tenerezza, di insegnargli tutto quello che sapeva di Nietzsche e di tante altre meravigliose cose intellettuali. Non sapevo bene come, ma a un certo punto Carlo e io avevamo parlato di queste lettere e ci eravamo chiesti se avremmo mai conosciuto quello strano Dean Moriarty. Tutto questo succedeva tanto tempo fa, quando Dean non era com’è adesso, quando era un giovane carcerato avvolto nel mistero. Poi arrivò la notizia che Dean era uscito dal riformatorio e stava venendo a New York per la prima volta; si diceva che avesse appena sposato una ragazza di nome Marylou.
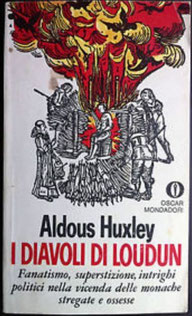
ALDOUS HUXLEY - I DIAVOLI DI LOUDUN (1952)
Capitolo 1
Fu nel 1605 che Joseph Hall, scrittore di satire e futuro vescovo, si recò per la prima volta nelle Fiandre.
Quante chiese demolite vedemmo lungo la strada, non erano rimasti che cumuli di macerie a dire al passante che vi erano state devozione e ostilità.
Oh, le dolorose impronte della guerra!...
Ma (con mia meraviglia) le chiese cadono e i collegi di gesuiti sorgono dovunque.
Non vi è città dove non vengano costruiti.
Da che cosa deriva ciò? Forse perché la devozione non è così necessaria come la politica? Questi uomini (come diciamo della volpe) si comportano meglio quando sono maltrattati.
Nessuno più insultato, nessuno più odiato, nessuno più contrastato dai nostri; eppure questa malerba cresce.
Crescevano per una ragione molto semplice e convincente: il pubblico li voleva.
Per i gesuiti, la "politica", come Hall e tutta la sua generazione sapevano benissimo, era il movente principale.
Le scuole erano state fondate allo scopo di rafforzare la Chiesa Cattolica contro i suoi nemici, "libertini" e protestanti.
I buoni padri sperarono, col loro insegnamento, di creare una classe di laici colti assolutamente devoti agli interessi della Chiesa.
Diceva Cerutti facendo andare in bestia l'indignato Michelet - come fasciamo le membra del bambino nella culla per dar loro le giuste proporzioni, così è necessario dalla prima fanciullezza fasciare, per così dire, la sua volontà in modo che egli conservi per tutta la vita una felice e salutare docilità.
Lo spirito di dominio era abbastanza forte ma la carne del metodo propagandistico era debole.
Nonostante la fasciatura della volontà, alcuni tra i migliori allievi dei gesuiti lasciarono la scuola per diventare liberi pensatori o perfino, come Jean Labadie, protestanti.
Per quanto riguardava la "politica", il sistema non fu così efficiente come i suoi creatori avevano sperato.
Ma l'interesse del pubblico non era per la politica, l'interesse del pubblico era per le buone scuole dove i ragazzi potessero apprendere tutto ciò che un gentiluomo doveva conoscere, e i gesuiti, meglio di qualsiasi altro fornitore di istruzione, soddisfacevano la domanda.
Che cosa notai durante i sette anni trascorsi sotto il tetto dei gesuiti? Una vita piena di moderazione, diligenza e ordine.
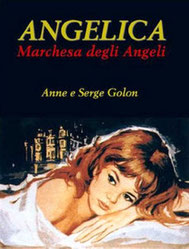
ANNE e SERGE GOLON - Angelica, marchesa degli angeli (1957)
«Nutrice», chiese Angelica, «perché Gilles di Retz uccideva tanti fanciulli?»
«Per il demonio, figlia mia. Gilles di Retz, l'orco di Machecoul, voleva essere il più potente signore del suo tempo. Nel suo castello non c'erano che storte, ampolle, pentole piene di rosse brode e di orrendi vapori. Il diavolo voleva che gli fosse offerto in sacrificio il cuore di un bambino. Così cominciarono i delitti. E le madri atterrite s'indicavano il nero torrione di Machecoul circondato di corvi, tanti erano nelle prigioni i cadaveri degli innocenti.»
«Li mangiava tutti?» chiese con voce tremante Maddalena, la sorellina di Angelica.
«Non tutti, non ce l'avrebbe fatta», rispose la nutrice. China sul paiolo dove cuocevano a lento fuoco il lardo e il cavolfiore, ella stette un po' in silenzio a rimestare la zuppa.
Ortensia, Angelica e la piccola Maddalena, le tre figlie del barone di Sancé di Monteloup, aspettavano con il cucchiaio pronto accanto alle scodelle, prese da angoscia, il seguito del racconto.
«Faceva di peggio», riprese infine la narratrice, con voce colma di rancore. «Dapprima, faceva portare dinanzi a sé il poverino (o la poveretta) che, terrorizzato, chiamava con gridi acuti la madre. Il signore, coricato su un letto, se la godeva un mondo di quella paura. Faceva poi attaccare il bambino al muro a una specie di forca che lo stringeva al petto e al collo soffocandolo, non però tanto da farlo morire. Il fanciullo si dibatteva come un pollo impiccato, le sue grida andavan soffocandosi, gli occhi gli uscivano dalla testa, diventava livido. E nel salone non si udivano che le risa di quegli uomini crudeli e i gemiti della piccola vittima. Allora, Gilles di Retz lo faceva staccare, se lo prendeva sulle ginocchia, appoggiava la fronte del povero angioletto contro il proprio petto. E parlava dolcemente, lo rassicurava: “Tutto ciò non aveva importanza”, diceva. “Avevano voluto divertirsi ma ora era finito. Il fanciullo avrebbe avuto zuccherini, un bel letto di piume, un costume di seta come quello dei paggi”. Il bambino si rassicurava. Una luce di gioia gli brillava nello sguardo pieno di lagrime. Allora, all'improvviso, il signore gli cacciava la daga nel collo. Ma le cose più terribili accadevano quando rapiva delle bambine.»

ALBERTO MORAVIA - La ciociara (1957)
Capitolo primo
Ah, i bei tempi di quando andai sposa e lasciai il mio paese per venire a Roma. La sapete la canzone:
Quando la ciociara si marita
a chi tocca lo spago e a chi la ciocia.
Ma io diedi tutto a mio marito, spago e ciocia, perché era mio marito e anche perché mi portava a Roma ed ero contenta di andarci e non sapevo che proprio a Roma mi aspettava la disgrazia. Avevo la faccia tonda, gli occhi neri, grandi e fissi, i capelli neri che mi crescevano fin quasi sugli occhi, stretti in due trecce fitte fitte simili a corde. Avevo la bocca rossa come il corallo e quando ridevo mostravo due file di denti bianchi, regolari e stretti. Ero forte allora e sul cercine, in bilico sulla testa, ero capace di portare fino a mezzo quintale. Mio padre e mia madre erano contadini, si sa, però mi avevano fatto un corredo come ad una signora, trenta di tutto: trenta lenzuola, trenta federe, trenta fazzoletti, trenta camicie, trenta mutande. Tutta roba fine, di lino pesante filato e tessuto a mano, dalla mamma stessa, al suo telaio, e alcune lenzuola ci avevano anche la parte che si vede tutta ricamata con molti ricami tanto belli. Avevo anche i coralli, di quelli che valgono di più, rosso scuro, la collana di coralli, le buccole d'oro e di coralli, un anello d'oro con un corallo, e persino una bella spilla anch'essa d'oro e di coralli. Oltre i coralli ci avevo alcuni oggetti d'oro, di famiglia, e avevo un medaglione da portare sul petto, con un cammeo tanto bello, nel quale si vedeva un pastorello con le sue pecore.
Mio marito aveva un negozietto di alimentari, in Trastevere, al vicolo del Cinque; e affittò un quartierino proprio sopra il negozio, tanto che sporgendomi dalla finestra della camera da letto potevo toccare con le dita l'insegna color sangue di bue su cui
c'era scritto "pane e pasta". Il quartierino aveva due finestre sul cortile e due sulla strada, erano
quattro stanzette in tutto, piccoline e basse, ma io le ammobiliai bene, un po' di mobili li comprammo a Campo di Fiori e un po' li avevamo, di famiglia. La camera da letto era tutta nuova, col letto matrimoniale di metallo dipinto
che imitava il legno e le testiere ornate di mazzolini e ghirlande; nel salotto ci misi un bel sofà coi
riccioloni di legno e la stoffa a fiorami, due poltroncine con la stessa stoffa e gli stessi riccioloni, un
tavolo tondo per mangiare, e una credenza per tenerci i piatti, tutti di porcellana fina quest'ultimi, col bordo d'oro e un disegno di frutta e fiori nel fondo.

FRANCOIS SAGAN - Bonjour tristesse (1957)
Esito ad apporre il nome, il bel nome grave di tristezza, sul sentimento così completo, così egoista che io quasi me ne vergogno mentre la tristezza mi è sempre parsa onorevole. Non conoscevo lei, ma la noia, il rimpianto, e più raramente i rimorsi. Oggi, qualcosa si ripiega su me come una seta snervante e dolce, e mi separa dagli altri.
In quell'estate avevo diciassette anni ed ero perfettamente felice. Gli «altri » erano mio padre ed Elsa, la sua amante. Bisogna che io spieghi subito quelli che possono apparire rapporti erronei. Mio padre aveva quarant'anni, e da quindici era vedovo; era un uomo giovane, pieno di vitalità, di possibilità; uscendo di collegio due anni prima io non avevo potuto fare a meno di capire che egli vivesse con una donna. Meno facilmente avevo ammesso che ne cambiasse una ogni sei mesi! Ma presto, il suo incanto, la vita nuova e facile, le mie stesse inclinazioni, mi condussero ad ammetterlo. Era un uomo frivolo, abile negli affari, sempre curioso, presto annoiato, e che piaceva alle donne. Non feci fatica ad amarlo, e teneramente, perché era buono, generoso, allegro, pieno di affetto per me. Non posso immaginare un amico migliore e più divertente.
Al principio dell'estate, spinse la sua amabilità sino a domandarmi se la compagnia d'Elsa, la sua amante del momento, mi sarebbe dispiaciuta durante le vacanze. Non potei che rassicurarlo su questo punto; conoscevo infatti il suo bisogno di donne e Elsa, d'altronde, non ci avrebbe dato nessuna noia. Era una ragazza alta, coi capelli rossi, metà bambina e metà mondana, che faceva la comparsa nei teatri di posa e nei bar dei Champs Elysées. Era simpatica, molto semplice e senza pretese di serietà.
D'altronde, mio padre e io eravamo troppo felici di andarcene per trovar da ridire contro qualcuno o qualcosa.
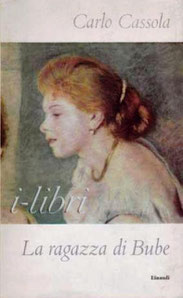
CARLO CASSOLA - La ragazza di Bube (Premio Strega 1960)
Capitolo 1
Mara sbadigliò. Era una bella noia essere costretta a stare in casa per colpa del fratello! Le venne in mente che avrebbe potuto lo stesso andarsene fuori: Vinicio si sarebbe messo a strillare, e la sera lo avrebbe raccontato "alla madre; ma lei avrebbe potuto sempre dire che non" era vero. E, dopo, gliele avrebbe anche date, a Vinicio. Le piacque talmente l'idea che le venne una gran voglia di farlo. Ma poi indugiò a guardarsi nello specchio ovale del cassettone. Si mise le mani sotto i capelli, per vedere come sarebbe stata se li avesse avuti gonfi. Il vetro era scheggiato per traverso, sì che non ci si poteva specchiar bene: la faccia non c'entrava tutta.
Dopo qualche minuto, scese in cucina.
« Dove vai? » le gridò dietro il fratello.
« Sto qui. Uggioso. »
« No, tu vai fuori » piagnucolò il fratello. Era incredibile la paura che aveva di restar solo.
« Non vado fuori. Sto qui ». Si era messa alla finestra.
La finestra dava su uno spiazzo tra le case. In fondo lo spiazzo si restringeva in una specie di vicolo, che immetteva nell'unica strada del paese. Mauro era seduto sullo scalino della casa di fronte.
« Ehi! Non ci sei andato a lavorare? » lo apostrofò Mara.
Mauro non rispose. Si alzò pigramente e attraversò il piazzale. I calzoni gli scivolavano lungo i fianchi magri, e ogni poco era costretto a tirarseli su.
« Vieni fuori » le disse.
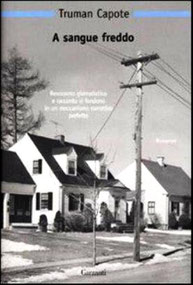
TRUMAN CAPOTE - A sangue freddo (1965)
CAPITOLO 1. GLI ULTIMI A VEDERLI VIVI.
Il villaggio di Holcomb si trova sulle alte pianure di grano del Kansas occidentale, una zona desolata che nel resto dello stato viene definita «laggiù.» Un centinaio di chilometri a est del confine del Colorado, il paesaggio, con i suoi duri cieli azzurri e l'aria limpida e secca, ha un'atmosfera più da Far West che da Middle West. L'accento locale ha pungenti risonanze di praterìa, una nasalità da bovari, e gli uomini, molti di loro, portano stretti pantaloni da cowboy, cappello a larghe tese e stivali con tacchi alti e punte aguzze. Il terreno è piatto e gli orizzonti paurosamente estesi; cavalli, mandrie di bestiame, un gruppo di silos bianchi che si elevano aggraziati come templi greci, sono visibili parecchio prima che il viaggiatore li raggiunga. Anche Holcomb può essere scorto da grandi distanze. Non che ci sia molto da vedere; solo un confuso agglomerato di costruzioni diviso al centro dai binari della Ferrovia Santa Fé, un borgo qualsiasi delimitato a sud da un tratto del fiume Arkansas (pronunciato Ar-kansas),' a nord da un'autostrada, la Route 50, a est e a ovest da praterie e campi di grano. Dopo una pioggia, o quando le nevi si sciolgono, le strade prive di nome, di ombra, di pavimentazione, passano dal polverone al fango. A un capo della cittadina si trova una vecchia costruzione spoglia, in calce, il cui tetto sorregge un'insegna elettrica: DANZE. ma il ballo è cessato da tempo e l'insegna è spenta da parecchi anni. Lì vicino c'è un'altra costruzione con un'inutile dicitura, in oro un po' sfaldato su una vetrina sporca: Banca di Holcomb. Ma la banca è fallita. nel 1933 e i suoi ex uffici contabili sono stati trasformati in appartamenti. E' uno dei due «condomini» della cittadina; il secondo è un palazzotto cadente conosciuto come il Professorato poiché vi abita buona parte del corpo insegnante della scuola locale. Ma la maggior parte delle case di Holcomb sono costruzioni di legno a un solo piano con una veranda sul davanti. Giù vicino alla stazione, la ricevitrice della posta, una donna scarna che porta una giacca di pelle, blue jeans e stivali da cowboy, presiede a uno sgangherato ufficio postale.
FREDERICK FORSYTH - Il giorno dello sciacallo (1971)
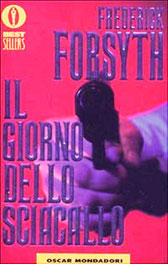
1
Fa freddo a Parigi, alle sei e quaranta di mattina in una giornata di marzo, e il freddo sembra ancora più intenso quando sta per essere giustiziato un uomo. L'11 marzo 1963, a quell'ora, nel cortile principale di Fort d'Ivry, un colonnello dell'aviazione francese era in piedi davanti a un palo conficcato nella ghiaia gelida e mentre gli legavano le mani fissava con incredulità sempre meno evidente il plotone di fronte a lui, a una ventina di metri. Un piede strisciò sui sassi, impercettibile sollievo alla tensione, nell'attimo in cui una benda veniva avvicinata agli occhi del tenente colonnello Jean-Marie Bastien-Thiry, a nascondergli definitivamente la luce.
Il mormorio del sacerdote fu il vano contrappunto al crepitare degli otturatori, quando i soldati caricarono e armarono i fucili.
Al di là del muro di cinta, un clacson insistente: un autocarro Berliet chiedeva strada a qualche veicolo più piccolo che lo intralciava nella sua corsa verso il centro della città. Il suono si spense lontano, confondendosi col «Puntate!» dell'ufficiale al comando del plotone. La scarica di fucileria, quando fu il momento, non provocò alcuna increspatura sulla superficie della città al risveglio; soltanto uno stormo di piccioni si levò in volo verso il cielo, per pochi attimi. L'eco del singolo coup-degrâce, qualche secondo più tardi, si perse nella crescente confusione del traffico al di là del muro.
La morte dell'ufficiale, capo di una banda di assassini della Organisation de l'Armée Secrète che avevano tentato di uccidere il Presidente francese, doveva significare una fine - la fine di ulteriori attentati alla vita del Presidente. Per uno scherzo del destino segnava invece un inizio, e per spiegarne la ragione è necessario spiegare prima perché un corpo crivellato di proiettili si trovasse, legato a un palo, nel cortile del carcere militare, a pochi chilometri da Parigi, in quella mattina di marzo...
Il sole era finalmente sparito dietro il palazzo, e lunghe ombre avanzavano strisciando sul cortile, apportatrici di gradito sollievo. Perfino alle sette di sera la giornata era stata la più calda dell'anno la temperatura si manteneva sui ventitré gradi.

Entrò nella mia vita nel febbraio del 1932 per non uscirne più. Da allora è passato più di un quarto di secolo, più di novemila giorni tediosi e senza scopo, che l'assenza della speranza ha reso tutti ugualmente vuoti - giorni e anni, molti dei quali morti come le foglie secche su un albero inaridito.
Ricordo il giorno e l'ora in cui il mio sguardo si posò per la prima volta sul ragazzo che doveva diventare la fonte della mia più grande felicità e della mia più totale disperazione. Fu due giorni dopo il mio compleanno, alle tre di uno di quei pomeriggi grigi e bui, caratteristici dell'inverno tedesco. Ero al Karl Alexander Gymnasium di Stoccarda, il liceo più famoso del Württemberg, fondato nel 1521, l'anno in cui Lutero comparve davanti a Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Spagna.
Ricordo ogni particolare: l'aula scolastica, con le panche e i banchi massicci, l'odore acre, muschioso, di quaranta pesanti cappotti invernali, le pozze di neve disciolta, i contorni bruno-giallastri sulle pareti grige in corrispondenza del punto in cui, prima della rivoluzione, erano appesi i ritratti del Kaiser Guglielmo e del re del Württemberg. Se chiudo gli occhi, riesco ancora a vedere le schiene dei miei compagni, molti dei quali sono morti nelle steppe della Russia o nelle sabbie di Alamein. Risento ancora la voce stanca e disillusa di Herr Zimmermann che, condannato all'insegnamento a vita, aveva accettato il suo destino con triste rassegnazione. Aveva il volto pallido e i capelli, i baffi e la barbetta a punta erano striati di grigio. Guardava il mondo attraverso gli occhiali a pince-nez che teneva appoggiati sulla punta del naso con l'espressione di un cane randagio in cerca di cibo. Anche se non doveva avere più di cinquant'anni, a noi pareva che ne avesse ottanta. Lo disprezzavamo perché era buono, gentile e aveva addosso l'odore dei poveri - molto probabilmente il suo appartamentino bicamere non era dotato di bagno - e anche perché in autunno e nei lunghi mesi invernali indossava un abito lustro, verdastro e rappezzato (possedeva un altro vestito, che portava in primavera e in estate). Lo trattavamo dall'alto in basso e, a volte, anche con crudeltà, la crudeltà codarda che i ragazzi in buona salute mostrano spesso nei confronti dei deboli, dei vecchi e degli indifesi.
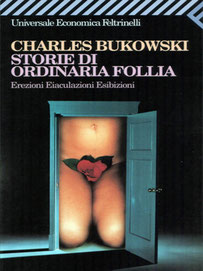
CHARLES BUKOWSKI - Storie di ordinaria follia (1972)
La più bella donna della città
Cass era la più giovane e la più bella di 5 sorelle. Cass era la più bella ragazza di tutta la città. Mezzindiana, aveva un corpo stranamente flessuoso, focoso era e come di serpente, con due occhi che proprio ci dicevano. Cass era fuoco fluido in movimento. Era come uno spirito incastrato in una forma che però non riusciva a contenerlo. I capelli castani e lunghi, i capelli di seta, si muovevano ondeggiando e vorticando come il corpo volteggiava. Non c'era via di mezzo per Cass. C'era anche chi diceva che era pazza. Gli imbecilli lo dicevano. Gli scemi non potevano capirla. Agli uomini in genere Cass pareva una macchina da fottere, e quindi non gliene fregava niente, fosse o non fosse pazza. E Cass ballava e civettava, si lasciava baciare dagli uomini ma, tranne qualche rara volta, quando si stava per venire al dunque, com'è come non è, Cass si eclissava, Cass aveva eluso gli uomini.
Le sorelle la accusavano di sprecare la sua bellezza, di non fare buon uso del suo cervello. Ma Cass ne aveva da vendere, di cervello e di spirito. Dipingeva, danzava, cantava, modellava la creta, e quando qualcuno era ferito, mortificato, nel corpo e nell'anima, Cass provava compassione per costui. Il suo cervello era, ecco, differente; la sua mentalità non era pratica, ecco quanto. Le sorelle eran gelose perché essa attraeva i loro uomini; ce l'avevano su con Cass perché, secondo loro, sciupava un sacco d'occasioni. Di solito Cass era gentile con quelli più brutti; i cosiddetti fusti non le dicevano niente. Le facevano schifo. "Senza nerbo," diceva, "senza grinta. Arrivano, alti in sella, con quei nasi ben fatti, quelle orecchie ben disegnate… Tutta esteriorità e niente dentro." La sua indole era affine alla pazzia; aveva un temperamento che certi chiamano pazzia.
Il padre era morto alcolizzato, la madre era scappata via di casa, abbandonando le figlie. Le ragazze si rivolsero a certi loro parenti, che la misero in convento. Il convento era un posto molto triste, più per Cass che per le sorelle. Le altre ragazze erano gelose di Cass e a Cass toccava litigare sempre. Aveva segni di rasoiate sul braccio sinistro, in conseguenza di quelle baruffe. Poi aveva una cicatrice permanente sulla guancia sinistra, ma lo sfregio anziché diminuirla sembrava accrescere la sua bellezza.
Io l'incontrai al West End Bar poco dopo ch'era venuta via dal convento. Essendo la più giovane delle sorelle, era venuta via per ultima. Quella sera entrò là e, semplicemente, si venne a sedere vicino a me, Io ero forse l'uomo più brutto della città, e magari questo avrà influito in qualche modo.
"Bevi?" le domandai.
"Ma sicuro, come no?"
Non ci dicemmo niente di straordinario, mi sa, quella sera; ma contava l'impressione che lei dava. Cass aveva scelto me e questo era quanto. Nessuna
forzatura. Bere le piaceva e così fece molti bis. Non credo fosse ancora maggiorenne, però lì la servivano lo stesso. Magari aveva
una carta d'identità falsa, chi lo sa.
 CULTURA & SVAGO
CULTURA & SVAGO