INCIPIT DI LIBRI dal 1950 al 1962
INVITO ALLA LETTURA
In questa pagina leggeremo incipit di libri classici dell'800 e del '900. Propongo questi incipit come invito alla lettura delle opere.
JACK KEROUAC - Sulla strada (1951)
Aldous Huxley - I diavoli di Loudun (1952)
J.R.R. Tolkien - Il signore degli anelli. Trilogia( 1956)
Truman Capote - A sangue freddo (1956)
Anne e Serge Golon - Angelica marchesa degli angeli (1957)
Alberto Moravia - La ciociara (1957)
François Sagan - Bonjour tristesse (1957)
Carlo Cassola - La ragazza di Bube (1960)
Anthony Burgess - Arancia meccanica (1962)
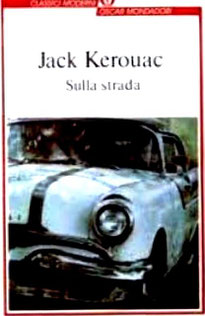
JACK KEROUAC - Sulla strada (1951)*
Incontrai Dean per la prima volta dopo la separazione da mia moglie. Mi ero appena rimesso da una seria malattia della quale non vale la pena di parlare, se non perché aveva a che fare con quella separazione avvilente e penosa e con la sensazione di morte che si era impadronita di me. Con l’arrivo di Dean Moriarty cominciò quella parte della mia vita che si può chiamare la mia vita sulla strada. Prima di allora avevo spesso fantasticato di attraversare il Paese, ma erano sempre progetti vaghi, e non ero mai partito. Dean è il compagno perfetto per mettersi sulla strada, perché c’è addirittura nato, sulla strada, nel 1926, mentre i suoi genitori si trovavano a passare per Salt Lake City a bordo di una vecchia automobile sfiancata, diretti a Los Angeles. Le prime notizie su di lui le avevo avute da Chad King, che mi aveva mostrato certe sue lettere scritte da un riformatorio del New Mexico. Quelle lettere mi avevano fatto una forte impressione perché chiedevano a Chad King, con ingenuità e tenerezza, di insegnargli tutto quello che sapeva di Nietzsche e di tante altre meravigliose cose intellettuali. Non sapevo bene come, ma a un certo punto Carlo e io avevamo parlato di queste lettere e ci eravamo chiesti se avremmo mai conosciuto quello strano Dean Moriarty. Tutto questo succedeva tanto tempo fa, quando Dean non era com’è adesso, quando era un giovane carcerato avvolto nel mistero. Poi arrivò la notizia che Dean era uscito dal riformatorio e stava venendo a New York per la prima volta; si diceva che avesse appena sposato una ragazza di nome Marylou.
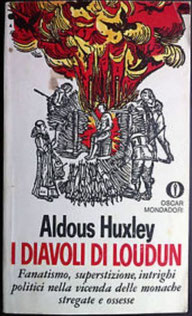
ALDOUS HUXLEY - I DIAVOLI DI LOUDUN (1952)*
Capitolo 1
Fu nel 1605 che Joseph Hall, scrittore di satire e futuro vescovo, si recò per la prima volta nelle Fiandre.
Quante chiese demolite vedemmo lungo la strada, non erano rimasti che cumuli di macerie a dire al passante che vi erano state devozione e ostilità.
Oh, le dolorose impronte della guerra!...
Ma (con mia meraviglia) le chiese cadono e i collegi di gesuiti sorgono dovunque.
Non vi è città dove non vengano costruiti.
Da che cosa deriva ciò? Forse perché la devozione non è così necessaria come la politica? Questi uomini (come diciamo della volpe) si comportano meglio quando sono maltrattati.
Nessuno più insultato, nessuno più odiato, nessuno più contrastato dai nostri; eppure questa malerba cresce.
Crescevano per una ragione molto semplice e convincente: il pubblico li voleva.
Per i gesuiti, la "politica", come Hall e tutta la sua generazione sapevano benissimo, era il movente principale.
Le scuole erano state fondate allo scopo di rafforzare la Chiesa Cattolica contro i suoi nemici, "libertini" e protestanti.
I buoni padri sperarono, col loro insegnamento, di creare una classe di laici colti assolutamente devoti agli interessi della Chiesa.
Diceva Cerutti facendo andare in bestia l'indignato Michelet - come fasciamo le membra del bambino nella culla per dar loro le giuste proporzioni, così è necessario dalla prima fanciullezza fasciare, per così dire, la sua volontà in modo che egli conservi per tutta la vita una felice e salutare docilità.
Lo spirito di dominio era abbastanza forte ma la carne del metodo propagandistico era debole.
Nonostante la fasciatura della volontà, alcuni tra i migliori allievi dei gesuiti lasciarono la scuola per diventare liberi pensatori o perfino, come Jean Labadie, protestanti.
Per quanto riguardava la "politica", il sistema non fu così efficiente come i suoi creatori avevano sperato.
Ma l'interesse del pubblico non era per la politica, l'interesse del pubblico era per le buone scuole dove i ragazzi potessero apprendere tutto ciò che un gentiluomo doveva conoscere, e i gesuiti, meglio di qualsiasi altro fornitore di istruzione, soddisfacevano la domanda.
Che cosa notai durante i sette anni trascorsi sotto il tetto dei gesuiti? Una vita piena di moderazione, diligenza e ordine.
J.R.R. TOLKIEN - IL SIGNORE DEGLI ANELLI. TRILOGIA (The Lord Of The Rings, 1956) *
PROLOGO
1
A proposito degli Hobbit
Questo libro riguarda principalmente gli Hobbit, e dalle sue pagine il lettore imparerà molto sul loro carattere e un po' della loro storia; ulteriori informazioni potranno trovarsi nel Libro
Rosso dei Confini Occidentali, già pubblicato col titolo di Lo Hobbit. Questa storia è tratta dai più antichi capitoli del Libro Rosso, scritti da Bilbo in persona, il primo Hobbit divenuto
famoso nel resto del mondo, e da lui intitolati Andata e Ritorno poiché narravano il suo viaggio verso l'Est e il ritorno a casa. Fu questa un'avventura che avrebbe più tardi coinvolto tutti gli
Hobbit nei grandi avvenimenti di un'Era di cui parleremo.
Molti, comunque, desidererebbero saperne di più su questo popolo primordiale, e per questi lettori ho annotato qui i punti essenziali della tradizione hobbit e riassunto le sue prime
vicende.
Il popolo hobbit è discreto e modesto, ma di antica origine, meno numeroso oggi che nel passato; amante della pace, della calma e della terra ben coltivata, il suo asilo preferito era una
campagna scrupolosamente ordinata e curata. Ora come allora, essi non capiscono e non amano macchinari più complessi del soffietto del fabbro, del mulino ad acqua o del telaio a mano, quantunque
abilissimi nel maneggiare attrezzi di ogni tipo. Anche in passato erano estremamente timidi; ora, poi, evitano addirittura con costernazione «la Gente Alta», come ci chiamano, ed è diventato
difficilissimo trovarli. Hanno una vista ed un udito particolarmente acuti, e benché tendano ad essere grassocci e piuttosto pigri, sono agili e svelti nei movimenti. Sin dal principio
possedevano l'arte di sparire veloci e silenziosi al sopraggiungere di genti che non desideravano incontrare, ma ora quest'arte l'hanno talmente perfezionata, che agli Uomini può sembrare quasi
magica. Gli Hobbit, invece, non hanno mai effettivamente studiato alcun tipo di magia; e quella loro rara dote è unicamente dovuta ad una abilità professionale che l'eredità, la pratica, e
un'amicizia molto intima con la terra hanno reso inimitabile da parte di razze più grandi e goffe.
Essi sono infatti minuscoli; anche i più alti fra loro sono più piccoli dei Nani, sebbene meno tozzi e robusti. La loro statura è variabile, ed oscilla da un braccio a un braccio e mezzo; ma
ormai è raro che qualcuno arrivi a quella misura, giacché pare che col tempo si siano rimpiccioliti e che in passato fossero più alti. Secondo quanto riferisce il Libro Rosso, Brando-bras Tuc
(Ruggibrante), figlio di Isengrim Secondo, misurava due braccia ed era capace di montare a cavallo. Il suo record fu battuto in tutta la storia hobbit da altri due personaggi soltanto; ma di
questo parleremo in seguito.
Per quanto riguarda gli Hobbit della Contea, di cui tratta questo nostro racconto, essi erano, nei tempi di pace e di benessere, un popolo allegro e spensierato; portavano vestiti di colori
vivaci, preferendo il giallo ed il verde, ma calzavano raramente scarpe, essendo i loro piedi ricoperti di un pelo riccio, folto e castano come i loro capelli, e le piante dure e callose come
suole. Perciò l'unica forma di artigianato che praticassero poco era la fabbricazione di calzature, benché avessero lunghe dita abilissime, capaci di creare tanti altri oggetti utili ed
artistici. Più che belli, i loro visi erano generalmente gioviali, illuminati da occhi vivacissimi e guance colorite, con una bocca fatta per ridere, bere e mangiare. Ed era proprio ciò che
facevano: mangiavano, bevevano e ridevano con tutto il cuore, amavano fare a tutte le ore scherzi infantili, e pranzavano sei volte al giorno, quando ne avevano la possibilità. Erano ospitali:
feste e regali, che offrivano con grande generosità ed accettavano con entusiasmo, costituivano il loro massimo divertimento.
La parentela che ci unisce agli Hobbit, malgrado la loro recente ostilità, è più che evidente e molto più stretta che non quella che ci unisce agli Elfi o persino ai Nani. In tempi lontani parlavano le lingue degli Uomini, a modo loro, ed avevano le stesse preferenze e le stesse antipatie. Quale sia però la nostra esatta parentela, ormai nessuno lo può più dire: gli albori della civiltà hobbit sono persi nei Tempi Remoti caduti nell'oblio; solamente gli Elfi conservano ancora ricordi di quel tempo che fu, ma sono solo ricordi della loro propria storia, ove gli Uomini hanno poco posto e gli Hobbit niente del tutto. Eppure è un fatto che gli Hobbit siano vissuti tranquilli e pacifici nella Terra di Mezzo per anni e anni prima che gli altri popoli si accorgessero della loro presenza; e, dato che il mondo è pieno zeppo di strane creature, questi piccoli esseri sembravano ben poco importanti.

ANNE e SERGE GOLON - Angelica, marchesa degli angeli (1957)*
«Nutrice», chiese Angelica, «perché Gilles di Retz uccideva tanti fanciulli?»
«Per il demonio, figlia mia. Gilles di Retz, l'orco di Machecoul, voleva essere il più potente signore del suo tempo. Nel suo castello non c'erano che storte, ampolle, pentole piene di rosse brode e di orrendi vapori. Il diavolo voleva che gli fosse offerto in sacrificio il cuore di un bambino. Così cominciarono i delitti. E le madri atterrite s'indicavano il nero torrione di Machecoul circondato di corvi, tanti erano nelle prigioni i cadaveri degli innocenti.»
«Li mangiava tutti?» chiese con voce tremante Maddalena, la sorellina di Angelica.
«Non tutti, non ce l'avrebbe fatta», rispose la nutrice. China sul paiolo dove cuocevano a lento fuoco il lardo e il cavolfiore, ella stette un po' in silenzio a rimestare la zuppa.
Ortensia, Angelica e la piccola Maddalena, le tre figlie del barone di Sancé di Monteloup, aspettavano con il cucchiaio pronto accanto alle scodelle, prese da angoscia, il seguito del racconto.
«Faceva di peggio», riprese infine la narratrice, con voce colma di rancore. «Dapprima, faceva portare dinanzi a sé il poverino (o la poveretta) che, terrorizzato, chiamava con gridi acuti la madre. Il signore, coricato su un letto, se la godeva un mondo di quella paura. Faceva poi attaccare il bambino al muro a una specie di forca che lo stringeva al petto e al collo soffocandolo, non però tanto da farlo morire. Il fanciullo si dibatteva come un pollo impiccato, le sue grida andavan soffocandosi, gli occhi gli uscivano dalla testa, diventava livido. E nel salone non si udivano che le risa di quegli uomini crudeli e i gemiti della piccola vittima. Allora, Gilles di Retz lo faceva staccare, se lo prendeva sulle ginocchia, appoggiava la fronte del povero angioletto contro il proprio petto. E parlava dolcemente, lo rassicurava: “Tutto ciò non aveva importanza”, diceva. “Avevano voluto divertirsi ma ora era finito. Il fanciullo avrebbe avuto zuccherini, un bel letto di piume, un costume di seta come quello dei paggi”. Il bambino si rassicurava. Una luce di gioia gli brillava nello sguardo pieno di lagrime. Allora, all'improvviso, il signore gli cacciava la daga nel collo. Ma le cose più terribili accadevano quando rapiva delle bambine.»
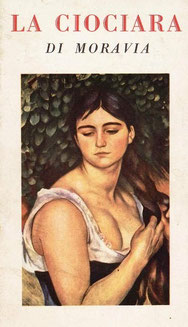
ALBERTO MORAVIA - La ciociara (1957)*
Capitolo primo
Ah, i bei tempi di quando andai sposa e lasciai il mio paese per venire a Roma. La sapete la canzone:
Quando la ciociara si marita
a chi tocca lo spago e a chi la ciocia.
Ma io diedi tutto a mio marito, spago e ciocia, perché era mio marito e anche perché mi portava a Roma ed ero contenta di andarci e non sapevo che proprio a Roma mi aspettava la disgrazia. Avevo la faccia tonda, gli occhi neri, grandi e fissi, i capelli neri che mi crescevano fin quasi sugli occhi, stretti in due trecce fitte fitte simili a corde. Avevo la bocca rossa come il corallo e quando ridevo mostravo due file di denti bianchi, regolari e stretti. Ero forte allora e sul cercine, in bilico sulla testa, ero capace di portare fino a mezzo quintale. Mio padre e mia madre erano contadini, si sa, però mi avevano fatto un corredo come ad una signora, trenta di tutto: trenta lenzuola, trenta federe, trenta fazzoletti, trenta camicie, trenta mutande. Tutta roba fine, di lino pesante filato e tessuto a mano, dalla mamma stessa, al suo telaio, e alcune lenzuola ci avevano anche la parte che si vede tutta ricamata con molti ricami tanto belli. Avevo anche i coralli, di quelli che valgono di più, rosso scuro, la collana di coralli, le buccole d'oro e di coralli, un anello d'oro con un corallo, e persino una bella spilla anch'essa d'oro e di coralli. Oltre i coralli ci avevo alcuni oggetti d'oro, di famiglia, e avevo un medaglione da portare sul petto, con un cammeo tanto bello, nel quale si vedeva un pastorello con le sue pecore.
Mio marito aveva un negozietto di alimentari, in Trastevere, al vicolo del Cinque; e affittò un quartierino proprio sopra il negozio, tanto che sporgendomi dalla finestra della camera da letto potevo toccare con le dita l'insegna color sangue di bue su cui
c'era scritto "pane e pasta". Il quartierino aveva due finestre sul cortile e due sulla strada, erano
quattro stanzette in tutto, piccoline e basse, ma io le ammobiliai bene, un po' di mobili li comprammo a Campo di Fiori e un po' li avevamo, di famiglia. La camera da letto era tutta nuova, col letto matrimoniale di metallo dipinto
che imitava il legno e le testiere ornate di mazzolini e ghirlande; nel salotto ci misi un bel sofà coi
riccioloni di legno e la stoffa a fiorami, due poltroncine con la stessa stoffa e gli stessi riccioloni, un
tavolo tondo per mangiare, e una credenza per tenerci i piatti, tutti di porcellana fina quest'ultimi, col bordo d'oro e un disegno di frutta e fiori nel fondo.
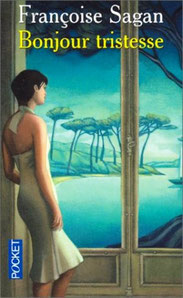
FRANCOIS SAGAN - Bonjour tristesse (1957)*
Esito ad apporre il nome, il bel nome grave di tristezza, sul sentimento così completo, così egoista che io quasi me ne vergogno mentre la tristezza mi è sempre parsa onorevole. Non conoscevo lei, ma la noia, il rimpianto, e più raramente i rimorsi. Oggi, qualcosa si ripiega su me come una seta snervante e dolce, e mi separa dagli altri.
In quell'estate avevo diciassette anni ed ero perfettamente felice. Gli «altri » erano mio padre ed Elsa, la sua amante. Bisogna che io spieghi subito quelli che possono apparire rapporti erronei. Mio padre aveva quarant'anni, e da quindici era vedovo; era un uomo giovane, pieno di vitalità, di possibilità; uscendo di collegio due anni prima io non avevo potuto fare a meno di capire che egli vivesse con una donna. Meno facilmente avevo ammesso che ne cambiasse una ogni sei mesi! Ma presto, il suo incanto, la vita nuova e facile, le mie stesse inclinazioni, mi condussero ad ammetterlo. Era un uomo frivolo, abile negli affari, sempre curioso, presto annoiato, e che piaceva alle donne. Non feci fatica ad amarlo, e teneramente, perché era buono, generoso, allegro, pieno di affetto per me. Non posso immaginare un amico migliore e più divertente.
Al principio dell'estate, spinse la sua amabilità sino a domandarmi se la compagnia d'Elsa, la sua amante del momento, mi sarebbe dispiaciuta durante le vacanze. Non potei che rassicurarlo su questo punto; conoscevo infatti il suo bisogno di donne e Elsa, d'altronde, non ci avrebbe dato nessuna noia. Era una ragazza alta, coi capelli rossi, metà bambina e metà mondana, che faceva la comparsa nei teatri di posa e nei bar dei Champs Elysées. Era simpatica, molto semplice e senza pretese di serietà.
D'altronde, mio padre e io eravamo troppo felici di andarcene per trovar da ridire contro qualcuno o qualcosa.

CARLO CASSOLA - La ragazza di Bube (Premio Strega 1960)*
Capitolo 1
Mara sbadigliò. Era una bella noia essere costretta a stare in casa per colpa del fratello! Le venne in mente che avrebbe potuto lo stesso andarsene fuori: Vinicio si sarebbe messo a strillare, e la sera lo avrebbe raccontato "alla madre; ma lei avrebbe potuto sempre dire che non" era vero. E, dopo, gliele avrebbe anche date, a Vinicio. Le piacque talmente l'idea che le venne una gran voglia di farlo. Ma poi indugiò a guardarsi nello specchio ovale del cassettone. Si mise le mani sotto i capelli, per vedere come sarebbe stata se li avesse avuti gonfi. Il vetro era scheggiato per traverso, sì che non ci si poteva specchiar bene: la faccia non c'entrava tutta.
Dopo qualche minuto, scese in cucina.
« Dove vai? » le gridò dietro il fratello.
« Sto qui. Uggioso. »
« No, tu vai fuori » piagnucolò il fratello. Era incredibile la paura che aveva di restar solo.
« Non vado fuori. Sto qui ». Si era messa alla finestra.
La finestra dava su uno spiazzo tra le case. In fondo lo spiazzo si restringeva in una specie di vicolo, che immetteva nell'unica strada del paese. Mauro era seduto sullo scalino della casa di fronte.
« Ehi! Non ci sei andato a lavorare? » lo apostrofò Mara.
Mauro non rispose. Si alzò pigramente e attraversò il piazzale. I calzoni gli scivolavano lungo i fianchi magri, e ogni poco era costretto a tirarseli su.
« Vieni fuori » le disse.
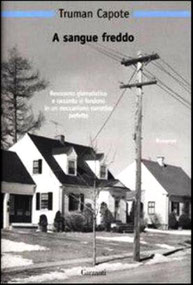
TRUMAN CAPOTE - A sangue freddo (1965) no
CAPITOLO 1. GLI ULTIMI A VEDERLI VIVI.
Il villaggio di Holcomb si trova sulle alte pianure di grano del Kansas occidentale, una zona desolata che nel resto dello stato viene definita «laggiù.» Un centinaio di chilometri a est del confine del Colorado, il paesaggio, con i suoi duri cieli azzurri e l'aria limpida e secca, ha un'atmosfera più da Far West che da Middle West. L'accento locale ha pungenti risonanze di praterìa, una nasalità da bovari, e gli uomini, molti di loro, portano stretti pantaloni da cowboy, cappello a larghe tese e stivali con tacchi alti e punte aguzze. Il terreno è piatto e gli orizzonti paurosamente estesi; cavalli, mandrie di bestiame, un gruppo di silos bianchi che si elevano aggraziati come templi greci, sono visibili parecchio prima che il viaggiatore li raggiunga. Anche Holcomb può essere scorto da grandi distanze. Non che ci sia molto da vedere; solo un confuso agglomerato di costruzioni diviso al centro dai binari della Ferrovia Santa Fé, un borgo qualsiasi delimitato a sud da un tratto del fiume Arkansas (pronunciato Ar-kansas),' a nord da un'autostrada, la Route 50, a est e a ovest da praterie e campi di grano. Dopo una pioggia, o quando le nevi si sciolgono, le strade prive di nome, di ombra, di pavimentazione, passano dal polverone al fango. A un capo della cittadina si trova una vecchia costruzione spoglia, in calce, il cui tetto sorregge un'insegna elettrica: DANZE. ma il ballo è cessato da tempo e l'insegna è spenta da parecchi anni. Lì vicino c'è un'altra costruzione con un'inutile dicitura, in oro un po' sfaldato su una vetrina sporca: Banca di Holcomb. Ma la banca è fallita. nel 1933 e i suoi ex uffici contabili sono stati trasformati in appartamenti. E' uno dei due «condomini» della cittadina; il secondo è un palazzotto cadente conosciuto come il Professorato poiché vi abita buona parte del corpo insegnante della scuola locale. Ma la maggior parte delle case di Holcomb sono costruzioni di legno a un solo piano con una veranda sul davanti. Giù vicino alla stazione, la ricevitrice della posta, una donna scarna che porta una giacca di pelle, blue jeans e stivali da cowboy, presiede a uno sgangherato ufficio postale.
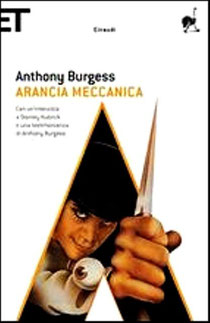
STANLEY KUBRICK - Arancia meccanica (1962)*
1'
- Allora che si fa, eh?
C'ero io, cioè Alex, e i miei tre soma, cioè Pete, Georgie, e Bamba, Bamba perché era davvero bamba, e si stava al Korova Milkbar a rovellarci il cardine su come passare la serata, una sera buia
fredda bastarda d'inverno, ma asciutta.
Il Korova era un sosto di quelli col latte corretto e forse, O fratelli, vi siete scordati di com'erano questi sosti, con le cose che cambiano allampo oggigiorno e tutti che le scordano svelti, e
i giornali che nessuno nemmeno li legge.
Non avevano la licenza per i liquori, ma non c'era ancora una legge contro l'aggiunta di quelle trucche nuove che si sbattevano dentro il vecchio mommo, così lo potevi glutare con la sintemesc o
la drenacrom o il vellocet o un paio d'altre robette che ti davano un quindici minuti tranquilli tranquilli di cinebrivido stando ad ammirare Zio e Tutti gli Angeli e i Santi nella tua scarpa
sinistra con le luci che ti scoppiavano dappertutto dentro il planetario.
O potevi glutare il latte coi coltelli dentro, come si diceva, e questo ti rendeva sviccio e pronto per un po' di porco diciannove, ed è proprio quel che si glutava la sera in cui sto cominciando
questa storia.
Si aveva le tasche piene di denghi e così non c'era proprio una gran necessità, dal punto di vista caccia alla bella maria, di festare qualche vecchio poldo in un vicolo e locchiarlo nuotar nel
sangue mentre noi si faceva la conta dell'incasso e lo si divideva per quattro, né di fare gli ultraviolenti con qualche tremante semprocchia in un negozio e poi alzare il tacco col budellame
della cassa.
Ma, come dicono, il denaro non è tutto.
Noi quattro eravamo tappati all'estremo grido della moda, che in quei giorni era un paio di braghe attillatissime col vecchio stampo da budino, come lo chiamavamo, stretto nell'inforcatura sotto
le cosce, e questo serviva a proteggere e formava anche una specie di disegno che sotto certe luci potevi locchiarlo abbastanza chiaramente, e così io ne avevo uno a forma di ragno, Pete aveva
una granfia, cioè una mano, Georgie ce l'aveva molto stravagante di un fiore, e il povero vecchio Bamba ne aveva uno molto mielestrazio con una biffa, cioè faccia, di clown, perché Bamba non
capiva mai bene le cose ed era, oltre ogni ombra di dubitante, il più bamba di noi quattro.
Poi portavamo delle giacche strettine senza risvolti ma con quelle spallone molto imbottite ("mestole", le chiamavamo) che erano una specie di presa in giro di chi aveva le spalle fatte in quel
modo.
Poi, fratelli miei, si aveva di quelle cravatte bianchicce che parevano purea di cartoffel con una specie di disegno fatto su con una forchetta. I capelli non li portavamo molto lunghi, e si
aveva degli ultrastivali molto cinebrivido per menar calci.
- Allora che si fa, eh?
C'erano tre mammole sedute insieme al banco, ma noi malcichi eravamo in quattro, e di solito era uno per tutti e tutti per uno. Anche queste quaglie erano vestite all'estremo grido, con parrucche
viola, verdi e arancione sul planetario, roba che non costava meno di tre o quattro settimane del loro stipendio, direi, e trucco in carattere (arcobaleno intorno ai fari, cioè, e il truglio
dipinto larghissimo).

JAMES LEO HERLIHY - Un uomo da marciapiede (1965) no
CON GLI STIVALI nuovi, Joe Buck era alto uno e ottantacinque, e la vita gli sembrava diversa. Come uscì da quel negozio di Houston, qualcosa scattò nella sua intera metà inferiore: una forza,
della cui presenza non si era mai accorto, gli si era scatenata nel bacino, ed egli ora poteva avvertire il mondo pel suo tramite. Muscoli nuovi fiammanti gli entrarono in azione nelle natiche e
nelle gambe, e Joe Buck fu consapevole di un atteggiamento affatto nuovo nei confronti del selciato. Il mondo era lì sotto ed egli marciava sulla sua sommità, e lo spazio tra lui e il mondo era
ora dominio di uno strano, bell'animale: lui stesso, Joe Buck. Era forte. Era esultante. Era pronto.
Sono pronto, si disse, e si chiese che cosa ciò significasse.
Joe sapeva di non valere granché come pensatore, e sapeva anche che, quel poco che pensava, gli riusciva nel modo migliore di fronte a uno specchio, e così i suoi occhi si volsero all'ingiro, in
cerca di qualcosa che gli rimandasse la propria immagine. Proprio davanti a lui c'era la vetrina di un negozio. Ta-clic, ta-clic, ta-clic, ta-clic, dissero gli stivali al cemento, intendendo
possanza, possanza, possanza, mentre Joe si avvicinava, allungando il collo, alla vetrina, e c'era quest'individuo, nuovo eppure familiare, che gli veniva incontro, largo di spalle, spavaldo,
freddo e bello. Signore, son felice d'esser lei, disse all'immagine - non ad alta voce, beninteso e poi: Cos'è questa storia dell'esser pronto?
Pronto a che cosa?
E allora si sovvenne.
Quando arrivò all'Hotel, un hotel che non solo non aveva nome ma aveva anche perso la o, avvertì l'assurdità del fatto che uno ricco e duro e vitale come lui stesse in un posto del genere,
anonimo e così dappoco. Fece i gradini due alla volta, giunse al secondo piano, sul retro, e corse all'armadio a muro, da cui emerse un istante dopo con un grosso pacco. Tolse la carta da imballo
e depose sul letto una valigia di cavallino bianco e nero.
Incrociò le braccia, si scostò e la guardò, scuotendo la testa affascinato. La bellezza della valigia non mancava
mai di fargli effetto. Il nero era così nero, il bianco così bianco, e l'insieme così vivo e morbido, che era come possedere un miracolo. Si guardò le mani, se per caso non fossero sudice, poi
spazzolò la pelle, come a toglierne della polvere che naturalmente non c'era: Joe semplicemente spazzava via la possibilità di futura sporcizia.
Prese a cavare dal loro nascondiglio altri tesori acquistati negli ultimi mesi: sei camicie fiammanti di taglio western, calzoni nuovi (gabardine nera e cotone nero), biancheria mai usata,
calzini (sei paia, ancora avvolti nel cellophane), due fazzoletti di seta da collo, un anello d'argento proveniente da Juarez, una radio portatile a otto transistor, con cui potevi ricevere Città
del Messico senza la minima interferenza, un rasoio elettrico nuovo, quattro stecche di Camel e parecchie di gomma da masticare Juicy Fruit, articoli da toletta, un plico di vecchie lettere, e
così via.
Prese poi una doccia e tornò in camera a prepararsi per il viaggio.
FREDERICK FORSYTH - Il giorno dello sciacallo (1971)
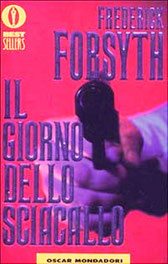
1 no
Fa freddo a Parigi, alle sei e quaranta di mattina in una giornata di marzo, e il freddo sembra ancora più intenso quando sta per essere giustiziato un uomo. L'11 marzo 1963, a quell'ora, nel cortile principale di Fort d'Ivry, un colonnello dell'aviazione francese era in piedi davanti a un palo conficcato nella ghiaia gelida e mentre gli legavano le mani fissava con incredulità sempre meno evidente il plotone di fronte a lui, a una ventina di metri. Un piede strisciò sui sassi, impercettibile sollievo alla tensione, nell'attimo in cui una benda veniva avvicinata agli occhi del tenente colonnello Jean-Marie Bastien-Thiry, a nascondergli definitivamente la luce.
Il mormorio del sacerdote fu il vano contrappunto al crepitare degli otturatori, quando i soldati caricarono e armarono i fucili.
Al di là del muro di cinta, un clacson insistente: un autocarro Berliet chiedeva strada a qualche veicolo più piccolo che lo intralciava nella sua corsa verso il centro della città. Il suono si spense lontano, confondendosi col «Puntate!» dell'ufficiale al comando del plotone. La scarica di fucileria, quando fu il momento, non provocò alcuna increspatura sulla superficie della città al risveglio; soltanto uno stormo di piccioni si levò in volo verso il cielo, per pochi attimi. L'eco del singolo coup-degrâce, qualche secondo più tardi, si perse nella crescente confusione del traffico al di là del muro.
La morte dell'ufficiale, capo di una banda di assassini della Organisation de l'Armée Secrète che avevano tentato di uccidere il Presidente francese, doveva significare una fine - la fine di ulteriori attentati alla vita del Presidente. Per uno scherzo del destino segnava invece un inizio, e per spiegarne la ragione è necessario spiegare prima perché un corpo crivellato di proiettili si trovasse, legato a un palo, nel cortile del carcere militare, a pochi chilometri da Parigi, in quella mattina di marzo...
Il sole era finalmente sparito dietro il palazzo, e lunghe ombre avanzavano strisciando sul cortile, apportatrici di gradito sollievo. Perfino alle sette di sera la giornata era stata la più calda dell'anno la temperatura si manteneva sui ventitré gradi.

Entrò nella mia vita nel febbraio del 1932 per non uscirne più. Da allora è passato più di un quarto di secolo, più di novemila giorni tediosi e senza scopo, che l'assenza della speranza ha reso tutti ugualmente vuoti - giorni e anni, molti dei quali morti come le foglie secche su un albero inaridito.
Ricordo il giorno e l'ora in cui il mio sguardo si posò per la prima volta sul ragazzo che doveva diventare la fonte della mia più grande felicità e della mia più totale disperazione. Fu due giorni dopo il mio compleanno, alle tre di uno di quei pomeriggi grigi e bui, caratteristici dell'inverno tedesco. Ero al Karl Alexander Gymnasium di Stoccarda, il liceo più famoso del Württemberg, fondato nel 1521, l'anno in cui Lutero comparve davanti a Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Spagna.
Ricordo ogni particolare: l'aula scolastica, con le panche e i banchi massicci, l'odore acre, muschioso, di quaranta pesanti cappotti invernali, le pozze di neve disciolta, i contorni bruno-giallastri sulle pareti grige in corrispondenza del punto in cui, prima della rivoluzione, erano appesi i ritratti del Kaiser Guglielmo e del re del Württemberg. Se chiudo gli occhi, riesco ancora a vedere le schiene dei miei compagni, molti dei quali sono morti nelle steppe della Russia o nelle sabbie di Alamein. Risento ancora la voce stanca e disillusa di Herr Zimmermann che, condannato all'insegnamento a vita, aveva accettato il suo destino con triste rassegnazione. Aveva il volto pallido e i capelli, i baffi e la barbetta a punta erano striati di grigio. Guardava il mondo attraverso gli occhiali a pince-nez che teneva appoggiati sulla punta del naso con l'espressione di un cane randagio in cerca di cibo. Anche se non doveva avere più di cinquant'anni, a noi pareva che ne avesse ottanta. Lo disprezzavamo perché era buono, gentile e aveva addosso l'odore dei poveri - molto probabilmente il suo appartamentino bicamere non era dotato di bagno - e anche perché in autunno e nei lunghi mesi invernali indossava un abito lustro, verdastro e rappezzato (possedeva un altro vestito, che portava in primavera e in estate). Lo trattavamo dall'alto in basso e, a volte, anche con crudeltà, la crudeltà codarda che i ragazzi in buona salute mostrano spesso nei confronti dei deboli, dei vecchi e degli indifesi.
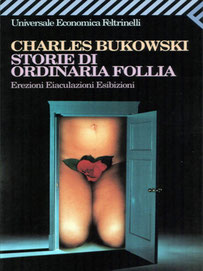
CHARLES BUKOWSKI - Storie di ordinaria follia (1972) no
La più bella donna della città
Cass era la più giovane e la più bella di 5 sorelle. Cass era la più bella ragazza di tutta la città. Mezzindiana, aveva un corpo stranamente flessuoso, focoso era e come di serpente, con due occhi che proprio ci dicevano. Cass era fuoco fluido in movimento. Era come uno spirito incastrato in una forma che però non riusciva a contenerlo. I capelli castani e lunghi, i capelli di seta, si muovevano ondeggiando e vorticando come il corpo volteggiava. Non c'era via di mezzo per Cass. C'era anche chi diceva che era pazza. Gli imbecilli lo dicevano. Gli scemi non potevano capirla. Agli uomini in genere Cass pareva una macchina da fottere, e quindi non gliene fregava niente, fosse o non fosse pazza. E Cass ballava e civettava, si lasciava baciare dagli uomini ma, tranne qualche rara volta, quando si stava per venire al dunque, com'è come non è, Cass si eclissava, Cass aveva eluso gli uomini.
Le sorelle la accusavano di sprecare la sua bellezza, di non fare buon uso del suo cervello. Ma Cass ne aveva da vendere, di cervello e di spirito. Dipingeva, danzava, cantava, modellava la creta, e quando qualcuno era ferito, mortificato, nel corpo e nell'anima, Cass provava compassione per costui. Il suo cervello era, ecco, differente; la sua mentalità non era pratica, ecco quanto. Le sorelle eran gelose perché essa attraeva i loro uomini; ce l'avevano su con Cass perché, secondo loro, sciupava un sacco d'occasioni. Di solito Cass era gentile con quelli più brutti; i cosiddetti fusti non le dicevano niente. Le facevano schifo. "Senza nerbo," diceva, "senza grinta. Arrivano, alti in sella, con quei nasi ben fatti, quelle orecchie ben disegnate… Tutta esteriorità e niente dentro." La sua indole era affine alla pazzia; aveva un temperamento che certi chiamano pazzia.
Il padre era morto alcolizzato, la madre era scappata via di casa, abbandonando le figlie. Le ragazze si rivolsero a certi loro parenti, che la misero in convento. Il convento era un posto molto triste, più per Cass che per le sorelle. Le altre ragazze erano gelose di Cass e a Cass toccava litigare sempre. Aveva segni di rasoiate sul braccio sinistro, in conseguenza di quelle baruffe. Poi aveva una cicatrice permanente sulla guancia sinistra, ma lo sfregio anziché diminuirla sembrava accrescere la sua bellezza.
Io l'incontrai al West End Bar poco dopo ch'era venuta via dal convento. Essendo la più giovane delle sorelle, era venuta via per ultima. Quella sera entrò là e, semplicemente, si venne a sedere vicino a me, Io ero forse l'uomo più brutto della città, e magari questo avrà influito in qualche modo.
"Bevi?" le domandai.
"Ma sicuro, come no?"
Non ci dicemmo niente di straordinario, mi sa, quella sera; ma contava l'impressione che lei dava. Cass aveva scelto me e questo era quanto. Nessuna
forzatura. Bere le piaceva e così fece molti bis. Non credo fosse ancora maggiorenne, però lì la servivano lo stesso. Magari aveva
una carta d'identità falsa, chi lo sa.
 CULTURA & SVAGO
CULTURA & SVAGO