BRANI DI FILOSOFIA CONTEMPORANEA
I brani riportati sono stati tratti dalle seguenti opere:
WACKENRODE - Fantasie sull'arte
ARTHUR SCHOPENHAUER - Il mondo come volontà e rappresentazione
FRIEDRICH NIETZSCHE - Genealogia della morale (con note)
ERICH FROMM - Avere o essere?
Inoltre proponiamo brani dei seguenti filosofi:
GADAMER - Il mito di Sisifo
MARCUSE - Eros e civiltà
Theodor Adorno - Sulla scrittura
Durkheimer - L'anomia
Adorno - Un test che riveli i veri amici
ANTONIO GRAMSCI - Senza il riferimento alle masse sociali, il concetto di libertà è vuoto

WACKENRODER - Da "Fantasie sull'arte".
"Oh, questo interminabile monotono giro di migliaia di giorni e di notti ... tutta la vita dell'uomo, tutta la vita dell'intero universo, non è altro che un interminabile gioco di scacchi sui due campi: bianco e nero, gioco nel quale nessuno vince se non l'infausta morte...
Tutto questo potrebbe in certe ore far perdere la testa! E invece ci si deve sostenere con braccia coraggiose in mezzo al caos delle rovine, nel quale la nostra vita è sminuzzata e attaccarci fortemente all'arte, alla grande, alla duratura arte che, al di sopra di ogni caos, attinge l'eternità, l'arte che dal cielo ci porge una mano luminosa, così che noi stiamo sospesi in ardita posizione sopra un abisso deserto, fra cielo e terra".
ARTHUR SCHOPENHAUER - Il mondo come volontà e rappresentazione
“Trasportiamoci in una contrada solitaria; l’orizzonte è infinito, il cielo senza nubi; le piante e gli alberi sono immersi in un’atmosfera perfettamente immobile; nessun animale, nessun uomo, non acque correnti, e dappertutto il più profondo silenzio; il paesaggio invita al raccoglimento, alla contemplazione, all’oblìo più completo della volontà e delle sue miserie. Ma ciò appunto conferisce a questo paesaggio, dove non regnano che la solitudine e la quiete, una tinta di sublime …, benché al suo grado più tenue…
Cerchiamo d’immaginarci ora una tale contrada, spoglia di ogni vegetazione, tale che non vi si vedano che nude rocce: la volontà proverà ben presto un senso d’inquietudine dall’assenza assoluta di tutta la natura organica necessaria alla nostra sussistenza. Il deserto ha un aspetto terribile, e in esso il nostro stato d’animo diviene più tragico, infatti, allo stato di conoscenza pura, tutto pieno di calma e di autosufficienza, si mescola qui, per contrasto, il ricordo di una volontà mai autosufficiente, sempre misera, sempre tormentata dal bisogno di spingersi innanzi. Questo è il genere di sublime che si vanta nello spettacolo “
“Un uomo, che sia disposto a commettere l’ingiustizia, sempreché gli si presenti l’occasione, e nessuna forza esterna lo trattenga, si dice cattivo. Data la nostra concezione dell’ingiustizia, esser cattivo significa non contentarsi di affermare la volontà di vivere quale si manifesta nel proprio corpo, ma spingere l’affermazione fino a negare la volontà che si estrinseca in altre individualità: il cattivo tenta di asservire le altrui forze alla volontà propria, e di distruggere le altrui esistenze quando sian d’ostacolo alle proprie aspirazioni. La sorgente ultima di tale disposizione d’animo va cercata in un eccesso di egoismo… Ne risultano ad evidenza due verità. La prima consiste nel fatto che la volontà di vivere, quale si manifesta in un tale uomo, è violenta ed eccessiva e supera di gran lunga la semplice affermazione del proprio corpo. La seconda verità invece insegna che la conoscenza di costui è incapace di elevarsi al di sopra della distinzione assoluta fra la persona propria e gli altri esseri. Perciò il malvagio va in cerca del suo solo benessere, senza punto curarsi dell’altrui. Le altre persone gli rimangono estranee, come se fra la loro essenza e la sua ci fosse un abisso incolmabile, come se le altre non fossero che larve senz’ombra di realtà. Questi sono i fondamenti del carattere cattivo.
La veemenza eccessiva del volere è già in sé e per sé una sorgente immediata ed inesauribile di dolore. Perché, in primo luogo, ogni volere come tale nasce da un bisogno; dunque, da una sofferenza… In secondo luogo la concatenazione causale dei fatti condanna i più tra i desideri a restare senza soddisfazione; poiché la volontà viene più sovente contrariata che accontentata, la sua violenza e la sua multiformità saranno indissolubilmente congiunte con delle sofferenze anch’esse multiformi e violente. La sofferenza, infatti, non è che volontà insoddisfatta e contrariata; lo stesso dolore derivante da un lesione del corpo, è possibile perché il corpo è volontà oggettivata. Il legame indissolubile, per cui una volontà violenta e multiforme non può andar disgiunta da un multiforme violento soffrire, imprime nella fisionomia stessa del malvagio il caratteristico segno di un’intima sofferenza. Quand’anche abbia raggiunto il colmo della felicità esterna il malvagio, trattone qualche istante in cui sia posseduto da una qualche gioia passeggera, conserva sempre, se non sa dissimulare, l’aria d’infelice. E questa intima tortura, che fa parte integrante della sua essenza, è anche la sorgente di una gioia non derivante per intero dall’egoismo che il malvagio prova nella vista del dolore altrui; gioia in cui propriamente consiste la malvagità e che s’intensifica nella crudeltà. Il dolore altrui non è più, allora, un semplice mezzo per altri fini egoistici, ma diviene fine a se stesso. Ed ecco in che modo. L’uomo, essendo una manifestazione della volontà illuminata dal grado supremo della conoscenza, misura costantemente la soddisfazione reale e sentita della sua volontà, comparandola con la soddisfazione possibile che l’intelligenza gli fa intravedere. Di qui l’invidia: ogni privazione è smisuratamente aggravata dalla gioia altrui, e addolcita al solo pensiero che altri ne soffrano al pari di noi. I mali comuni a tutti gli uomini, e inseparabili dalla vita umana, poco ci preoccupano, poco ci turbano; altrettanto dicasi dei malanni che colpiscono un paese intero, delle inclemenze del clima. Il solo ricordo di sofferenze più gravi che le nostre, vale a calmare le nostre pene; la vista del dolore altrui basta di per sé ad alleviare il nostro. Si supponga ora un uomo animato da una volontà straordinariamente violenta; che voglia, con bramosia cocente, abbracciare tutto quanto esiste, per immolarlo al proprio egoismo e calmarne la sete; senza dubbio, egli dovrà ben presto e necessariamente sperimentare che ogni soddisfazione è per sua natura illusoria, che l’oggetto posseduto non mantiene mai le promesse dell’oggetto desiderato, che non ci dà l’acquietamento finale degli impulsi furiosi del nostro volere. Costui dovrà d’altra parte rendersi conto che il desiderio soddisfatto non fa altro che rivestire una forma nuova, per ricominciare di nuovo a tormentarci e che, infine, se tutte le forme del desiderio venissero esaurite, non per questo la sete ardente del volere si estinguerebbe, ma persisterebbe anche in assenza di ogni motivo conosciuto, e si rivelerebbe come sentimento spaventevole del vuoto e del nulla, come tortura atroce. Tutto ciò, in una persona dotata di un grado comune di volontà, non è sentito che debolmente, senza produrre che un volgare malumore; in quella persona, invece, la cui volontà è intensa quanto si richiede alla perversità, provoca un tormento interiore inaudito, un’eterna inquietudine, un dolore insanabile. Quel sollievo, che direttamente non è ottenibile, è allora cercato per via indiretta: il malvagio procura di mitigare il proprio dolore, con lo spettacolo del dolore altrui, con il pensiero che tale dolore è un effetto e una testimonianza della propria potenza. Così la sofferenza degli altri diviene per lui un fine a se stessa, uno spettacolo dilettevole; questa è l’origine del fenomeno, così frequente nella storia, della crudeltà nel senso più puro della parola, di quella sete di sangue che ardeva nei Neroni, nei Domiziani, nei Robespierre ecc….
L’intelligenza… produce la giustizia; e quando s’innalzi a un grado ancor superiore, la vera bontà, che si manifesta nell’amor puro e disinteressato verso gli altri. Allorché tale chiarezza di visione diviene perfetta, noi mettiamo l’individuo estraneo, e il suo destino, allo stesso livello con l’io nostro e con il nostro destino; più oltre non si può andare, non essendoci alcuna ragione di preferire l’altro a noi stessi. Tuttavia, quando si tratta di una grande collettività d’individui, il cui benessere o la cui vita sian minacciati da grave pericolo, può darsi che la loro sciagura faccia in un dato individuo passare in seconda o in ultima linea ogni considerazione sul benessere proprio. In tal caso vedremo dei caratteri pervenuti alla più alta bontà e alla più nobile elevazione, offrire in sacrificio il proprio bene e la propria vita, al bene e alla vita della maggioranza; così morì Codro, così Leonida, così Regolo …così muore chi corre liberamente e con piena coscienza a morte sicura, per la salvezza dei suoi e della patria. A pari altezza si elevano tutti quegli uomini che affrontano volenterosi le torture e la morte, per l’affermazione di ciò che deve costituire il benessere e divenire il patrimonio legittimo dell’umanità; cioè per il trionfo di qualche importante verità di ordine generale, e per l’estirpazione di perniciosi errori; così morì Socrate, così Giordano Bruno, così tanti martiri ed eroi della verità che perirono sul rogo per mano dei preti.
Ora, a proposito del paradosso dianzi espresso, dobbiamo ricordare che…alla vita è essenzialmente e inseparabilmente congiunto il dolore; che ogni desiderio nasce da un bisogno, da una mancanza, da una sofferenza; che perciò la soddisfazione, lungi dal costituire un vero benessere positivo e acquisito, non è che la rimozione di un dolore, che le gioie mentiscono alla speranza, presentandosi come un bene positivo mente, in realtà, non sono che di natura negativa: semplice e pura cessazione di un male. Quindi, tutto ciò che la bontà, la generosità e l’amore possono fare per gli altri, si riduce a lenirne le sofferenze; né altro può ispirare e promuovere le buone azioni e le opere di carità, fuorché la conoscenza delle sofferenze altrui, che intuiamo nelle nostre, ponendole con queste allo stesso livello. Come si vede, l’amor puro (agape, caritas) è per essenza pietà; la sofferenza che n’è mitigata può essere piccola o grande; potrebbe anche ridursi a un semplice desiderio insoddisfatto: poco importa. Non esito dunque a oppormi su questo punto a Kant, il quale riconosce come vera bontà e vera virtù quelle soltanto che scaturiscono dalla riflessione astratta, o meglio dal concetto di dovere e dall’imperativo categorico; e non ammette sia virtù la pietà che sentiamo per un essere debole. Io, invece, affermo recisamente che il puro e semplice concetto è impotente a produrre la vera virtù, come è impotente a creare la vera opera d’arte: ogni amore puro e sincero è pietà; un amore, che non sia pietà, si riduce a egoismo. L’amore personale è l’eros; la pietà è l’agape. Spesso ha luogo una fusione dei due sentimenti. Anche l’amicizia più pura è sempre un miscuglio di egoismo e di pietà; il primo risiede nel piacere che proviamo alla presenza dell’amico, la cui individualità corrisponde alla nostra, e ne costituisce quasi sempre la miglior parte; la pietà si rivela nella sincera partecipazione che prendiamo al suo bene e ai suoi mali, e nei sacrifizi disinteressati a cui siamo pronti per lui...
E’ questo il luogo di studiare anche una delle più meravigliose proprietà della natura umana: il pianto, che, al pari del riso, è uno dei segni più esteriori per cui l’uomo si distingue dal bruto. Il pianto non è l'espressione del dolore; anzi, è ben raro che un dolore ci faccia versare delle lacrime. A parer mio, ci fa piangere non il dolore immediatamente sentito, mala rappresentazione riflessa che ne facciamo. Infatti, non appena ci colpisce un dolore, sia pur fisico, passiamo subito a rappresentarcelo; allora il nostro stato ci appare così compassionevole, da sentirci profondamente persuasi che se un altro si trovasse nella nostra condizione, lo soccorreremmo col più fervido slancio della pietà e dell’amore. Ora, per altro, siam proprio noi l’oggetto di questa sincera petà; e, animati come siamo dal più tenero sentimento di soccorso, siam proprio noi che di soccorso abbiam bisogno; sentiamo di soffrire più di quanto non potremmo veder soffrire un altro. E, in una disposizione tanto strana e complessa, dove il dolore immediato ritorna alla percezione con duplice rimbalzo, prima come dolore estraneo e compatito, poi subito di nuovo come dolore proprio e percepito direttamente, la natura cerca un sollievo in quella strana crisi convulsiva del corpo. Il pianto è dunque pietà di noi stessi: è pietà richiamata al suo punto di partenza. Così, non può piangere chi non sia capace di amore, di pietà, di fantasia; perciò gli uomini di cuore duro, e scarsi di fantasia, difficilmente piangono; perciò, anche, il pianto viene ritenuto come segno di una certa bontà di carattere; le lacrime disarmano la collera, perché si sene, in chi è capace di piangere, la capacità di amare, di essere pietoso con gli altri; la pietà, come s’è visto, essendo elemento costitutivo di quella disposizione d’animo che invita al pianto…
Ed ecco un’altra conferma: i bambini che si son fatti del male, il più delle volte non piangono, se non quando vedono che altri li compiange; dunque, ciò che li fa piangere non è già il dolore, ma soltanto la sua rappresentazione. Il pianto, a cui ci muove non il nostro dolore, ma l’altrui, si deve al nostro metterci con l’immaginazione al posto di chi soffre; al nostro vedere, nella sua sorte, il destino di tutta l’umanità, e quindi anche il nostro. Dunque, in ultimo, finiamo sempre per piangere su di noi stessi; noi stessi siamo l’oggetto della nostra pietà. E questa dev’essere la ragione del fatto costante, e quindi naturale, per cui, di fronte ad un caso di morte, ci sentiamo tutti venir da piangere. Ciò che piangiamo non è la perdita sofferta; ci vergogneremmo di lacrime tanto egoistiche: mentre se c’è cosa che in simile caso ci faccia vergogna, è appunto il non piangere. Senza dubbio, ciò che innanzi tutto ci muove al pianto è la sorte del defunto: tuttavia piangiamo anche se la morte sia stata per lui come una provvidenziale liberazione da lunghe, tormentose, insanabili sofferenze; dunque, ciò che principalmente ispira la pietà nostra è il destino dell’umanità intera, condannata ad una fine che estinguerà ogni vita, per quanto energica e intraprendente, e la ridurrà al nulla; però in tale destino dell'umanità intravediamo anche il nostro.
Un uomo che senta le sofferenze degli altri non meno che le proprie; che dunque non soltanto si mostri soccorrevole fino all’estremo grado, ma sia pronto a sacrificare il proprio individuo, se ciò si richieda per salvare molti individui estranei; un tal uomo, riconoscendo in tutte le creature se stesso, il più intimo, il più vero se stesso, riterrà come sue le pene infinite di tutti gli esseri viventi; e farà suo tutto il dolore dell’universo. Nessuna sofferenza può essergli estranea. I tormenti che vede affliggere i suoi simili, e che può così raramente addolcire; quelli di cui non ha che notizia indiretta, e quelli stessi che può soltanto concepire come possibili, tutti lo commuovono come se fossero suoi. Non fissa più lo sguardo sull’alterna vicenda dei beni e dei mali della propria persona, come fa l’uomo ancora schiavo dell’egoismo…abbraccia tutto l’insieme delle cose, ne afferra l’essenza e la riconosce consistere in un perpetuo annientamento, in uno sforzo sterile, in una contraddizione intima, in una sofferenza senza tregua; dovunque volga lo sguardo, vede un’umanità dolorante, un’animalità sofferente, un mondo evanescente. Il tutto lo tocca da vicino, come i mali della propria persona toccano l’egoista…La volontà allora si distacca dalla vita e sente orrore di tutte le gioie in cui si traduce la sua affermazione. L’uomo perviene ad uno stato di volontaria rinunzia, di rassegnazione, di perfetta quiete e di soppressione completa del volere. A noi, miseri mortali avvolti ancora nel velo di Maya, accade talvolta che un acerbo dolore personale, o la viva rappresentazione delle sofferenze altrui, ci renda consci della nullità e dell’amarezza della vita; e allora vorremmo, con energico atto di rinunzia, smussare una volta per sempre la punta dei desideri, chiudere ogni accesso ai dolori, purificarci e santificarci; ma il fascino ingannatore del mondo fenomenico torna subito a sedurci e irretirci, e i suoi motivi non tardano a metter di nuovo la volontà in movimento: siamo impotenti a liberarci. Le seduzioni della speranza, le lusinghe del presente, la dolcezza delle gioie, il benessere che per eccezione ci tocca talora in sorte tra le pene ed i guai di questo misero mondo dominato dal caso e dall’errore, tutto ci sospinge indietro, e riallaccia di nuovo i nostri vincoli con la vita…
L’uomo non si contenta più di amare i suoi simili come se stesso e di fare per loro quello che farebbe per sé; ma sorge in lui una ripugnanza per quell’essere di cui è manifestazione il suo stesso fenomeno, cioè, per la volontà di vivere, nocciolo ed essenza di questo mondo di guai. La rinnega, anche in quanto si manifesta in lui e si esprime nel suo corpo; il suo agire smentisce recisamente il suo fenomeno e lo contraddice. Benché non sia egli stesso che fenomeno di volontà, cessa di volere, di attaccarsi a qualsiasi cosa, e si tien fermo in una indifferenza che non fa eccezione. Il suo corpo, sano e forte, esprime negli organi di riproduzione il desiderio sessuale; ma egli rinnega la sua volontà e smentisce il suo corpo, rifiutando ad ogni costo una soddisfazione sessuale.
Il primo passo nell’ascesi o nella negazione della volontà è una perfetta e libera castità; che (rifiutando il commercio sessuale) nega questo affermarsi della volontà oltre la vita individuale, attestando così che, insieme con la vita del corpo, si sopprime anche la volontà di cui il corpo è manifestazione. La natura, sempre vera ed ingenua, dice che se questa massima divenisse universale, il genere umano perirebbe; ora… se della volontà svanisse la manifestazione più alta (l’uomo) svanirebbe insieme anche il suo riflesso, l’animalità; come, con la luce solare, svanirebbero le penombre… L’ascesi si manifesta nella povertà volontaria e intenzionale: essa non sorge per accidens, in quanto ci si spoglia dei propri beni per addolcire le sofferenze altrui; ma ha per fine se stessa e deve servire di costante mortificazione alla volontà, perché la soddisfazione dei desideri e le dolcezze della vita non vengano di nuovo ad eccitarla; la volontà, per il soggetto resosi autocosciente, essendo divenuta oggetto di orrore. L’uomo, giunto a questa altezza, sente ancora, in quanto corpo animato, in quanto fenomeno concreto della volontà, i desideri del volere; ma li reprime, costringendosi a non far nulla di ciò che farebbe volentieri e a fare ciò che non vorrebbe; per contribuire, se non altro, alla mortificazione della volontà. Poiché rinnega egli stesso, la volontà che si manifesta in lui neppure si opporrà più a chi gli facesse qualcosa di simile, a chi gli facesse torto; accoglierà come benvenuta ogni sofferenza che gli venga dal di fuori, sia per caso che per altrui malvagità; lo stesso dicasi di ogni oltraggio, di ogni offesa, di ogni affronto; tutto accoglie con gioia, non vedendoci che un’occasione per provare a se stesso di essersi ormai alienato dall’affermare la volontà, e inimicato con quella sua manifestazione speciale che è la persona. Sopporta dunque oltraggi e dolori, con una pazienza e una dolcezza inesauribili; rende senza ostentazione bene per male; non permette che si riaccenda in lui l’ardore né della collera né del desiderio. E, come la volontà, mortifica l’oggettivazione visibile della volontà, il corpo. Lo nutre parcamente, perché la sua floridezza rigogliosa non ridesti a vita energica la volontà, di cui quello è l’espressione e lo specchio. Pratica il digiuno, la macerazione; giunge a flagellare la propria carne, per abbattere sempre più, con le privazioni e le sofferenze continue, quella volontà in cui ravvisa e detesta l’origine della travagliata esistenza sua e del mondo. La morte infine, quando viene a distruggere la manifestazione di una tale volontà, ch’egli aveva già da tempo con atto di libera negazione uccisa nella sua essenza, non lasciandone vivere che il debole resto animante il suo corpo, è da lui salutata con gioia, e accolta festosamente come una liberazione sospirata. In lui la morte non si limita, come negli altri, a porre un termine al semplice fenomeno; ma sopprime anche l’essenza, il cui ultimo barlume di esistenza non era dovuto che al fenomeno; ora vien rotto anche questo fragile ultimo legame. Per chi finisce così, finisce in pari tempo anche l’universo…
I santi e gli asceti, sebbene tutti fossero ispirati da una stessa conoscenza interiore, parlavano ciascuno un linguaggio differente, secondo i dogmi di cui s’era imbevuta la loro ragione. Alla varietà dei dogmi si deve, se ogni santo si rende un conto ben diverso della propria condotta, secondo che sia indiano, cristiano o lamaista; ma l’essenza della cosa resta sempre inalterata. Che un santo sia imbevuto delle più assurde superstizioni, o sia un filosofo, non importa. Ciò che lo fa e lo rivela santo, è unicamente la condotta; e questa, considerata moralmente, non scaturisce da una nozione astratta, ma si ispira alla conoscenza intuitiva e immediata del mondo e della sua essenza…La letteratura indiana, per giudicarne da quel tanto che se ne sa dalle traduzioni, sembra molto ricca in biografie di santi, di espiatori…Né i cristiani mancano di esempi che illustrino la nostra teoria. Non c’è che da leggere le biografie…di persone analoghe, sotto i nomi, ora di santi, ora di pietisti, di quietisti, di pii, di visionari ecc…Un posto speciale nella serie appartiene alla vita di San Francesco D’Assisi, che fu la vera personificazione dell’ascesi, l’ideale del frate mendicante…Ci troviamo il medesimo contenuto, sotto una veste differente; il che dimostra quanto poco importi che la santità provenga da una religione teistica od atea…La storia non parlerà mai, e non può del resto parlarne, di quegli uomini la cui condotta presenta l’illustrazione migliore e più completa di questo punto importante delle nostre considerazioni. Infatti, la materia della storia è non soltanto molto diversa, ma opposta; la storia non si preoccupa della negazione e soppressione della volontà di vivere; studia, invece, l’affermazione della volontà medesima, e la sua estrinsecazione in un numero infinito d’individui; estrinsecazione, in cui la volontà rivela, nel modo più patente, il conflitto interiore che la travaglia sulla vetta della sua oggettivazione; facendoci vedere, ora il predominio dell’individuo in virtù della sua saggezza, ora la sfera delle moltitudini, ora la potenza del caso personificato nel destino; sempre, la vanità e la nullità dello sforzo totale. Ma noi, che non seguiamo il filo dei fenomeni nel tempo; noi che, da filosofi, cerchiamo invece d’investigare il significato etico delle azioni, e ce ne serviamo come di misura per tutto quanto abbia importanza e valore, noi proclameremo coraggiosamente, senza lasciarci spaventare dalla voce sempre contraria dei più, cioè degli spiriti sciocchi e volgari, che il fenomeno più sublime, più importante e più significativo che possa mai comparire sulla faccia della terra, non è il conquistatore del mondo, ma il vincitore di se medesimo: la vita quieta e silenziosa di un uomo sollevatosi all’altezza suprema della conoscenza, in cui rinnega e sopprime la volontà di vivere che tutto domina e pervade, che in tutto travaglia e si sforza e, ad esclusione di qualsiasi altra creatura, ne attua in sé la libertà, traducendola in una condotta opposta alla consueta… Nella vita dei nostri santi, la quiete e la beatitudine ci appaiono soltanto come un fiore sbocciato da una costante vittoria sulla volontà, e cresciuto sul campo della lotta senza tregua contro la volontà di vivere; a nessuna creatura essendo concesso di gustare sulla terra il riposo eterno. Leggendo le biografie dei santi, vediamo che la storia della loro vita intima è piena di lotte spirituali, di tentazioni…Con il termine di ascesi intendo in senso stretto quell’annientamento intenzionale della volontà, che si ottiene rinunciando ai piaceri e andando in cerca delle sofferenze: cioè la pratica volontaria di una vita di penitenza e di macerazioni, fatta in vista di una costante mortificazione del volere.
Abbiamo fin qui detto quanto basta per esporre l’essenza della negazione della volontà di vivere…Nulla è più diverso da questa negazione, che l’annientamento del proprio fenomeno individuale: voglio dire il suicidio. Non che sia negazione della volontà, il suicidio è il fenomeno di una sua più energica affermazione. La negazione, infatti, non consiste in un orrore dei mali della vita, ma nell’odio dei suoi piaceri. Il suicida vorrebbe la vita: e soltanto non è soddisfatto delle condizioni in cui gli si offre. Distruggendo il suo fenomeno, il suicida non rinuncia dunque al voler vivere, ma unicamente al vivere. Bramerebbe la vita, e vorrebbe che il suo corpo potesse esistere ed affermarsi senza ostacoli; e soffre atrocemente, perché ciò non gli è permesso dalla complicazione delle circostanze. La volontà di vivere si trova in lui così ostacolata, da non poter attuare ed esplicare i suoi sforzi...Tutti siamo animati da una certezza salda e profonda, che ci permette di vivere senza il terrore costante della morte; dalla certezza che la volontà non mancherà mai di fenomeni. E questa è la certezza su cui si fonda l’atto suicida. La volontà di vivere si manifesta dunque, tanto nel suicidio (Siva) quanto nella gioia della conservazione (Visnu), quanto nella voluttà della generazione (Brahma).Tale è il senso profondo dell’unità della Trimurti, che personifica l’uomo integrale… Il suicidio sta alla negazione della volontà di vivere, come l’oggetto particolare all’idea; il suicidio nega l’individuo, non la specie. Come s’è visto, la vita è assicurata infallibilmente per sempre alla volontà di vivere; e alla vita è essenziale il dolore; dunque, il suicidio appare come un atto vano e pazzesco; distrugge arbitrariamente il fenomeno particolare, ma la cosa in sé rimane sempre intatta…La volontà di vivere, come tale, non può venir soppressa che dalla conoscenza. Quindi, non c’è che una via di salvezza: bisogna, cioè, che la volontà si manifesti liberamente, affinché in tale manifestazione prenda coscienza della propria natura. Soltanto in virtù di una tale coscienza, la volontà può sopprimer se stessa, ponendo fine in pari tempo al dolore che ne accompagna inseparabilmente il fenomeno; la violenza, come la distruzione dei germi, l’uccisione dei neonati, il suicidio, sono mezzi assolutamente inadatti allo scopo.
La vita oscilla, come un pendolo, tra il dolore e la noia, suoi due costitutivi essenziali. Donde lo stranissimo fatto, che gli uomini, dopo ricacciati nell'inferno dolori e supplizi, non trovarono che restasse, per il cielo, niente all'infuori della noia.
L’uomo, essendo l’oggettivazione più perfetta della volontà di vivere, è anche il più bisognoso degli esseri; non è che volontà e bisogno, e lo si potrebbe definire una concrezione di bisogni. Sulla terra, l’uomo si trova dunque abbandonato a se stesso, incerto di ogni cosa, fuorché della sua indigenza e della sua angustia; le ansie per la conservazione della vita, in mezzo ad esigenze così difficili a soddisfare, e sempre rinascenti, bastano d’ordinario ad occupare tutta la vita. Si aggiunga un altro bisogno: quello di propagare la specie. Si aggiungano i pericoli di ogni sorta che lo minacciano da ogni lato, donde la necessità di star sempre all’erta per non caderne vittima. L’uomo non può avanzare che a passi lenti, con occhio ansioso e vigile, perché mille rischi e mille nemici gli tendono agguato. Così procedeva allo stato selvaggio, così procede in piena civiltà: per lui non c’è nessuna sicurezza. Per i più la vita non è che una lotta continua per l’esistenza, con la certezza di una disfatta finale. E ciò che dà loro tanta forza di persistere in questo disastroso conflitto, non è tanto l’amor della vita, quanto la paura della morte, che tuttavia sta là, nel fondo, pronta sempre ad affacciarsi. La vita è un mare seminato di scogli e di gorghi, che l’uomo riesce, con cura e con prudenza estreme, ad evitare; sapendo però che, se anche gli vien fatto, con la sua forza e la sua destrezza, di cavarsela, non fa che avvicinarsi man mano al grande, al totale, all’inevitabile, all’irreparabile naufragio; sapendo che il suo è un veleggiare verso il naufragio, verso la morte; ultimo termine del penoso viaggio, meta spaventosa più degli scogli evitati.
E’ poi anche da notare: per un verso, che i dolori e le torture della vita posson facilmente arrivare a una tale intensità, che la morte stessa ci divenga desiderabile; sicché, quantunque la nostra esistenza consista nel fuggirla, pure le si corra incontro volentieri; per un altro verso, che, non appena il bisogno e la sofferenza ci diano un momento di respiro, ci piomba subito addosso la noia, sicché siamo costretti a cercare qualche passatempo. Ciò che tien desti e in moto i viventi, è il desiderio di vivere. Orbene: assicurata che abbiamo la vita, non sanno più che farsene: sopravviene allora un altro stimolo: il desiderio di liberarsi del peso dell’esistenza, di renderlo insensibile, di “ammazzare il tempo”; in altre parole, di sfuggire alla noia. Così, la più gran parte di quelli che sono al riparo da ogni bisogno e da ogni preoccupazione, una volta riusciti a liberarsi di ogni altro peso, finiscono per diventar di peso a se stessi, e per ritenere come tanto di guadagnato, ogni ora che riescono a passare, ogni particella che riescono a sottrarre a quella vita, per il cui massimo prolungamento avevano prima impegnate tutte le loro forze. La noia non è, del resto, il meno disprezzabile dei mali; finisce per imprimere nel viso una stimmata di vera disperazione. La noia è appunto la causa per cui esseri che si amano così poco fra loro, e cioè gli uomini, pure si cercano a vicenda con tanta premura; è, dunque, la radice della socievolezza. E contro la noia, la saggezza politica prende, come contro le calamità naturali, dei provvedimenti pubblici. A ragione; perché la noia, e il suo estremo opposto che è la fame, può spingere gli uomini ai più furiosi eccessi; panem et circenses è ciò di cui il popolo ha bisogno. Il rigido sistema penitenziario di Filadelfia, che impone l’isolamento e l’inazione, fece della noia un mezzo di punizione: l’effetto fu così terribile, da spingere al suicidio i detenuti. Se il bisogno è il flagello del popolo, la noia è il supplizio delle classi superiori. Nella borghesia, la noia è rappresentata dalla domenica, il bisogno dagli altri sei giorni della settimana.
Tutta la vita umana scorre fra il desiderio e la soddisfazione. Il desiderio è, per sua natura, dolore: la soddisfazione si traduce presto in sazietà. Il fine, in sostanza, è illusorio: col possesso, svanisce ogni attrattiva; il desiderio rinasce in nuova forma; e con esso, il bisogno; altrimenti, ecco la tristezza, il vuoto, la noia, nemici ancor più terribili del bisogno. Quando il desiderio e la soddisfazione si seguono a intervalli non troppo lunghi né troppo brevi, la sofferenza che deriva da entrambi è ridotta al suo minimum, e si ha la vita più felice. Gli sforzi incessanti dell’uomo per bandire il dolore non riescono che a mutargli faccia. Il dolore si fa sentire dapprima come privazione, bisogno, ansia per la conservazione della vita. Se, cosa difficilissima, riusciamo a scacciarlo sotto questa forma, ricompare subito sotto mille altre, cambiando con l’età e con le circostanze: desiderio carnale, amor passionale, gelosia, invidia, odio, inquietudine, ambizione, avarizia, malattia, eccetera eccetera. Supposta esclusa ogni altra forma, prenderà quelle tristi e lugubri del disgusto e della noia, contro cui escogitiamo tutti i mezzi possibili di difesa. Che la buona fortuna ci permette di scongiurare anche la noia, sarà ben difficile che il dolore non si ripresenti sotto un’altra delle sue forme; perché, ripetiamo, la vita umana è un oscillare perpetuo fra il dolore e la noia.

Lettera di Einstein a Freud - Gaputh (Potsdam), 30 luglio 1932
Caro signor Freud,
La proposta, fattami dalla Società delle Nazioni e dal suo “Istituto internazionale di cooperazione intellettuale” di Parigi, di invitare una persona di mio gradimento a un franco scambio
d’opinioni su un problema qualsiasi da me scelto, mi offre la gradita occasione di dialogare con Lei circa una domanda che appare, nella presente condizione del mondo, la più urgente fra tutte
quelle che si pongono alla civiltà. La domanda è: C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra? E’: ormai risaputo che, col progredire della scienza moderna, rispondere a
questa domanda è divenuto una questione di vita o di morte per la civiltà da noi conosciuta, eppure, nonostante tutta la buona volontà, nessun tentativo di soluzione è purtroppo approdato a
qualcosa.
Penso anche che coloro cui spetta affrontare il problema professionalmente e praticamente divengano di giorno in giorno più consapevoli della loro impotenza in proposito, e abbiano oggi un vivo
desiderio di conoscere le opinioni di persone assorbite dalla ricerca scientifica, le quali per ciò stesso siano in grado di osservare i problemi del mondo con sufficiente distacco. Quanto a me,
l’obiettivo cui si rivolge abitualmente il mio pensiero non m’aiuta a discernere gli oscuri recessi della volontà e del sentimento umano. Pertanto, riguardo a tale inchiesta, dovrò limitarmi a
cercare di porre il problema nei giusti termini, consentendoLe così, su un terreno sbarazzato dalle soluzioni più ovvie, di avvalersi della Sua vasta conoscenza della vita istintiva umana per far
qualche luce sul problema. Vi sono determinati ostacoli psicologici di cui chi non conosce le scienze mentali ha un vago sentore, e di cui tuttavia non riesce a esplorare le correlazioni e i
confini; sono convinto che Lei potrà suggerire metodi educativi, più o meno estranei all’ambito politico, che elimineranno questi ostacoli.
Essendo immune da sentimenti nazionalistici, vedo personalmente una maniera semplice di affrontare l’aspetto esteriore, cioè organizzativo, del problema: gli Stati creino un’autorità legislativa
e giudiziaria col mandato di comporre tutti i conflitti che sorgano tra loro. Ogni Stato si assuma l’obbligo di rispettare i decreti di questa autorità, di invocarne la decisione in ogni disputa,
di accettarne senza riserve il giudizio e di attuare tutti i provvedimenti che essa ritenesse necessari per far applicare le proprie ingiunzioni. Qui s’incontra la prima difficoltà: un tribunale
è un’istituzione umana che, quanto meno è in grado di far rispettare le proprie decisioni, tanto più soccombe alle pressioni stragiudiziali. Vi è qui una realtà da cui non possiamo prescindere:
diritto e forza sono inscindibili, e le decisioni del diritto s’avvicinano alla giustizia, cui aspira quella comunità nel cui nome e interesse vengono pronunciate le sentenze, solo nella misura
in cui tale comunità ha il potere effettivo di impone il rispetto del proprio ideale legalitario. Oggi siamo però lontanissimi dal possedere una organizzazione sovrannazionale che possa emettere
verdetti di autorità incontestata e imporre con la forza di sottomettersi all’esecuzione delle sue sentenze. Giungo così al mio primo assioma: la ricerca della sicurezza internazionale implica
che ogni Stato rinunci incondizionatamente a una parte della sua libertà d’azione, vale a dire alla sua sovranità, ed è assolutamente chiaro che non v’è altra strada per arrivare a siffatta
sicurezza.
L’insuccesso, nonostante tutto, dei tentativi intesi nell’ultimo decennio a realizzare questa meta ci fa concludere senz’ombra di dubbio che qui operano forti fattori psicologici che paralizzano
gli sforzi. Alcuni di questi fattori sono evidenti. La sete di potere della classe dominante è in ogni Stato contraria a qualsiasi limitazione della sovranità nazionale. Questo smodato desiderio
di potere politico si accorda con le mire di chi cerca solo vantaggi mercenari, economici. Penso soprattutto al piccolo ma deciso gruppo di coloro che, attivi in ogni Stato e incuranti di ogni
considerazione e restrizione sociale, vedono nella guerra, cioè nella fabbricazione e vendita di armi, soltanto un occasione per promuovere i loro interessi personali e ampliare la loro personale
autorità.
Tuttavia l’aver riconosciuto questo dato inoppugnabile ci ha soltanto fatto fare il primo passo per capire come stiano oggi le cose. Ci troviamo subito di fronte a un’altra domanda: com’è
possibile che la minoranza ora menzionata riesca ad asservire alle proprie cupidigie la massa del popolo, che da una guerra ha solo da soffrire e da perdere? (Parlando della maggioranza non
escludo i soldati, di ogni grado, che hanno scelto la guerra come loro professione convinti di giovare alla difesa dei più alti interessi della loro stirpe e che l’attacco è spesso il miglior
metodo di difesa.) Una risposta ovvia a questa domanda sarebbe che la minoranza di quelli che di volta in volta sono a1 potere ha in mano prima di tutto la scuola e la stampa, e perlopiù anche le
organizzazioni religiose. Ciò le consente di organizzare e sviare i sentimenti delle masse rendendoli strumenti della propria politica.
Pure, questa risposta non dà neanch’essa una soluzione completa e fa sorgere una ulteriore domanda: com’è possibile che la massa si lasci infiammare con i mezzi suddetti fino al furore e
all’olocausto di sé?
Una sola risposta si impone: perché l’uomo ha dentro di sé il piacere di odiare e di distruggere. In tempi normali la sua passione rimane latente, emerge solo in circostanze eccezionali; ma è
abbastanza facile attizzarla e portarla alle altezze di una psicosi collettiva. Qui, forse, è il nocciolo del complesso di fattori che cerchiamo di districare, un enigma che può essere risolto
solo da chi è esperto nella conoscenza degli istinti umani.
Arriviamo così all’ultima domanda. Vi è una possibilità di dirigere l’evoluzione psichica degli uomini in modo che diventino capaci di resistere alle psicosi dell’odio e della distruzione? Non
penso qui affatto solo alle cosiddette masse incolte. L’esperienza prova che piuttosto la cosiddetta “intellighenzia” cede per prima a queste rovinose suggestioni collettive, poiché
l’intellettuale non ha contatto diretto con la rozza realtà, ma la vive attraverso la sua forma riassuntiva più facile, quella della pagina stampata.
Concludendo: ho parlato sinora soltanto di guerre tra Stati, ossia di conflitti internazionali. Ma sono perfettamente consapevole del fatto che l’istinto aggressivo opera anche in altre forme e
in altre circostanze (penso alle guerre civili, per esempio, dovute un tempo al fanatismo religioso, oggi a fattori sociali; o, ancora, alla persecuzione di minoranze razziali). Ma la mia
insistenza sulla forma più tipica, crudele e pazza di conflitto tra uomo e uomo era voluta, perché abbiamo qui l’occasione migliore per scoprire i mezzi e le maniere mediante i quali rendere
impossibili tutti i conflitti armati.
So che nei Suoi scritti possiamo trovare risposte esplicite o implicite a tutti gli interrogativi posti da questo problema che è insieme urgente e imprescindibile. Sarebbe tuttavia della massima
utilità a noi tutti se Lei esponesse il problema della pace mondiale alla luce delle Sue recenti scoperte, perché tale esposizione potrebbe indicare la strada a nuovi e validissimi modi
d’azione.
Molto cordialmente Suo
Albert Einstein
La risposta di Freud
Caro signor Einstein,
Quando ho saputo che Lei aveva intenzione di invitarmi a uno scambio di idee su di un tema che Le interessa e che Le sembra anche degno dell’interesse di altri, ho acconsentito prontamente. Mi
aspettavo che Lei avrebbe scelto un problema al limite del conoscibile al giorno d’oggi, cui ciascuno di noi, il fisico come lo psicologo, potesse aprirsi la sua particolare via d’accesso, in
modo che da diversi lati s’incontrassero sul medesimo terreno. Lei mi ha pertanto sorpreso con la domanda su che cosa si possa fare per tenere lontana dagli uomini la fatalità della guerra. Sono
stato spaventato per prima cosa dall’impressione della mia - starei quasi per dire: della nostra - incompetenza, poiché questo mi sembrava un compito pratico che spetta risolvere agli uomini di
Stato. Ma ho compreso poi che Lei ha sollevato la domanda non come ricercatore naturale e come fisico, bensì come amico dell’umanità, che aveva seguito gli incitamenti della Società delle Nazioni
così come fece l’esploratore polare Fridtjof Nansen allorché si assunse l’incarico di portare aiuto agli affamati e alle vittime senza patria della guerra mondiale. Ho anche riflettuto che non si
pretende da me che io faccia proposte pratiche, ma che devo soltanto indicare come il problema della prevenzione della guerra si presenta alla considerazione di uno psicologo. Ma anche a questo
riguardo quel che c’era da dire è gia stato detto in gran parte nel Suo scritto. In certo qual modo Lei mi ha tolto un vantaggio, ma io viaggio volentieri nella sua scia e mi preparo perciò a
confermare tutto ciò che Lei mette innanzi. nella misura in cui lo svolgo più ampiamente seguendo le mie migliori conoscenze (o congetture).
Lei comincia con il rapporto tra diritto e forza. È certamente il punto di partenza giusto per la nostra indagine. Posso sostituire la parola “forza” con la parola più incisiva e più dura
“violenza”? Diritto e violenza sono per noi oggi termini opposti. È facile mostrare che l’uno si è sviluppato dall’altro e, se risaliamo ai primordi della vita umana per verificare come ciò sia
da principio accaduto, la soluzione del problema ci appare senza difficoltà. Mi scusi se nel seguito parlo di ciò che è universalmente noto come se fosse nuovo; la concatenazione dell’insieme mi
obbliga a farlo.
I conflitti d’interesse tra gli uomini sono dunque in linea di principio decisi mediante l’uso della violenza. Ciò avviene in tutto il regno animale, di cui l’uomo fa inequivocabilmente parte;
per gli uomini si aggiungono, a dire il vero, anche i conflitti di opinione, che arrivano fino alle più alte cime dell’astrazione e sembrano esigere, per essere decisi, un’altra tecnica. Ma
questa è una complicazione che interviene più tardi. Inizialmente, in una piccola orda umana, la maggiore forza muscolare decise a chi dovesse appartenere qualcosa o la volontà di chi dovesse
essere portata ad attuazione. Presto la forza muscolare viene accresciuta o sostituita mediante l’uso di strumenti; vince chi ha le armi migliori o le adopera più abilmente. Con l’introduzione
delle armi la superiorità intellettuale comincia già a prendere il posto della forza muscolare bruta, benché lo scopo finale della lotta rimanga il medesimo: una delle due parti, a cagione del
danno che subisce e dell’infiacchimento delle sue forze, deve essere costretta a desistere dalle proprie rivendicazioni od opposizioni. Ciò è ottenuto nel modo più radicale quando la violenza
toglie di mezzo l’avversario definitivamente, vale a dire lo uccide. Il sistema ha due vantaggi, che l’avversario non può riprendere le ostilità in altra occasione e che il suo destino distoglie
gli altri dal seguire il suo esempio. Inoltre l’uccisione del nemico soddisfa un’inclinazione pulsionale di cui parlerò più avanti. All’intenzione di uccidere subentra talora la riflessione che
il nemico può essere impiegato in mansioni servili utili se lo s’intimidisce e lo si lascia in vita. Allora la violenza si accontenta di soggiogarlo, invece che ucciderlo. Si comincia così a
risparmiare il nemico, ma il vincitore da ora in poi ha da fare i conti con la smania di vendetta del vinto, sempre in agguato, e rinuncia in parte alla propria sicurezza.
Questo è dunque lo stato originario, il predominio del più forte, della violenza bruta o sostenuta dall’intelligenza. Sappiamo che questo regime è stato mutato nel corso dell’evoluzione, che una
strada condusse dalla violenza al diritto, ma quale? Una sola a mio parere: quella che passava per l’accertamento che lo strapotere di uno solo poteva essere bilanciato dall’unione di più deboli.
L’union fait la force. La violenza viene spezzata dall’unione di molti, la potenza di coloro che si sono uniti rappresenta ora il diritto in opposizione alla violenza del singolo. Vediamo così
che il diritto è la potenza di una comunità. È ancora sempre violenza, pronta a volgersi contro chiunque le si opponga, opera con gli stessi mezzi, persegue gli stessi scopi; la differenza
risiede in realtà solo nel fatto che non è più la violenza di un singolo a trionfare, ma quella della comunità. Ma perché si compia questo passaggio dalla violenza al nuovo diritto deve
adempiersi una condizione psicologica. L’unione dei più deve essere stabile, durevole. Se essa si costituisse solo allo scopo di combattere il prepotente e si dissolvesse dopo averlo sopraffatto,
non si otterrebbe niente. Il prossimo personaggio che si ritenesse più forte ambirebbe di nuovo a dominare con la violenza, e il giuoco si ripeterebbe senza fine. La comunità deve essere
mantenuta permanentemente, organizzarsi, prescrivere gli statuti che prevengano le temute ribellioni, istituire organi che veglino sull’osservanza delle prescrizioni - le leggi - e che provvedano
all’esecuzione degli atti di violenza conformi alle leggi. Nel riconoscimento di una tale comunione di interessi s’instaurano tra i membri di un gruppo umano coeso quei legami emotivi, quei
sentimenti comunitari sui quali si fonda la vera forza del gruppo.
Con ciò, penso, tutto l’essenziale è gia stato detto: il trionfo sulla violenza mediante la trasmissione del potere a una comunità più vasta che viene tenuta insieme dai legami emotivi tra i suoi
membri. Tutto il resto sono precisazioni e ripetizioni.
La cosa è semplice finché la comunità consiste solo di un certo numero di individui ugualmente forti. Le leggi di questo sodalizio determinano allora fino a che punto debba essere limitata la
libertà di ogni individuo di usare la sua forza in modo violento, al fine di rendere possibile una vita collettiva sicura. Ma un tale stato di pace è pensabile solo teoricamente, nella realtà le
circostanze si complicano perché la comunità fin dall’inizio comprende elementi di forza ineguale, uomini e donne, genitori e figli, e ben presto, in conseguenza della guerra e
dell’assoggettamento, vincitori e vinti, che si trasformano in padroni e schiavi. Il diritto della comunità diviene allora espressione dei rapporti di forza ineguali all’interno di essa, le leggi
vengono fatte da e per quelli che comandano e concedono scarsi diritti a quelli che sono stati assoggettati. Da allora in poi vi sono nella comunità due fonti d’inquietudine - ma anche di
perfezionamento - del diritto. In primo luogo il tentativo di questo o quel signore di ergersi al di sopra delle restrizioni valide per tutti, per tornare dunque dal regno del diritto a quello
della violenza; in secondo luogo gli sforzi costanti dei sudditi per procurarsi più potere e per vedere riconosciuti dalla legge questi mutamenti, dunque, al contrario, per inoltrarsi dal diritto
ineguale verso il diritto uguale per tutti. Questo movimento in avanti diviene particolarmente notevole quando si danno effettivi spostamenti dei rapporti di potere all’interno della
collettività, come può accadere per l’azione di molteplici fattori storici. Il diritto si può allora conformare gradualmente ai nuovi rapporti di potere, oppure, cosa che accade più spesso, la
classe dominante non è pronta a tener conto di questo cambiamento, si giunge all’insurrezione, alla guerra civile, dunque a una temporanea soppressione del diritto e a nuove testimonianze di
violenza, in seguito alle quali viene instaurato un nuovo ordinamento giuridico. C’è anche un’altra fonte di mutamento del diritto, che si manifesta solo in modi pacifici, cioè la trasformazione
dei membri di una collettività, ma essa appartiene a un contesto che può essere preso in considerazione solo più avanti.
Vediamo dunque che anche all’interno di una collettività non può venire evitata la risoluzione violenta dei conflitti. Ma le necessità e le coincidenze di interessi che derivano dalla vita in
comune sulla medesima terra favoriscono una rapida conclusione di tali lotte, e le probabilità che in queste condizioni si giunga a soluzioni pacifiche sono in continuo aumento. Uno sguardo alla
storia dell’umanità ci mostra tuttavia una serie ininterrotta di conflitti tra una collettività e una o più altre, tra unità più o meno vaste, città, paesi, tribù, popoli, Stati, conflitti che
vengono decisi quasi sempre mediante la prova di forza della guerra. Tali guerre si risolvono o in saccheggio o in completa sottomissione, conquista dell’una parte ad opera dell’altra. Non si
possono giudicare univocamente le guerre di conquista. Alcune, come quelle dei Mongoli e dei Turchi, hanno arrecato solo calamità, altre al contrario hanno contribuito alla trasformazione della
violenza in diritto avendo prodotto unità più grandi, al cui interno la possibilità di ricorrere alla violenza venne annullata e un nuovo ordinamento giuridico riuscì a comporre i conflitti. Così
le conquiste dei Romani diedero ai paesi mediterranei la preziosa pax romana. La cupidigia dei re francesi di ingrandire i loro possedimenti creò una Francia pacificamente unita, fiorente. Per
quanto ciò possa sembrare paradossale, si deve tuttavia ammettere che la guerra non sarebbe un mezzo inadatto alla costruzione dell’agognata pace “eterna”, poiché potrebbe riuscire a creare
quelle più vaste unità al cui interno un forte potere centrale rende impossibili ulteriori guerre. Tuttavia la guerra non ottiene questo risultato perché i successi della conquista di regola non
sono durevoli; le unità appena create si disintegrano, perlopiù a causa della insufficiente coesione delle parti unite forzatamente. E inoltre la conquista ha potuto fino ad oggi creare soltanto
unificazioni parziali, anche se di grande estensione, e sono proprio i conflitti sorti all’interno di queste unificazioni che hanno reso inevitabile il ricorso alla violenza. Così l’unica
conseguenza di tutti questi sforzi bellici è che l’umanità ha sostituito alle continue guerricciole le grandi guerre, tanto più devastatrici quanto meno frequenti.
Per quanto riguarda la nostra epoca, si impone la medesima conclusione a cui Lei è giunto per una via più breve. Una prevenzione sicura della guerra è possibile solo se gli uomini si accordano
per costituire un’autorità centrale, al cui verdetto vengano deferiti tutti i conflitti di interessi. Sono qui chiaramente racchiuse due esigenze diverse: quella di creare una simile Corte
suprema, e quella di assicurarle il potere che le abbisogna. La prima senza la seconda non gioverebbe a nulla. Ora la Società delle Nazioni è stata concepita come suprema potestà del genere, ma
la seconda condizione non è stata adempiuta; la Società delle Nazioni non dispone di forza propria e può averne una solo se i membri della nuova associazione - i singoli Stati - gliela concedono.
Tuttavia per il momento ci sono scarse probabilità che ciò avvenga. Ci sfuggirebbe il significato di un’istituzione come quella della Società delle Nazioni, se ignorassimo il fatto che qui ci
troviamo di fronte a un tentativo coraggioso, raramente intrapreso nella storia dell’umanità e forse mai in questa misura. Essa è il tentativo di acquisire mediante il richiamo a determinati
princìpi ideali l’autorità (cioè l’influenza coercitiva) che di solito si basa sul possesso della forza. Abbiamo visto che gli elementi che tengono insieme una comunità sono due: la coercizione
violenta e i legami emotivi tra i suoi membri (ossia, in termini tecnici, quelle che si chiamano identificazioni). Nel caso in cui venga a mancare uno dei due fattori non è escluso che l’altro
possa tener unita la comunità. Le idee cui ci si appella hanno naturalmente un significato solo se esprimono importanti elementi comuni ai membri di una determinata comunità. Sorge poi il
problema: Che forza si può attribuire a queste idee? La storia insegna che una certa funzione l’hanno pur svolta. L’idea panellenica, per esempio, la coscienza di essere qualche cosa di meglio
che i barbari confinanti, idea che trovò così potente espressione nelle anfizionie, negli oracoli e nei Giuochi, fu abbastanza forte per mitigare i costumi nella conduzione della guerra fra i
Greci, ma ovviamente non fu in grado di impedire il ricorso alle armi fra le diverse componenti del popolo ellenico, e neppure fu mai in grado di trattenere una città o una federazione di città
dallo stringere alleanza con il nemico persiano per abbattere un rivale. Parimenti il sentimento che accomunava i Cristiani, che pure fu abbastanza potente, non impedì durante il Rinascimento a
Stati cristiani grandi e piccoli di sollecitare l’aiuto del Sultano nelle loro guerre intestine. Anche nella nostra epoca non vi è alcuna idea cui si possa attribuire un’autorità unificante del
genere. È fin troppo chiaro che gli ideali nazionali da cui oggi i popoli sono dominati spingono in tutt’altra direzione. C’è chi predice che soltanto la penetrazione universale del modo di
pensare bolscevico potrà mettere fine alle guerre, ma in ogni caso siamo oggi ben lontani da tale meta, che forse sarà raggiungibile solo a prezzo di spaventose guerre civili. Sembra dunque che
il tentativo di sostituire la forza reale con la forza delle idee sia per il momento votato all’insuccesso. È un errore di calcolo non considerare il fatto che il diritto originariamente era
violenza bruta e che esso ancor oggi non può fare a meno di ricorrere alla violenza.
Posso ora procedere a commentare un’altra delle Sue proposizioni. Lei si meraviglia che sia tanto facile infiammare gli uomini alla guerra, e presume che in loro ci sia effettivamente qualcosa,
una pulsione all’odio e alla distruzione, che è pronta ad accogliere un’istigazione siffatta. Di nuovo non posso far altro che convenire senza riserve con Lei. Noi crediamo all’esistenza di tale
istinto e negli ultimi anni abbiamo appunto tentato di studiare le sue manifestazioni. Mi consente, in proposito, di esporLe parte della teoria delle pulsioni cui siamo giunti nella psicoanalisi
dopo molti passi falsi e molte esitazioni?
Noi presumiamo che le pulsioni dell’uomo siano soltanto di due specie, quelle che tendono a conservare e a unire - da noi chiamate sia erotiche (esattamente nel senso di Eros nel Convivio di
Platone) sia sessuali, estendendo intenzionalmente il concetto popolare di sessualità, - e quelle che tendono a distruggere e a uccidere; queste ultime le comprendiamo tutte nella denominazione
di pulsione aggressiva o distruttiva.
Lei vede che propriamente si tratta soltanto della dilucidazione teorica della contrapposizione tra amore e odio, universalmente nota, e che forse è originariamente connessa con la polarità di
attrazione e repulsione che interviene anche nel Suo campo di studi. Non ci chieda ora di passare troppo rapidamente ai valori di bene e di male. Tutte e due le pulsioni sono parimenti
indispensabili, perché i fenomeni della vita dipendono dal loro concorso e dal loro contrasto. Ora, sembra che quasi mai una pulsione di un tipo possa agire isolatamente, essa è sempre legata -
vincolata, come noi diciamo - con un certo ammontare della controparte, che ne modifica la meta o, talvolta, solo così ne permette il raggiungimento. Per esempio, la pulsione di autoconservazione
è certamente esotica, ma ciò non toglie che debba ricorrere all’aggressività per compiere quanto si ripromette. Allo stesso modo la pulsione amorosa, rivolta a oggetti, necessita un quid della
pulsione di appropriazione, se veramente vuole impadronirsi del suo oggetto. La difficoltà di isolare le due specie di pulsioni nelle loro manifestazioni ci ha impedito per tanto tempo di
riconoscerle.
Se Lei è disposto a proseguire con me ancora un poco, vedrà che le azioni umane rivelano anche una complicazione di altro genere. E’ assai raro che l’azione sia opera di un singolo moto
pulsionale, il quale d’altronde deve essere già una combinazione di Eros e distruzione. Di regola devono concorrere parecchi motivi similmente strutturati per rendere possibile l’azione. Uno dei
Suoi colleghi l’aveva già avvertito, un certo professor G. C. Lichtenberg, che insegnava fisica a Gottinga al tempo dei nostri classici; ma forse egli era anche più notevole come psicologo di
quel che fosse come fisico. Egli scoprì la rosa dei moventi, nell’atto in cui dichiarò: “I motivi per i quali si agisce si potrebbero ripartire come i trentadue venti e indicarli con nomi
analoghi, per esempio ‘Pane-Pane-Fama’ o ‘Fama-Fama-Pane’.” Pertanto, quando gli uomini vengono incitati alla guerra, è possibile che si destino in loro un’intera serie di motivi consenzienti,
nobili e volgari, quelli di cui si parla apertamente e altri che vengono taciuti. Non è il caso di enumerarli tutti. Il piacere di aggredire e distruggere ne fa certamente parte; innumerevoli
crudeltà della storia e della vita quotidiana confermano la loro esistenza e la loro forza. Il fatto che questi impulsi distruttivi siano mescolati con altri impulsi, erotici e ideali, facilita
naturalmente il loro soddisfacimento. Talvolta, quando sentiamo parlare delle atrocità della storia, abbiamo l’impressione che i motivi ideali siano serviti da paravento alle brame di
distruzione; altre volte, trattandosi per esempio crudeltà della Santa Inquisizione, che i motivi ideali fossero preminenti nella coscienza, mentre i motivi distruttivi recassero loro un
rafforzamento inconscio. Entrambi i casi sono possibili.
Ho qualche scrupolo ad abusare del Suo interesse, che si rivolge alla prevenzione della guerra e non alle nostre teorie. Tuttavia vorrei intrattenermi ancora un attimo sulla nostra pulsione
distruttiva, meno nota di quanto richiederebbe la sua importanza. Con un po’ di speculazione ci siamo convinti che essa opera in ogni essere vivente e che la sua aspirazione è di portarlo alla
rovina, di ricondurre la vita allo stato della materia inanimata. Con tutta serietà le si addice il nome di pulsione di morte, mentre le pulsioni erotiche stanno a rappresentare gli sforzi verso
la vita. La pulsione di morte diventa pulsione distruttiva allorquando, con l’aiuto di certi organi, si rivolge all’esterno, verso gli oggetti. L’essere vivente protegge, per così dire, la
propria vita distruggendone una estranea. Una parte della pulsione di morte, tuttavia, rimane attiva all’interno dell’essere vivente e noi abbiamo tentato di derivare tutta una serie di fenomeni
normali e patologici da questa interiorizzazione della pulsione distruttiva. Siamo perfino giunti all’eresia di spiegare l’origine della nostra coscienza morale con questo rivolgersi
dell’aggressività verso l’interno. Noti che non è affatto indifferente se questo processo è spinto troppo oltre in modo diretto; in questo caso è certamente malsano. Invece il volgersi di queste
forze pulsionali alla distruzione nel mondo esterno scarica l’essere vivente e non può non avere un effetto benefico. Ciò serve come scusa biologica a tutti gli impulsi esecrabili e pericolosi
contro i quali noi combattiamo. Si deve ammettere che essi sono più vicini alla natura di quanto lo sia la resistenza con cui li contrastiamo e di cui ancora dobbiamo trovare una spiegazione.
Forse Lei ha l’impressione che le nostre teorie siano una specie di mitologia, in questo caso neppure festosa. Ma non approda forse ogni scienza naturale in una sorta di mitologia? Non è così
oggi anche per Lei, nel campo della fisica?
Per gli scopi immediati che ci siamo proposti da quanto precede ricaviamo la conclusione che non c’è speranza di poter sopprimere le tendenze aggressive degli uomini. Si dice che in contrade
felici, dove la natura offre a profusione tutto ciò di cui l’uomo ha bisogno, ci sono popoli la cui vita scorre nella mitezza. presso cui la coercizione e l’aggressione sono sconosciute. Posso a
malapena crederci; mi piacerebbe saperne di più, su questi popoli felici. Anche i bolscevichi sperano di riuscire a far scomparire l’aggressività umana, garantendo il soddisfacimento dei bisogni
materiali e stabilendo l’uguaglianza sotto tutti gli altri aspetti tra i membri della comunità. Io la ritengo un’illusione. Intanto, essi sono diligentemente armati, e fra i modi con cui tengono
uniti i loro seguaci non ultimo è il ricorso all’odio contro tutti gli stranieri. D’altronde non si tratta, come Lei stesso osserva, di abolire completamente l’aggressività umana; si può cercare
di deviarla al punto che non debba trovare espressione nella guerra.
Partendo dalla nostra dottrina mitologica delle pulsioni, giungiamo facilmente a una formula per definire le vie indirette di lotta alla guerra. Se la propensione alla guerra è un prodotto della
pulsione distruttiva, contro di essa è ovvio ricorrere all’antagonista di questa pulsione: l’Eros. Tutto ciò che fa sorgere legami emotivi tra gli uomini deve agire contro la guerra. Questi
legami possono essere di due tipi. In primo luogo relazioni che pur essendo prive di meta sessuale assomiglino a quelle che si hanno con un oggetto d’amore. La psicoanalisi non ha bisogno di
vergognarsi se qui parla di amore, perché la religione dice la stessa cosa: “ama il prossimo tuo come te stesso”.
Ora, questo è un precetto facile da esigere, ma difficile da attuare. L’altro tipo di legame emotivo è quello per identificazione. Tutto ciò che provoca solidarietà significative tra gli uomini
risveglia sentimenti comuni di questo genere, le identificazioni. Su di esse riposa in buona parte l’assetto della società umana.
L’abuso di autorità da Lei lamentato mi suggerisce un secondo metodo per combattere indirettamente la tendenza alla guerra. Fa parte dell’innata e ineliminabile diseguaglianza tra gli uomini la
loro distinzione in capi e seguaci. Questi ultimi sono la stragrande maggioranza, hanno bisogno di un’autorità che prenda decisioni per loro, alla quale perlopiù si sottomettono
incondizionatamente. Richiamandosi a questa realtà, si dovrebbero dedicare maggiori cure, più di quanto si sia fatto finora all’educazione di una categoria superiore di persone dotate di
indipendenza di pensiero, inaccessibili alle intimidazioni e cultrici della verità, alle quali dovrebbe spettare la guida delle masse prive di autonomia. Che le intrusioni del potere statale e la
proibizione di pensare sancita dalla Chiesa non siano favorevoli ad allevare cittadini simili non ha bisogno di dimostrazione. La condizione ideale sarebbe naturalmente una comunità umana che
avesse assoggettato la sua vita pulsionale alla dittatura della ragione. Nient’altro potrebbe produrre un’unione tra gli uomini così perfetta e così tenace, perfino in assenza di reciproci legami
emotivi. Ma secondo ogni probabilità questa è una speranza utopistica. Le altre vie per impedire indirettamente la guerra sono certo più praticabili, ma non promettono alcun rapido successo. E’
triste pensare a mulini che macinano talmente adagio che la gente muore di fame prima di ricevere la farina.
Vede che, quando si consulta il teorico estraneo al mondo per compiti pratici urgenti, non ne vien fuori molto. E’ meglio se in ciascun caso particolare si cerca di affrontare il pericolo con i
mezzi che sono a portata di mano. Vorrei tuttavia trattare ancora un problema, che nel Suo scritto Lei non solleva e che m’interessa particolarmente. Perché ci indigniamo tanto contro la guerra,
Lei e io e tanti altri, perché non la prendiamo come una delle molte e penose calamità della vita? La guerra sembra conforme alla natura, pienamente giustificata biologicamente, in pratica assai
poco evitabile. Non inorridisca perché pongo la domanda. Al fine di compiere un’indagine come questa è forse lecito fingere un distacco di cui in realtà non si dispone. La risposta è: perché ogni
uomo ha diritto alla propria vita, perché la guerra annienta vite umane piene di promesse, pone i singoli individui in condizioni che li disonorano, li costringe, contro la propria volontà, a
uccidere altri individui, distrugge preziosi valori materiali, prodotto del lavoro umano, e altre cose ancora. Inoltre la guerra nella sua forma attuale non dà più alcuna opportunità di attuare
l’antico ideale eroico, e la guerra di domani, a causa del perfezionamento dei mezzi di distruzione, significherebbe lo sterminio di uno o forse di entrambi i contendenti. Tutto ciò è vero e
sembra così incontestabile che ci meravigliamo soltanto che il ricorso alla guerra non sia stato ancora ripudiato mediante un accordo generale dell’umanità. Qualcuno dei punti qui enumerati può
evidentemente essere discusso: ci si può chiedere se la comunità non debba anch’essa avere un diritto sulla vita del singolo; non si possono condannare nella stessa misura tutti i tipi di guerra;
finché esistono stati e nazioni pronti ad annientare senza pietà altri stati e altre nazioni, questi sono necessitati a prepararsi alla guerra. Ma noi vogliamo sorvolare rapidamente su tutto ciò,
giacché non è questa la discussione a cui Lei mi ha impegnato. Ho in mente qualcos’altro, credo che la ragione principale per cui ci indigniamo contro la guerra è che non possiamo fare a meno di
farlo. Siamo pacifisti perché dobbiamo esserlo per ragioni organiche: ci è poi facile giustificare il nostro atteggiamento con argomentazioni.
So di dovermi spiegare, altrimenti non sarò capito. Ecco quello che voglio dire: Da tempi immemorabili l’umanità è soggetta al processo dell’incivilimento (altri, lo so, chiamano più volentieri
questo processo: civilizzazione). Dobbiamo ad esso il meglio di ciò che siamo divenuti e buona parte di ciò di cui soffriamo.
Le sue cause e origini sono oscure, il suo esito incerto, alcuni dei suoi caratteri facilmente visibili. Forse porta all’estinzione del genere umano, giacché in più di una guisa pregiudica la
funzione sessuale, e già oggi si moltiplicano in proporzioni più forti le razze incolte e gli strati arretrati della popolazione che non quelli altamente coltivati. Forse questo processo si può
paragonare all’addomesticamento di certe specie animali; senza dubbio comporta modificazioni fisiche; tuttavia non ci si è ancora familiarizzati con l’idea che l’incivilimento sia un processo
organico di tale natura. Le modificazioni psichiche che intervengono con l’incivilimento sono invece vistose e per nulla equivoche. Esse consistono in uno spostamento progressivo delle mete
pulsiona!i. Sensazioni che per i nostri progenitori erano cariche di piacere, sono diventate per noi indifferenti o addirittura intollerabili; esistono fondamenti organici del fatto che le nostre
esigenze ideali, sia etiche che estetiche, sono mutate. Dei caratteri psicologici della civiltà, due sembrano i più importanti: il rafforzamento dell’intelletto, che comincia a dominare la vita
pulsionale, e l’interiorizzazione dell’aggressività, con tutti i vantaggi e i pericoli che ne conseguono. Orbene, poiché la guerra contraddice nel modo più stridente a tutto l’atteggiamento
psichico che ci è imposto dal processo civile, dobbiamo necessariamente ribellarci contro di essa: semplicemente non la sopportiamo più; non si tratta soltanto di un rifiuto intellettuale e
affettivo, per noi pacifisti si tratta di un’intolleranza costituzionale, per così dire della massima idiosincrasia. E mi sembra che le degradazioni estetiche della guerra non abbiano nel nostro
rifiuto una parte molto minore delle sue crudeltà.
Quanto dovremo aspettare perché anche gli altri diventino pacifisti? Non si può dirlo, ma forse non è una speranza utopistica che l’influsso di due fattori - un atteggiamento più civile e il
giustificato timore degli effetti di una guerra futura - ponga fine alle guerre in un prossimo avvenire. Per quali vie dirette o traverse non possiamo indovinarlo. Nel frattempo possiamo dirci:
tutto ciò che promuove l’evoluzione civile lavora anche contro la guerra.
La saluto cordialmente e Le chiedo scusa se le mie osservazioni L’hanno delusa.
Suo Sigm. Freud
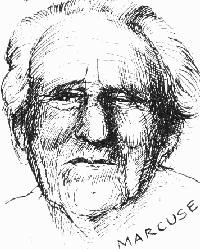
HERBERT MARCUSE - "Eros e civiltà"
"Ora si può riformulare il problema del lavoro, dell'attività socialmente utile, senza sublimazione (repressiva). Esso si presentò come il problema di un cambiamento del carattere del lavoro, in virtù del quale il lavoro diverrebbe simile al gioco - libero gioco di facoltà umane. Quali sono i presupposti istintuali di una siffatta trasformazione? (...)
Il gioco sottostà in pieno al principio del piacere. il piacere sta nel movimento stesso in quanto esso attiva zone erogene. "Il tratto fondamentale del gioco sta nel fatto che esso è soddisfacente in se stesso, senza servire ad altri scopi oltre a quello della soddisfazione dell'istinto" ...D'altro lato il lavoro serve a fini che sono all'infuori del lavoro stesso - e cioè a fini di autoconservazione. "Lavorare significa lo sforzo attivo dell'Io .. di ottenere dal mondo esterno tutto quanto è necessario all'autoconservazione". Questo contrasto crea un parallelismo tra l'organizzazione degli istinti e quella dell'attività umana: "Il gioco è fine a se stesso, il lavoro è in funzione dell'autoconservazione...
Quindi è lo scopo e non il contenuto che stabilisce se un'attività è gioco o lavoro.
(...)
Tutto il progresso tecnico, la conquista della natura, la razionalizzazione dell'uomo e della società, non hanno eliminato né possono eliminare la necessità del lavro alienato, del lavoro meccanico, spiacevole, tale da non rappresentare una autorealizzazione individuale.
Ma la stessa alienazione progressiva aumenta il potenziale di libertà: quanto più l'individuo rimane esterno al lavoro necessario, tanto meno è coinvolto nel regno della necessità. Liberata dalle esigenze del dominio, la riduzione quantitativa del tempo lavorativo e delle energie lavorative porta a un cambiamento qualitativo dell'esistenza umana: le ore libere più che le ore lavorative determinano il suo contenuto. Il regno della libertà, espandendosi sempre più, diventa veramente il regno del gioco - del libero gioco di facoltà individuali. Così liberate, esse genereranno nuove forme di realizzazione e di scoperta del mondo, e queste a loro volta daranno una nuova forma al regno della necessità, alla lotta per l'esistenza. Il rapporto modificato tra i due regni della realtà umana, modifica il rapporto tra ciò che è desiderabile e ciò che è ragionevole, tra istinto e ragione. Con la trasformazione di sessualità in eros, gli istinti di vita evolvono il loro ordine sensuale, mentre la ragione si fa sensuale fino al punto da comprendere in sé e arricchire gli istinti di vita".
Da "Eros e civiltà", Einaudi Torino 1999 pp.229 e 236-237
"Prolunghiamo artificiosamente la vita, negli attuali centri di terapia intensiva e negli ospedali geriatrici favoriamo il prolungamento vegetativo della vita allontanando, ritardando la morte naturale in un modo che può apparire come una sorta di tormento di Sisifo, in un senso forse più profondo. Noi, cioè, ci spegniamo lentamente, e nel nostro spegnerci siamo solo esistenze vegetative. Per il modo in cui le nostre possibilità tecniche ci mantengono in vita, Sisifo ha acquisito un nuovo significato simbolico. Noi tutti probabilmente dobbiamo continuamente imparare che morire è anche un momento di apprendimento, non è solo la caduta in uno stato di incoscienza".
HANS GEORG GADAMER - "IL FILOSOFO E LA MORTE".
FRIEDRICH NIETZSCHE - Brano tratto da Genealogia della morale
"Considero la cattiva coscienza (1) come la grave malattia cui l’uomo doveva soccombere, sotto la spinta della più profonda di tutte le mutazioni (2)… Una cosa simile deve essere capitata agli animali acquatici (3), quando furono costretti a trasformarsi in animali terrestri o a morire, e così anche questi semianimali (4), felicemente adattati alla vita selvaggia, alla guerra, al nomadismo, all’avventura – all’improvviso videro tutti i loro istinti svalutati e “scardinati” (5). Dovettero allora camminare sulle gambe e “sorreggersi”, mentre prima erano stati portati dall’acqua: una pesantezza tremenda li affliggeva. Si sentivano incapaci delle operazioni più elementari; per questo mondo nuovo e sconosciuto non possedevano più le loro antiche guide, gli istinti regolatori, inconsciamente incapaci di fallire – erano ridotti, poveri infelici, a pensare (6), a dedurre, a calcolare cause ed effetti, ridotti alla loro “coscienza”, al più miserevole e ingannevole dei loro organi (7)!
Credo che mai sulla terra ci sia stato un tal senso di miseria, un tal plumbeo disagio – mentre quegli istinti non avevano certo cessato improvvisamente di manifestare le loro esigenze! Solo che soddisfarle era difficile e solo raramente possibile: in sostanza essi dovettero trovarsi nuove e quasi sotterranee soddisfazioni. Tutti gli istinti che non si scaricano all’esterno si rivolgono all’interno – questa è quella che chiamo interiorizzazione (8) dell’uomo: solo così si sviluppa nell’uomo quella cosa che più tardi riceverà il nome di anima… Quei bastioni (9) terribili con cui l’organizzazione statale si proteggerà contro gli antichi istinti della libertà – le pene – fecero sì che tutti quegli istinti dell’uomo libero e randagio, regredendo, si rivoltassero contro l’uomo stesso.
L’inimicizia, la crudeltà, il piacere della persecuzione, dell’attacco, delle mutazioni, della distruzione – tutto quello che si rivolta contro i possessori di tali istinti: questa è l’origine della “cattiva coscienza”.
L’uomo che, in mancanza di nemici esterni e resistenze, costretto nelle oppressive strettoie e regolarità di costumi (10), dilaniava impaziente se stesso, si perseguitava, si torturava, si punzecchiava, si maltrattava, questo animale che si butta contro le sbarre della sua gabbia ferendosi, che vogliono domare, questo essere privato di qualcosa … questo dissennato, questo prigioniero disperato e sitibondo (11) di desiderio, diventò l’inventore della cattiva coscienza. Con ciò, però, si aprì la strada alla più grave e oscura malattia da cui, sino ad oggi, l’umanità non è guarita (12)”.
1. L’uomo evoluto ha dovuto inventare un meccanismo di controllo degli istinti, la “cattiva coscienza”, ponendo così le condizioni della sua perenne infelicità.
2. La mutazione è l’evoluzione delle società umane, che si servono della morale come strumento di dominio.
3. L’evoluzione delle specie animali ha seguito il seguente ordine: pesci – anfibi – rettili. Da questi ultimi sono derivati sia gli uccelli che i mammiferi.
4. I semianimali sono gli esseri viventi che non si erano ancora adattati alla vita terrestre e conservavano alcune abitudini acquatiche.
5. A differenza degli animali da cui deriva, l’uomo, lasciato il regno dell’acqua, nel nuovo mondo non è più guidato dagli istinti della corporeità, ma dalle regole della ragione: è costretto a pensare. Unico fra tutti gli animali, l’uomo nega il suo passato di animale, ma rinuncia anche alla felicità, essendosi ridotto a contare solo sulla coscienza.
6. Non potendo contare sugli istinti, gli uomini dovettero usare un’altra facoltà, la ragione, che finì per sconfiggere gli istinti.
7. La coscienza, nata dalla repressione degli istinti, è un fallimento della selezione e dell’evoluzione, è l’organo meno efficace dell’uomo.
8. L’interiorizzazione è il meccanismo di compensazione all’inibizione degli istinti, che ha portato alla formazione dell’anima.
9. La società ebbe bisogno di bastioni per mantenere in vita le sue norme e istituì sanzioni e pene per i trasgressori. Per paura delle punizioni l’uomo regredì e impedì agli istinti di scaricarsi all’esterno; così essi si rivoltarono contro di lui.
10. In mancanza di nemici esterni contro i quali scaricare i suoi istinti, costretto a rispettare norme e costumi, l’uomo pagò il suo conformismo con un’aggressività introiettata e rivolta contro di sé. Facendosi del male reciprocamente, gli uomini inventarono la “coscienza” come meccanismo facilitatore del controllo.
11. Assetato.
12. Negando il suo passato animale, l’uomo ha perduto il piacere di vivere, la forza e la temibilità: è divenuto debole, infelice e fragile. La malattia dell’uomo moderno è la vergogna: l’uomo si vergogna dei suoi istinti e si sforza di apparire un essere razionale, ma è diventato un essere privo di vitalità.
ERICH FROMM: Avere o Essere?
La modalità dell’essere ha, come prerequisiti, l’indipendenza, la libertà e la presenza della ragione critica. La sua caratteristica fondamentale consiste nell’essere attivo, che non va inteso nel senso di un’attività esterna, nell’essere indaffarati, ma di un’attività interna, di uso produttivo dei nostri poteri umani. Essere attivi significa dare espressione alle proprie facoltà e capacità, alle molteplicità di doti che ogni essere umano possiede, sia pure in vario grado. Significa rinnovarsi, crescere, espandersi, amare, trascendere il carcere del proprio io isolato, essere interessato, “prestare attenzione”, dare. Solo se noi limitiamo la modalità dell’avere, vale a dire del non essere (cioè quella che consiste nel cercare sicurezza e identità aggrappandoci a quanto abbiamo, per così dire standogli seduti sopra, avvinghiandoci al nostro io e ai nostri possessi), la modalità dell’essere può emergere. “Essere” significa rinunciare al proprio egocentrismo ed egoismo, ovvero, per usare le parole che spesso ricorrono nei mistici, nel rendersi “vuoti” e poveri”. Per la maggior parte di noi, tuttavia, rinunciare all’atteggiamento dell’avere risulta troppo difficile e ogni tentativo in questo senso ha per effetto di determinare l’insorgere di uno stato di intensa ansia, la sensazione di abbandonare ogni sicurezza, di essere scagliati nell’oceano senza saper nuotare. Chi si trovi in questa condizione ignora che, una volta gettata via la stampella della proprietà, può finalmente cominciare a servirsi delle sue proprie forze, a camminare con le sue gambe. A trattenerlo è l’illusione che non è in grado di camminare da solo, la paura di crollare qualora non sia più sostenuto dalle cose che possiede.
Gli individui che fanno propria la modalità dell’avere godono della sicurezza ma sono, per forza di cose, assai insicuri. Dipendono da ciò che hanno: denaro, prestigio, il loro io - in altre parole da qualcosa che è al di fuori di loro. Ma che ne è di loro se perdono ciò che hanno? Qualsiasi cosa si ha può essere perduta e ciò vale soprattutto per le proprietà oltre che per la posizione sociale e gli amici; senza contare che in ogni momento si può perdere la propria vita. Se "sono ciò che ho" e ciò che ho è perduto, chi sono io? Null’altro che uno sconfitto, frustrato, patetico testimone di un modo di vivere errato. Dato che posso perdere ciò che ho sono sempre preda della preoccupazione di restare privo di ciò che possiedo. Ho paura dei ladri, dei mutamenti economici, temo le rivoluzioni, le malattie, la morte, mi sgomentano la libertà, l’amore, la crescita, il mutamento, l’ignoto. Sono continuamente preoccupato in preda ad una cronica ipocondria relativa non solo alla perdita di salute ma ogni altra perdita di ciò che ho; sto pertanto sulla difensiva, mi mostro duro, sospettoso, sono solitario, mosso dal bisogno di avere di più per essere meglio protetto. L’ansia e l’insicurezza prodotte dal pericolo di perdere ciò che ho sono assenti dalla modalità dell’essere. Se "se sono ciò che sono" e non “ciò che ho”, nessuno può privarmi né della mia sicurezza né del mio senso di identità e neppure minacciare di farlo. Il mio centro è dentro di me; la mia capacità di essere e di esprimere i miei poteri essenziali è parte integrante della mia struttura caratteriale e da me dipende.
“Essere" libero anziché “avere" sicurezza genera angoscia in chi non ha il coraggio di affrontare l’ “avventura dell’essere”: costui è disposto a rinunciare alla propria libertà (Da Avere a Essere).
Non andare avanti, restare dove siamo, non progredire, accontentarci di quello che abbiamo è assai tentante, perché conosciamo ciò che abbiamo; a questo possiamo aggrapparci e ce ne viene un senso di sicurezza. Temiamo ed evitiamo di affrontare l’ignoto, l’incerto; perché - se non può apparire rischioso una volta che l’abbiamo fatto - prima di affrontare l’impresa i nuovi aspetti che si profilano al di là del passo iniziale appaiono imprevedibili, pericolosi e fonte di paura. Soltanto il vecchio, il comprovato, è sicuro; o così sembra. Ogni nuovo passo comporta il pericolo di un fallimento, ed è qui che va ricercato uno dei motivi per cui la gente ha tanta paura della libertà.
Le persone la cui vita è imperniata sull’avere desiderano “avere” la persona che apprezzano o ammirano e lo si constata facilmente nei rapporti tra genitori e figli, tra insegnanti e studenti, come pure tra amici. Il partner non si accontenta semplicemente di godere l'altra persona, ma desidera averla tutta per sé. Ciascuno è geloso di coloro che aspirano ad avere l'altro; ognuno dei partner cerca l'altro come un naufrago una tavola di salvezza: per sopravvivere. I rapporti basati sull'avere sono pesanti, ossessivi, gravidi di conflitti e gelosie. Gli elementi fondamentali tra individui che facciano propria la modalità dell'avere sono la competizione, l'antagonismo e la paura. Se l'avere è il fondamento del mio sentimento di identità perché "io sono ciò che ho", il desiderio di avere non può che condurre al desiderio di avere molto, di avere di più, di avere il massimo. L' avidità è la naturale conseguenza dell'orientamento dell'avere. Può trattarsi della brama dell'avaro come pure quella dello speculatore, ovvero del cacciatore di gonnelle o della mangiatrice di uomini. Quale che sia l'elemento costitutivo della loro brama, certo è che gli avidi non hanno mai abbastanza, non riescono mai a sentirsi soddisfatti. L'ingordigia mentale (avidità) non ha limite di sazietà, poiché il suo esaudimento non colma il vuoto interiore, la noia, il senso di solitudine, lo stato di depressione, che invece dovrebbe vincere. Dal momento che ciò che abbiamo ci può essere tolto in una forma o nell'altra, bisogna avere di più per rafforzare la propria esistenza di fronte a un pericolo del genere. Ma se ognuno aspira ad avere di più ne consegue che ognuno non può che temere le intenzioni aggressive del vicino a portargli via ciò che possiede e per prevenire attacchi del genere non resta che acquisire sempre maggiori poteri e far proprio un atteggiamento di aggressione preventiva. Dal momento che la produzione non può mai tenere il passo con desideri illimitati, non possono che esserci competitività e antagonismo tra i singoli impegnati in una lotta per assicurarsi il massimo.
(...)
La modalità esistenziale dell'avere, l'atteggiamento imperniato sulla proprietà e sul profitto, inevitabilmente producono il desiderio - anzi il bisogno - di potere. Per esercitare il controllo su altri esseri umani, dobbiamo far ricorso al potere per vincerne la resistenza. Per mantenere il controllo della proprietà privata dobbiamo servirci del potere per proteggerci da coloro che vorrebbero privarcene, perché questi, al pari di noi, non hanno né possono mai avere abbastanza; il desiderio di avere proprietà private produce il desiderio di usare la violenza allo scopo di depredare altri in maniera coperta o esplicita. Nella modalità dell'avere la propria felicità risiede nella superiorità sugli altri, nel proprio potere e nella capacità di conquistare, depredare, uccidere. Secondo la modalità dell'essere, la felicità consiste invece nell'amare, nel condividere, nel dare.
(...)
Viviamo in un mondo di "piaceri senza gioia". I piaceri degli edonisti, la soddisfazione di sempre nuove cupidigie, i piaceri della società industriale danno origine a diversi
gradi di euforia, ma non conducono alla gioia, anzi la mancanza di gioia rende necessaria la ricerca di piaceri sempre nuovi, sempre più eccitanti. Piacere ed eccitamento lasciano il posto alla tristezza una volta che sia stato raggiunto il cosiddetto culmine; perché, se l'eccitamento è stato sperimentato, non per questo il recipiente è cresciuto, non sono aumentati i poteri interiori dell'individuo, il quale ha compiuto il tentativo di far breccia nella noia dell'attività improduttiva e per un istante è riuscito a conglobare tutte le proprie energie, eccezion fatta per la ragione e l'amore; ha tentato di divenire un superuomo, senza neppure essere umano; in apparenza è riuscito ad ottenere un trionfo, seguito però da profonda tristezza: dentro di lui nulla è cambiato. Il detto "dopo il coito l'animale è triste" riflette questa situazione relativa al sesso senza amore, che è un'esperienza culminante di intensa eccitazione e quindi elettrizzante e piacevole, ma necessariamente seguita dalla delusione. La gioia del sesso può essere sperimentata solo qualora l'intimità fisica sia accompagnata dall'intimità amorosa. La gioia non è un'esperienza culminante che raggiunga improvvisamente l'apice e improvvisamente termini ma è uno stato emozionale che accompagna l'espressione delle proprie essenziali facoltà umane. La gioia è quanto sperimentiamo nel processo di avvicinamento all'obbiettivo costituito dal divenire noi stessi.
(...)
Indipendentemente dal fatto che siamo felici o infelici, il nostro organismo ci spinge ad aspirare all'immortalità, ma poiché sappiamo che moriremo andiamo alla ricerca di situazioni capaci di farci credere che, nonostante l'evidenza, siamo immortali. E' un desiderio che ha assunto molte forme: la credenza dei faraoni che i loro corpi rinchiusi nelle piramidi fossero immortali, le fantasie religiose di una vita dopo la morte, il paradiso cristiano e islamico. Nella società d'oggi la storia e il futuro hanno preso il posto del cielo cristiano: la fama, la celebrità, persino la cattiva nomea - insomma tutto ciò che sembra assicurare una nota a piè di pagina nel registro della storia - costituiscono un frammento di immortalità. L'aspirazione alla fama non è semplice vanità mondana: contiene in sé una qualità religiosa, agli occhi di coloro che non credono più nell'aldilà. Più di ogni altra cosa il possesso di proprietà costituisce la realizzazione del desiderio di immortalità.
(...)
Se il mio sé è costituito da ciò che ho, sono immortale se le cose che ho sono indistruttibili. Dall'antico Egitto a oggi - vale a dire dall'immortalità fisica (ottenuta con la mummificazione del corpo) all'immortalità legale (assicurata dal testamento) - la gente è sopravvissuta al di là della durata della propria esistenza fisica e mentale. Tramite il potere legale dell'ultima volontà, l'assegnazione delle nostre proprietà è prestabilita per le generazioni a venire; tramite le leggi che regolano l'eredità, in quanto sono proprietario di capitali, divengo immortale.
(...)
Nella modalità dell'avere la fede è il possesso di una risposta per la quale manca ogni prova razionale; essa consiste di formulazioni elaborate da altri, di solito una burocrazia. La risposta dà la sensazione di certezza causa del potere (effettivo o immaginario) della burocrazia. Essa rappresenta il biglietto d'ingresso per unirsi a un vasto gruppo e solleva chi ne è in possesso del gravoso compito di pensare da solo e di prendere decisioni. Si diventa dei beati possidentes, i felici detentori della vera felicità. Secondo la modalità dell'avere, questa conferisce certezza; proclama di fornire una conoscenza definitiva, incrollabile, credibile per il fatto che il potere di coloro che promulgano e diffondono la fede sembra anch'esso incrollabile. Chi non opterebbe per la certezza se tutto ciò che si richiede consiste nel rinunciare alla propria indipendenza?
(...)
Dio diviene, secondo la modalità dell'avere, un idolo. Un idolo è una cosa che noi stessi costruiamo e nella quale proiettiamo i nostri poteri, in tal modo impoverendoci. Così facendo ci assoggettiamo alla nostra creazione e con quest'atto di sottomissione ci mettiamo in contatto con noi stessi in forma alienata. Se posso avere l'idolo, a causa della mia sottomissione, l'idolo ha me. La fede secondo la modalità dell'avere è una stampella per chi desidera la certezza, per chi aspira ad avere una risposta al problema dell'esistenza senza osare cercarsela da solo. La fede secondo la modalità dell'essere non consiste in primo luogo nel credere in certe idee, ma è un orientamento intimo, un atteggiamento. Sarebbe meglio dire che una persona "è nella fede" invece che "ha fede". La fede che ripongo in me stesso, in un altro, nella specie umana, nella nostra capacità di assurgere a piena umanità implica certezza, ma una certezza che si fonda sulla mia propria esperienza, non sulla mia sottomissione ad una autorità che impone una certa credenza.
(...)
Durante il corteggiamento, nessuno dei due partner è ancora sicuro dell'altro: ciascuno di essi cerca di conquistare l'altro. Entrambi sono pieni di vitalità, attraenti, interessanti, persino belli, poiché la vitalità sempre rende bello un volto. Nessuno dei due ha l'altro; ne consegue che l'energia di ciascuno dei due è rivolta all'essere, vale a dire a cedere all'altro e a stimolarlo. In seguito al matrimonio, la situazione assai spesso cambia completamente. Il contratto matrimoniale conferisce a ciascun partner l'esclusivo possesso del corpo, dei sentimenti e dell'affetto dell'altro. Non occorre più conquistare nessuno, perché l'amore è diventato qualcosa che si ha, una proprietà. I due cessano di compiere lo sforzo di essere amabili e di produrre amore, e quindi divengono noiosi, e pertanto la loro bellezza scompare. Sono delusi e perplessi. Non sono forse più le stesse persone? Che abbiano commesso un errore iniziale? Di solito, ciascuno dei due cerca nell'altro la causa del mutamento e si sente defraudato. Ciò di cui non si rendono conto è che non sono più le stesse persone che erano quando si amavano a vicenda, e che l'errore per cui si può avere l'amore li ha condotti a cessare di amare. Adesso, invece di amarsi a vicenda, spostano l'interesse su ciò che hanno in comune: denaro, rango sociale, una casa, dei figli. E così accade che, in certi casi, il matrimonio, iniziato sulla base dell'amore, si trasformi in un amichevole possesso, una società in cui i due egotismi confluiscono in uno solo: quello della "famiglia".
THEODOR ADORNO - Sulla scrittura (Da Minima Moralia)
Lo scrittore si dispone nel proprio testo come a casa propria. Come crea confusione con i fogli, i libri, le matite e le cartelle che si porta dietro da una stanza all’altra, così fa anche, in un certo modo, coi suoi pensieri. Essi diventano, per lui, come mobili o suppellettili domestiche, su cui prende posto, si sente a proprio agio o, viceversa, va su tutte le furie. Li carezza delicatamente, li consuma, li mette a soqquadro, li sposta, li rovina. Per chi non ha più patria, anche e proprio lo scrivere può diventare una sorta di abitazione. E così facendo anche lui, come a suo tempo la famiglia, non può fare a ,meno di produrre rifiuti e scarti. Ma non ha più un ripostiglio dove metterli, e, in generale, è difficile separarsi dagli avanzi e dalle scorie. Così spinge i rimasugli davanti a sé e finisce per correre il rischi di riempire di essi le sue pagine. L’esigenza di indurirsi e di non indulgere alla pietà di se stessi comprende anche quella più tecnica di prevenire, con estrema cura, le cadute della tensione intellettuale e di eliminare tutto ciò che si viene a formare come un’incrostazione nel lavoro in corso, che continua a girare a vuoto, e che forse, in uno stadio antecedente, contribuiva a creare, come ciarla o pettegolezzo, la calda atmosfera in cui l’opera può crescere e svilupparsi, ma che ora non è più che un residuo muffito e un deposito stantio. Alla fine allo scrittore non è concesso di abitare nemmeno nello scrivere. THEODOR ADORNO (Da "Minima moralia")
EMILE DURKHEIM - L'anomia (Da "Il suicidio")
"E’ caratteristica dell’uomo essere soggetto a un freno non fisico, ma morale, cioè sociale. Egli non riceve la sua legge da un ambiente materale che s’impone
brutalmente, ma da una coscienza superiore alla sua e di cui sente la superiorità. Proprio perché la maggiore e migliore parte della sua vita trascende il corpo, egli sfugge al giogo del corpo
per subire quello della società.
Senonché, quando la società è scossa, sia per una crisi dolorosa che per improvvise, sebbene felici, trasformazioni, essa è provvisoriamente incapace di esercitare
questa azione. Da qui provengono quelle repentine ascese della curva dei suicidi di cui abbiamo già stabilito l’esistenza.
Nei casi di disastri economici si verifica infatti un declassamento che spinge certi individui in una situazione inferiore a quella occupata fino allora. Essi
debbono così diminuire le proprie esigenze, restringere i bisogni, imparare a contenersi di più. Per quanto li concerne tutti i frutti dell’azione sociale vanno perduti e la loro educazione
morale è da rifare. Ora, non è che la società possa piegarli in un attimo a questa nuova vita e subito insegnare a esercitare su se stessi un sovrappiù di costrizioni cui non sono avvezzi. Ne
consegue per loro una inidoneità alla condizione sopravvenuta di cui la semplice prospettiva è per essi quasi intollerabile. Da qui le sofferenze che li distaccano da una vita diminuita prima
ancora che ne abbiano fatto l’esperienza.
Né diversamente accade quando la crisi ha per origine un improvviso accrescimento di potenza e di fortuna. Anche in questo caso, mutate le condizioni di vita, la
scala su cui si regolavano i bisogni non può restare la stessa, ma deve variare con le risorse sociali, perché possa dterminare grosso modo la parte destinata ad ogni categoria di produttori. La
graduazione ne è rimasta sconvolta e non se ne può improvvisare un’altra seduta stante. Ci vuole un certo tempo perché uomini e cose siano nuovamente classificati per la coscienza pubblica.
Finché le forze sociali, così liberate, non ritrovino l’equilibrio, il loro valore rispettivo rimane indeterminato e, quindi, per un certo tempo, viene a difettare ogni disciplina. Non si sa più
ciò che è possibile e ciò che non lo è, ciò che è giusto e ciò che non è giusto, quali sono le rivendicazioni e le speranze legittime, quali quelle che vanno oltre la misura. Per poco profondo
che sia, questo sconvolgimento raggiunge anche i principi che presiedono alla ripartizione dei cittadini nei vari impieghi, perché come i rapporti tra le diverse parti della società ne sono
necessariamente modificati, anche le idee che esprimono quei rapporti non possono rimanere le stesse. Quella classe che la crisi ha favorita in modo speciale non è più disposta alla rassegnazione
e, di rimando, lo spettacolo della sua maggior fortuna le suscita attorno e dal basso ogni sorta di cupidigia. Così, non contenuti da un’opinione disorientata, gli appetiti non sanno più quali
siano i limiti da non superare. D’altra parte, proprio perché più intensa è la vitalità generale, essi sono in uno stato di naturale eretismo: con l’accrescersi della prosperità, i desideri si
sono esaltati. L’offerta di più ricca preda li stimola, li fa più esigenti, più insofferenti delle regole nel momento che le regole hanno perduto la loro autorità. Lo stato di non regolamento o
di anomia si rafforza dunque perché le passioni sono meno disciplinate proprio quando sono più bisognose di una forte disciplina.
Le stesse esigenze fanno sì che sia impossibile soddisfarle. Le ambizioni sovraeccitate vanno sempre oltre i risultati ottenuti, quali essi siano, perché non sono
consapevoli di non dover andare oltre. Nulla può accontentarle e l’agitazione si ricarica da sola, senza riuscire mai a placarsi. Lo sforzo si fa dunque più considerevole proprio nel momento più
improduttivo: in queste condizioni come potrebbe non venir meno la volontà di vivere?
La spiegazione è confermata dalla singolare immunità di cui godono i paesi poveri. Se la povertà protegge dal suicidio è segno che è di per sé un freno. Checché si
faccia, i desideri sono costretti, in certa misura, a fare i conti con i mezzi disponibili e ciò che si ha, serve in parte da punto di riferimento per determinare ciò che si vorrebbe. Pertanto,
meno si possiede meno si è portati ad allargare senza limiti la cerchia dei bisogni. L’impotenza, costringendoci alla moderazione, ci abitua ad essa senza contare che nulla può suscitare il
desiderio dove la mediocrità è generale. Invece la ricchezza coi poteri che conferisce ci dà l’illusione di far capo esclusivamente a noi stessi e diminuendo la resistenza che le cose ci
oppongono, ci induce a pensare che possono essere conquistate all’infinito. Meno ci si sente limitati, più insopportabile ci appare ogni limitazione. Non è senza ragione che tante religioni hanno
celebrato i benefici e il valore morale della povertà, che è, infatti, la migliore scuola per insegnare all’uomo a contenersi. Costringendoci ad esercitare su di noi una costante disciplina, essa
ci allena ad accettare docilmente la disciplina collettiva, mentre la ricchezza, esaltando l’individuo, rischia sempre di risvegliare quello spirito di ribellione che è la fonte stessa
dell’immoralità. Non è questa, certo, una ragione per impedire all’umanità di migliorare la sua condizione materiale. Ma se il pericolo mortale che ogni aumento di ricchezza comporta non è senza
rimedio, è anche necessario non perderlo di vista".
THEODOR ADORNO - Un test che riveli i veri amici
Parlar franco. C'è un criterio quasi infallibile per stabilire se un altro ti è veramente amico: il modo in cui riporta giudizi ostili o scortesi sulla tua persona. Questi ragguagli sono, per lo più, superflui, pretesti per lasciar trapelare la malevolenza senza assumerne la responsabilità, anzi in nome del bene. Come tutti quelli che si conoscono provano la tentazione di dir male - all'occasione - gli uni degli altri, anche per reazione contro la monotonia dei rapporti, così ciascuno è sensibilissimo alle opinioni di ogni altro e desidera segretamente di essere amato anche da chi non ama: non meno fatale e universale dell'alienazione tra gli uomini è il desiderio di spezzarla. In questa atmosfera prospera l'informatore, che non manca mai di materiale sgradevole e che può sempre contare sul fatto che chi vorrebbe che tutti gli volessero bene è sempre sul chi va là, ansioso di apprendere il contrario. Osservazioni sfavorevoli andrebbero riportate solo quando sono in gioco - in modo immediato e trasparente - decisioni comuni, la valutazione di uomini di cui ci si deve poter fidare e con cui si deve lavorare insieme. Quanto più disinteressata è l'informazione, tanto più torbido è l'interesse, il piacere segreto di recar dolore. E' un caso ancora relativamente innocuo, quando il relatore vuole semplicemente aizzare l'uno contro l'altro i due contraenti e - nello stesso tempo - mettere in luce le proprie qualità. Ma più sovente egli appare come il portavoce dell'opinione pubblica e lascia intendere alla vittima - proprio con la sua spassionata oggettività - tutta la violenza dell'ente anonimo di fronte al quale deve piegarsi. La menzogna è palese nell'inutile premura per l'onore dell'offeso che non sa nulla dell'offesa.
THEODOR WIESENGRUND ADORNO - "Minima moralia", Einaudi Torino 1994, pp. 211-212.
ANTONIO GRAMSCI - Senza il riferimento alle masse sociali, il concetto di libertà è vuoto
Se la storia è storia della libertà la formula è valida per la storia di tutto il genere umano di ogni tempo e di ogni luogo, è libertà anche la storia delle satrapie orientali. Libertà allora significa solo "movimento", svolgimento, dialettica. Anche la storia delle satrapie orientali è stata libertà, perché è stata movimento e svolgimento, tanto è vero che quelle satrapie sono crollate. Ancora: la storia è libertà in quanto è lotta tra libertà e autorità, tra rivoluzione e conservazione, lotta in cui la libertà e la rivoluzione continuamente prevalgono sull'autorità e la conservazione. Ma ogni corrente e ogni partito non sono in tal caso espressioni della libertà, movimenti dialettici del processo di libertà? Qual è dunque la caratteristica del secolo XIX in Europa? Non di essere storia della libertà, ma di essere storia della libertà consapevole di esser tale, nel secolo XIX in Europa esiste una coscienza critica prima non esistente, si fa la storia sapendo quello che si fa, sapendo che la storia è storia della libertà, ecc. (...)
ANTONIO GRAMSCI - Da Quaderni dal carcere. Il materialismo storico, Roma 1977 p. 240
 CULTURA & SVAGO
CULTURA & SVAGO